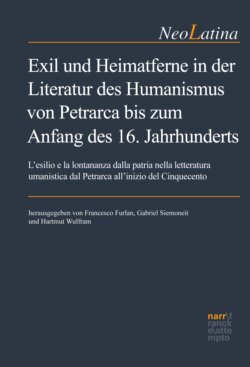Читать книгу Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts - Группа авторов - Страница 9
«Cacciato e isfolgorato dalla fortuna»: Variazioni sul tema dell’esilio, e gli inizî della novella italiana
ОглавлениеPiotr Salwa (Roma)
Tra gli studî critici dedicati alla novellistica «di stampo boccacciano» numerosi sono quelli dedicati alle cornici, anche in àmbito europeo e non solo in lingua italiana.1 La cornice, infatti, rappresenta una caratteristica essenziale di un determinato tipo di raccolta narrativa: alcune antologie e/o storie dei generi letterarî la trattano addirittura come un fondamentale criterio tipologico, distinguendo le raccolte «a cornice» dalle sillogi che ne sono sprovviste. Considerata un tempo anzitutto come un espediente formale in grado di conferire all’opera letteraria la necessaria «unità», ma in buona misura di per sé sprovvisto dell’interesse artistico ravvisabile nelle novelle stesse, ha poi attirato l’attenzione dei critici sia come istanza narrativa atta a suggerire una lettura o un’interpretazione dei racconti, sia come discorso in un certo senso metanarrativo che inquadra e modifica ciò che vien veicolato a livelli testuali «inferiori».
Tra i varî aspetti e motivi presenti nelle cornici, merita un momento di riflessione la frequente ricorrenza – quasi un luogo comune del genere – delle trame che hanno il loro nucleo nell’allontanamento dei protagonisti dai luoghi e dalle situazioni abituali della loro esistenza «normale» e quotidiana. Il «novellare» fa parte di solito di un dialogo che si svolge in circostanze insolite o addirittura singolari e drammatiche.2 Prima tuttavia di soffermarci sui casi concreti che si riscontrano in alcune narrazioni novellistiche, sarà utile ricordare una tipologia, anche sommaria, relativa all’allontanamento da un luogo considerato «naturale» per l’individuo.
Il fenomeno vanta ormai una Sekundärliteratur sterminata, ma in questa sede vorrei riferirmi in particolare a un modesto studio di Janina Abramowska che, ispirandosi ai suggerimenti di Michail Bachtin e di Jurij Lotman, propone talune distinzioni elementari che sembrano, ai nostri fini, poter costituire un buon punto di partenza.3 Anche se possono apparire ovvie o addirittura banali, esse permetteranno di tracciare una specie di mapping e di collocare le situazioni concrete riscontrate nelle cornici nell’ambito di un vasto spettro di possibilità virtuali. In primissimo luogo, «allontanarsi» significa dunque abbandonare lo spazio chiuso e familiare rappresentato dalla propria casa per affrontare una realtà piú o meno sconosciuta. Può trattarsi di una decisione libera oppure di una costrizione di vario tipo, mentre la destinazione può essere deliberata, casuale o forzata. Fuori dell’ambiente domestico ci si può limitare a essere osservatori passivi, ma si può anche diventare, volontariamente o meno, protagonisti di vicende eccezionali. Le opposizioni casa vs. mondo, immobilità vs. movimento, stabilità vs. rischio, abituale vs. nuovo, proprio vs. forestiero, etc., si possono associare a valutazioni diverse e contrarie, ognuno dei poli assumendo, a seconda dei casi, un valore positivo o negativo, anche alla luce di pregiudizî e stereotipi di carattere ideologico. Si aggiunga infine che chi abbandona la propria casa può esser percepito come individuo che séguita ad appartenere alla propria collettività, ma altresí come un forestiero. Anche al ritorno a casa, del resto tutt’altro che scontato, si possono attribuire segni diversi: esso può equivalere negativamente a una sconfitta, a una rinuncia o alla ricerca d’un rifugio, ma nella tradizione letteraria il ritorno è di norma connotato piuttosto positivamente, essendo un indiscusso happy end vissuto senza riserve. Esso coincide con il superamento degli ostacoli, con la vittoria sull’avversario (che aveva messo a repentaglio la pace domestica preesistente), con il ritorno all’equilibrio. Il ritorno a casa può tuttavia funzionare come un happy end soltanto nelle società che godono d’una certa stabilità, in cui si avverte univocamente e positivamente la consapevolezza d’avere nel mondo un posto proprio e stabile, e un forte legame con la collettività, con la casata e con la famiglia. L’allontanamento è, indipendentemente dalle motivazioni, un’esperienza chiusa ed eccezionale, non una regola.
In questo vasto e generico panorama l’esilio nel senso più specifico, benché storicamente impossibile da quantificare come fenomeno sociale, assume tuttavia un significato del tutto particolare, non foss’altro perché toccò in sorte a personaggi illustri e di primo piano. La condizione di esule segnò infatti profondamente l’esistenza o l’esperienza di grandi figure della storia e trovò espressione in opere di grande valore e lunga durata. In una prima e ristretta accezione, l’esilio significherebbe inizialmente l’allontanamento forzato d’un cittadino dalla patria, una forma di punizione o repressione, dunque, ma il campo semantico del termine è andato notevolmente estendendosi, certo sotto le pressioni delle svariate situazioni reali. Esso può riferirsi ugualmente a un allontanamento apparentemente volontario, ma in realtà imposto dalla logica dei fatti principalmente per evitare violenze o persecuzioni, le negative conseguenze d’una determinata situazione politica o sociale, ma anche per fuggire problemi fiscali o legali. L’esilio può riguardare singoli individui o intere etnie, può esser interno o interiore, senza uno spostamento fisico e limitato alla sfera psicologica, oppure esterno. Talvolta la differenza tra esilio ed emigrazione non sembra affatto scontata. Per evitare definizioni restrittive, nelle nostre considerazioni potremmo definire l’esilio in modo assai generico, come quello spostamento da un primo luogo «abituale» a un secondo luogo diverso ed estraneo in cui il desiderio d’abbandonare l’uno prevale decisamente sul desiderio di raggiungere l’altro.
*
Nella novellistica italiana i motivi connessi a quel complesso insieme d’idee o di concetti emergono fin dall’inizio.4 Nell’esaminarne le varianti piú significative ci sembra d’uopo ricorrere a un breve questionario, in cui proponiamo di prendere in considerazione i seguenti criterî:
1 esilio volontario / esilio involontario (forzato)
2 motivazione
3 luogo di partenza (caratteristica dominante)
4 luogo d’esilio (caratteristica dominante)
5 tipo di contrasto (peggioramento / miglioramento delle condizioni di vita)
6 ritorno / non ritorno
7 esperienza positiva / esperienza negativa.
Di là da ogni dubbio giustificato o persino (in questo genere di confronti) obbligatorio, il nostro principale punto di riferimento sarà ovviamente fornito dalla cornice del Decameron. In questa sede sarebbe superfluo il ricordarne dettagliatamente la trama. Si tratta del volontario e ben ponderato allontanamento dalla propria città – o patria – d’un gruppo di parenti, vicini e amici le cui motivazioni vengono esplicitate in un articolato discorso dell’«ideatrice» dell’impresa: Pampinea. La sua lunga giustificazione dimostra che si tratta d’una decisione tutt’altro che scontata. È un allontanamento privo di qualsiasi riferimento di carattere politico – la politica è in generale poco presente sulle pagine del Decameron – e di qualsiasi forzatura umana, ma volontario, in realtà, soltanto «in superficie», in quanto a uno sguardo piú attento si rivela condizionato e operato sotto l’ineluttabile costrizione del destino, dato che la vita dei protagonisti si trova in costante pericolo, minacciata com’è dalla peste che infuria in città e dal degrado sociale che vi s’accompagna. Richiamandosi, dunque, sia alla «natural ragione» che alle leggi e all’esempio altrui, i protagonisti affermano il loro diritto di difendere la propria incolumità e – visto che rimanere sul posto si ridurrebbe a un inutile e assurdo «essere testimonie di quanti corpi morti ci sieno alla sepoltura recati […] o ascoltare se i frati di qua entro […] alle debite ore cantino i loro uffici»5 – decidono che la miglior loro difesa consiste nel partire. Allontanarsi sarà inoltre utile dal punto di vista morale, in quanto nella città devastata regnano la dissolutezza e la corruzione; la morte corporale vi s’accompagna alla morte spirituale, ugualmente minacciosa. E anche questo contribuisce a creare quel clima d’insopportabile oppressione in cui l’autoesilio risulta essere l’unica degna soluzione. Pampinea non manca di notare, del resto, come anche sotto tale aspetto la realtà fiorentina sia del tutto contraria alla normalità:
veggiamo coloro i quali per li loro difetti l’autorità delle pubbliche leggi già condannò ad essilio, quasi quelle schernendo, per ciò che sentono gli essecutori di quelle o morti o malati, con dispiacevoli impeti per la terra discorrere […].6
Se in città trovano rifugio quelli che ne son stati giustamente esiliati, devono cercar rifugio in esilio coloro che non vogliono arrendersi di fronte alla corruzione dilagante.
Del resto i protagonisti della cornice decameroniana non fanno altro che seguire l’esempio di molti concittadini:
io giudicherei ottimamente fatto – dice Pampinea – che noi, sí come noi siamo, sí come molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo, e fuggendo come la morte i disonesti essempli degli altri, onestamente a’ nostri luoghi in contado, de’ quali a ciascuna di noi è gran copia, ce ne andassimo a stare, e quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo.7
La preoccupazione nei confronti dell’onestà da servare ritorna altresí nel breve dibattito che segue la proposta:
se alla nostra salute vogliamo andar dietro, trovare si convien modo di sí fattamente ordinarci, che, dove per diletto e per riposo andiamo, noia e scandalo non ne segua.8
L’esilio scelto dai narratori decameroniani ha una durata ben limitata. Al momento della partenza la questione non desta troppe preoccupazioni e vi s’accenna solo in maniera indiretta: la discretissima Filomena dubita fortemente «se noi alcuna altra guida non prendiamo che la nostra, che questa compagnia di dissolva troppo piú tosto e con meno onore di noi che non ci bisognerebbe», mentre Pampinea si dichiara pronta a dar a tutti l’esempio «per lo quale di bene in meglio procedendo la nostra compagnia con ordine e con piacere e senza alcuna vergogna viva e duri quanto a grado ne fia».9 Trascorsi quindici giorni dalla partenza, la gentile brigata decide di tornare sui proprî passi, non senza però – ci si dice – un animato dibattito: «i ragionamenti furon molti tralle donne e tra’ giovani, ma ultimamente presero per utile e per onesto il consiglio del re […]».10 Di contro alla dettagliata argomentazione addotta per convincere i protagonisti alla partenza all’inizio dell’opera, alla sua fine bastano poche e generiche affermazioni:
acciò che per troppa lunga consuetudine alcuna cosa che in fastidio si convertisse nascer non ne potesse, e perché alcuno la nostra troppo lunga dimoranza gavillar non potesse, e avendo ciascun di noi, la sua giornata, avuta la sua parte dell’onore che in me ancora dimora, giudicherei, quando piacer fosse di voi, che convenevole cosa fosse omai il tornarci là onde ci partimmo.11
Nulla fa invero pensare che siano cessate le disastrose condizioni che erano state all’origine della decisione di partire e le preoccupazioni or ora menzionate non hanno certo, in quel preciso momento, una ragion d’essere piú fondata che per l’innanzi. La chiave della svolta sarebbe piuttosto da ricercarsi nel fatto che in quel breve arco di tempo s’è compiuto il senso ed è stato conseguito l’obiettivo ideale dell’allontanamento. Si conclude il ciclo che aveva dato a ciascun componente della brigata la possibilità d’essere per una giornata «onorato e ubbidito come maggiore»,12 e con esso prende forma anche un ideale ciclo narrativo, in modo più discreto vengono messi in risalto due aspetti di quel volontario e breve esilio, con un leggero ma significativo spostamento d’accenti rispetto al momento della partenza. L’obiettivo principale della partenza – quello di «dovere alcun diporto pigliare a sostentamento della nostra sanità e della vita, cessando le malinconie e’ dolori e l’angoscie, le quali per la nostra città continuamente […] si veggono»;13 viene confrontato con il modo in cui esso è stato raggiunto:
il che secondo il mio giudicio noi onestamente abbiam fatto; per ciò che, se io ho saputo ben riguardare, quantunque liete novelle e forse attrattive a concupiscenzia dette ci sieno, e del continuo mangiato e bevuto bene e sonato e cantato (cose tutte da incitare le deboli menti a cose meno oneste), niuno atto, niuna parola, niuna cosa né dalla vostra parte né dalla nostra ci ho conosciuta da biasimare; continua onestà, continua concordia, continua fraternal dimestichezza mi ci è paruta vedere e sentire.14
Ciò che si riferiva alla realtà fisica e corporea si trova ora in secondo piano, mentre si evidenzia l’aspetto morale e quella che potrebbe definirsi come l’«arte del vivere». Lontano dalle frenetiche preoccupazioni della vita cittadina, e consapevoli del fatto che «le cose che sono senza modo non possono lungamente durare»,15 i protagonisti hanno saputo creare durante quel breve periodo un ambiente cortese e raffinato, alto e nobile, sereno e dedito a onesti piaceri.
Trovandosi per forza di cose in una situazione del tutto eccezionale, liberi loro malgrado dalle preoccupazioni della routine quotidiana, avendo a disposizione tutto il loro tempo e giornate intere, i protagonisti della cornice creano un rituale in cui uno spazio significativo viene dedicato al piacere, sia esso rappresentato dal «continuo mangiare e bere bene» o da «liete novelle» e risate, oppure da passeggiate tra paesaggi incantevoli e, ancora, da balli e canti. La narrazione che ci offre il Boccaccio mette in risalto soprattutto l’importanza del dialogo.
Infatti, al lettore del Decameron, anche poco attento, non possono sfuggire le aperture al dialogo segnalate in varî luoghi del testo. L’opera si presenta già nel titolo come relazione di una serie d’incontri e di conversazioni: «Comincia il libro […] nel quale si contengono cento novelle, in diece dí dette da sette donne e da tre giovani uomini».16 Sin dall’inizio della narrazione il Boccaccio assume apertamente un atteggiamento dialogico, intendendo istituire rapporti diretti con il pubblico da lui privilegiato, le donne, rivolgendosi direttamente a esse: «Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose[…]».17 Alla partecipazione al dialogo e al dibattito attorno al libro invitano palesemente le stesse, impegnate pagine dell’introduzione alla Quarta giornata e della Conclusione dell’autore, ove si richiamano alla memoria le voci, anche e soprattutto quelle ostili, che già corrono e che dialogano con il Boccaccio narratore, e ove si ribadisce l’importanza della benevolenza e dell’appoggio che l’autore attende dai proprî interlocutori.
Il dialogo non soltanto caratterizza la relazione che l’autore del Decameron intende istituire con i lettori, ma al tempo stesso funziona come parte integrante dei dibattiti che si svolgono tra la lieta brigata. A metterlo in rilievo serve l’accuratissima forma da tutti rigorosamente rispettata. Il dialogare è regolato da una precisa etichetta di norme e di civiltà. Gli incontri hanno luogo sempre alla stessa ora e nello stesso luogo, si svolgono secondo procedure formalizzate e sempre uguali. La cura costante della forma fa sí che nessuno manchi di rispetto al re o alla regina della giornata, nessuno trasgredisca l’ordine nel parlare, nessuno proponga temi estranei ai limiti prestabiliti, nessuno dimostri impazienza nell’ascoltare o, peggio, interrompa l’oratore. Il senso di un tale dialogo consiste fra l’altro nell’opporsi con imperturbato ordine alla disgregazione della civiltà dalla quale i narratori fuggono. L’unico disturbo viene provocato dall’irruzione, all’inizio della Sesta giornata, dei due rozzi servitori Tindaro e Licisca, respinti non solo con risa carnevalesche, fragorose ma chiaramente impregnate di un senso di superiorità, ma altresí dalla ferma decisione della regina: «mentre la Licisca parlava, facevan le donne sí gran risa, che tutti i denti si sarebbero loro potuti trarre […]. […] la reina con un mal viso le ‘mpose silenzio e comandolle che piú parola né romor facesse».18 Al dialogo possono partecipare soltanto coloro che rispettano degli alti criterî morali. Perciò, tra i rischi connessi al prorogare oltre misura l’esilio, Panfilo cita anche il seguente: «Senza che, se voi ben riguardate, la nostra brigata, già da piú altre saputa da torno, per maniera potrebbe multiplicare che ogni nostra consolazion ci torrebbe».19
L’esilio serve dunque, principalmente, in quanto prova di carattere ed esperienza che arricchisce chi la vive soprattutto grazie a una «civil conversazione» ante litteram. L’essersi sottratti alle costrizioni del quotidiano permette un dialogo piú libero, uno scambio d’idee piú aperto e piú innovativo, nonostante il rispetto delle forme. Il ritorno alla normalità avviene in una condizione morale, fisica e spirituale migliore di quella iniziale. Di nuovo, è un percorso in qualche misura analogo a quello che sono chiamati a compiere i lettori del Decameron nell’auspicio dell’autore:
Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto piú viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sí come la estremità della allegrezza il dolore occupa, cosí le miserie da sopravegnente letizia sono terminate.20
Il gran motivo della cornice riecheggia poi – e la cosa sembra piuttosto scontata – in alcune novelle della raccolta. Sebbene a volte non sembri chiara la linea di demarcazione tra esilio ed emigrazione, il senso dell’allontanamento dalla patria risulta piuttosto evidente, a cominciare dalla novella di apertura (Dec. I, 1), raccontata «acciò che, quella udita, la nostra speranza in lui [sc. Dio], sí come in cosa impermutabile, si fermi e sempre sia da noi il suo nome lodato».21 I suoi protagonisti sono italiani residenti da tempo in Francia, accomunati da un certo senso di solidarietà di fronte ad un ambiente «forestiero», anche se lontanissimi gli uni dagli altri per il loro status sociale e per le motivazioni che li hanno spinti a vivere all’estero: per ser Musciatto Franzesi, «di richissimo e gran mercatante in Francia cavalier divenuto»,22 si trattava d’una brillante carriera politica; per i fratelli fiorentini in Borgogna, «li quali quivi a usura prestavano»,23 della possibilità di svolgere una sospetta ma lucrativa attività economica; per ser Ciappelletto, «il piggiore uomo che mai nascesse»,24 con ogni probabilità della fuga da qualche persecuzione penale, da una esplicita condanna o magari da una vendetta privata. Per tutti, l’allontanamento dalla patria offriva la possibilità di portare alla perfezione il proprio carattere: di grand’uomo d’affari, spregiudicato ed efficace, o di minuto ma spietato sfruttatore o, ancora, di perfetto depravato. Tra emigrazione ed esilio si definisce altresí lo status dei tre fratelli fiorentini (Dec. II, 3), i quali decidono di lasciare la loro città natale per non far vedere la povertà in cui erano caduti per lo smisurato e dissennato loro spendere. Anche per loro il vivere lontano dalla patria è una prova di carattere che riescono a superare, una chance che non si lasciano sfuggire di rifarsi dell’avvilimento di cui sono essi stessi colpevoli.
Il modo d’intendere la funzione dell’esilio diventa piú palese nel confronto di altre due varianti del motivo, l’una ambientata nel mondo aristocratico, l’altra nel mondo comunale.25 Le due novelle sono situate direttamente l’una dopo all’altra: nella prima (Dec. II, 8), il virtuoso conte d’Anguersa parte all’estero per fuggire le possibili e minacciose conseguenze di false accuse (si tratta essenzialmente del motivo noto dalla biblica vicenda della moglie di Putifarre); nella seconda (Dec. II, 9), a fuggire, sempre per via di false accuse connesse alla sfera erotica, è la virtuosa moglie del mercante Bernabò da Genova. Anch’essi superano la prova di carattere, e benché in entrambe le novelle sia in definitiva la Fortuna a decidere del lieto fine «oltre alle speranze» dei protagonisti,26 per i narratori e per il lettore ciò non è altro che una giusta ricompensa per la loro integrità morale. Né molto diverso sembra il caso di Tedaldo degli Elisei (Dec. III, 7) che, respinto dall’amata, dopo varî e vani tentativi per riacquistarne l’amore perduto,
a doversi dileguar del mondo, per non far lieta colei che del suo mal era cagione di vederlo consumare, si dispose. E, presi quegli denari che aver potè, segretamente, senza far motto ad amico o a parente, fuor che ad un suo compagno il quale ogni cosa sapea, andò via […].27
Non tutti protagonisti decameroniani sono tuttavia in grado di superare la prova. Cosí, la fuga di tre coppie d’innamorati in cerca della libertà necessaria a vivere le loro passioni (Dec. IV, 3) finisce in una sanguinosa tragedia. Ciò non cambia, tuttavia, la prospettiva generale: l’esser lontano da casa propria è piuttosto un’occasione da sfruttare, che di solito si rivela utile; e si vedano persino casi cosí «radicali» quali il rapimento della moglie di messer Ricciardo da Chinzica (Dec. II, 10), che trova nel rapitore che se la porta via un uomo preferibile al vecchio marito, e nel rapimento l’occasione di liberarsi di lui.
L’impostazione che il Boccaccio ci propone merita evidentemente il confronto con quella lunga tradizione testuale, e con l’immaginario a essa connesso, in cui l’allontanamento dalla casa e soprattutto il viaggio o la peregrinazione rappresentano metaforicamente un’acquisizione d’esperienza vitale per la statura spirituale del protagonista: a partire da racconti mitologici e biblici, attraverso le fiabe e la poesia epica, fino a Dante, ammirato maestro del Certaldese. Come sempre accade per le strategie narrative minuziosamente elaborate e poi precisamente messe in opera dal Boccaccio, il loro senso andrebbe ricercato in un sottile gioco di analogie e innovazioni, di continuazione e rottura, di consenso e contraddizione. Si tratta, tuttavia, di un confronto che esula dai limiti del breve saggio presente.
Il grandioso tessuto narrativo del Decameron diventa presto, com’è noto, una sorta di «tela aida» sulla quale dei cosiddetti epigoni s’applicheranno a sovrapporre i loro «ricami», non sempre di grande eccellenza. La distanza che separa le loro narrazioni dalla raccolta boccacciana non sembra tuttavia esser sempre l’effetto di un’inconsapevole mediocrità, e potrebbe ben risultare sia da una loro particolare – e assai diversa dalle nostre – interpretazione delle novelle, sia da un calcolato tentativo di piegare il modello ai loro intenti, diversi da quelli del pur ammirato autore. In tale chiave si possono leggere anche i riferimenti al motivo che ci interessa in questa sede. Vediamone due esempî significativi.
Giovanni Sercambi di Lucca sembra adottare nella cornice della propria raccolta di novelle uno schema in superficie analogo a quello del Decameron: un gruppo di persone s’allontana dalla città natale per evitare la moría, proponendosi tuttavia sin dall’inizio di tornare quando i brutti tempi siano passati:
[…] pensonno con un bello exercizio passare tempo tanto l’arie di Lucca fusse purificata e di pestilenzia netta; e raunati insieme, li ditti diliberonno di Lucca partirsi e per la Italia fare i loro camino con ordine bello e con onesti e santi modi.28
Il motivo narrativo suggerito dal Boccaccio viene tuttavia sfruttato per veicolare contenuti assai diversi, in quanto l’esilio volontario dei lucchesi assume due aspetti originali: politico e religioso. Analogamente a quanto avveniva nella cornice del Decameron, si tratta di una scelta superficialmente volontaria ma, in realtà, imposta dall’incombente pericolo di morte. Tuttavia, mentre nella raccolta boccacciana si trattava di un’iniziativa privata che riguardava un esiguo gruppo d’amici e di parenti, desiderosi di seguire l’esempio d’altri, simili e piú o meno anonimi gruppi, nella cornice sercambiana si tratta d’una scelta civica. La posta in gioco non è solo la propria vita ma il destino dell’intera comunità, e la morte incombente non è soltanto quella materiale, ma altresí quella spirituale. Anzi, la questione della morte fisica e la problematica materiale della peste sembrano presto respinti in secondo piano da considerazioni di carattere spirituale e moralizzante. Lo preannunciano già le parole con cui il Sercambi dà inizio al proprio racconto:
È la natura umana creata e fatta da Lui a Sua somiglianza acciò che tale umana natura la celestiale corte debbia possedere, se di peccati non è ripieno; e quando per follia dessa dal celestie paradiso è privata non se ne dè dare colpa se non ad essa umana natura, e simile se E’ li dàe diversitadi per li nostri peccati comissi […].29
L’epidemia di peste non è altro, infatti, che una severa e collettiva punizione dei peccati mandata da Dio; per sottrarsi al pericolo d’annientamento, la comunità deve rompere con il passato e rinascere dando prova di corretta condotta morale:
neuna medicina può riparare, né ricchezza stato né e altro argomento che prender si possa sia sofficiente a schifar la morte altro che solo il bene, ch’è quello che da tutte pestilenzie scampa; e quella è la medicina che salva l’anima e ‘l corpo.30
Per questo, appunto,
alquanti omini e donne, frati e preti et altre della città di Lucca […] diliberonno, se piacer di Dio fusse, […] prima accostarsi con Dio per bene adoperare e da tutti i vizii astenersi; e questo faccendo la pestilenzia e li altri mali che ora e per l’avenire si spettano, Idio per sua pietà da noi cesserà.31
Nell’allontanarsi dalla città contagiata, i protagonisti sercambiani non soltanto vogliono fuggire un luogo nefasto, ma anche intendono avvicinarsi all’agognata meta spirituale seguendo l’insegnamento del loro nuovo leader:
poiché diliberati siemo per campare la vita e fuggire la peste, debiamo eziandio pensare di fuggire la morte dell’anima, la quale è piú d’averne cura che lo corpo. E acciò che l’uno e l’altro pericolo si fugga, è di necessità pigliare la via di Dio e’ suoi comandamenti e, con quelli savi modi che si denno, guidare le nostre persone.32
Da una parte, lo star lontano dalla patria coincide con il compimento d’un lungo viaggio di carattere penitenziale, con un’importante tappa romana dedicata soprattutto a pratiche devozionali. Dall’altra, quell’esperienza serve a mettere a punto la nuova organizzazione sociale e politica dei lucchesi. Infatti, per poter mantenere il giusto rigore morale, essi s’organizzano in una società di tipo signorile: dopo aver scelto un preposto, tutti gli giurano ubbidienza, gli affidano la gestione delle finanze comuni e la scelta dell’itinerario. È lui che comanda per l’intera durata della permanenza fuori Lucca, è lui che nomina i responsabili dell’organizzazione del viaggio, è lui che stabilisce il ritmo delle giornate. Non si tratta, di contro al Decameron, semplicemente d’assegnare i compiti alla servitú, bensí di nominare veri e proprî funzionarî del nuovo potere signorile. Del raffinato clima d’uguaglianza e di reciproco rispetto che regnava nel Decameron non rimane alcuna traccia. In tale contesto cambia anche la funzione attribuita all’atto del narrare: esso non deve servire ad altro che all’indottrinamento degli ascoltatori e tale delicata missione viene affidata esplicitamente e personalmente a un fedele e autorevole portavoce del preposto. L’unico narratore è poi facilmente identificabile, grazie all’acrostico che si trova in un «piacevole sonetto» iniziale, nello stesso Sercambi, noto tra i suoi concittadini come storico e cronachista.33 La brigata sercambiana non dialoga, ma ascolta e impara, limitandosi a lodare gli insegnamenti morali, condannare i vizî e concedersi a volte qualche risata. La voce del narratore unico, e autore della relazione del viaggio,34 è accompagnata esclusivamente da canzoni e poesie moralizzanti; se ci sono tracce di polemiche e divergenze d’opinione, esse sono e rimangono velate e allusive.35 Le analogie tra simile raffigurazione fortemente ideologica – e idealizzata, poiché il nuovo assetto sociale e politico implicitamente s’identifica, nella narrazione sercambiana, con la volontà di Dio – e il reale impegno politico dell’autore sembrano confermare quest’interpretazione.36 Siccome l’unico manoscritto pervenutoci dell’opera è mutilo e tronco, nulla sappiamo del ritorno in patria dei lucchesi. Ma le reali vicende storiche di Lucca e l’instaurazione del potere signorile appoggiata dal Sercambi sembrano offrire una soluzione all’enigma.
Per il Sercambi, dunque, l’esilio è una scelta, che si direbbe inevitabile e ovvia, operata dai giusti di fronte a una corruzione che scatena l’ira di Dio, e contro la quale non si scorgono rimedî diversi. Per fuggire il peccato ci si deve sottoporre a un periodo di prova e di perfezionamento. Se i pragmatici e concreti obiettivi sono per l’autore consoni all’attuale situazione politica della patria, la fase dell’esilio li nobilita e li sublima.
Non stupisce il fatto che in un’opera di cosí evidente carattere politico il motivo dell’esilio o quello del bando ritornino in numerose novelle. Nel mondo narrativo sercambiano l’esilio di un protagonista e di un gruppo di persone consente d’individuare e di caratterizzare un determinato momento storico, quasi a confermare il ruolo emblematico che il fenomeno ebbe nella realtà politica toscana dell’epoca (cfr. Nov. CV, 5: «nella nostra città, molti cittadini lucchesi per male stato di Lucca si partirono», CXXVIIII, 5: «essendo in Vinegia per lo male stato di Lucca andati a stare»), oppure serve a descrivere piú generalmente la condizione politica e sociale (cfr. Nov. CXXXVI e CXXXVII). L’esilio sembra quasi una condizione «abituale» nell’instabile mondo dei potenti (cfr. Nov. CXXXVIII, 9: «i Rossi di Parma furono cacciati»). E il tema ritorna addirittura in una delle canzoni (Nov. CXXXVII, 3) :
chi caccia e chi è cacciato
e tel che piglia quel ch’un altro leva
cosí non mai han tregua
i corpi governati di fortuna.
Ben nota all’autore sembra la precaria condizione dell’esiliato (cfr. Nov. LXXI, 6: «Dante di Firenze non potendo stare in Firenze, né in terra dove la Chiesa potesse, si riducea il preditto Dante alcuna volta con quelli della Scala, et alcuna volta al Signore di Mantova, e tutto il piú al duge di Lucca, cioè con messere Castruccio Castracani»; CXVIII, 9: «stando i preditti […] oggi in un luogo domane in uno altro come li sbanditi fanno»), mentre in una serie di novelle viene messa in risalto la conflittualità provocata dal ritorno degli esiliati in patria (cfr. Nov. CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIIII e CXLV).37 L’esilio emerge anche nei racconti di tipo fiabesco, ove dà luogo a una serie d’avventure miracolose (cfr. Nov. LXXXXVI) o porta a una esemplare presa di coscienza, quando l’umiliazione subita insegna al figlio dell’imperatore il vero valore del proprio ruolo sociale (cfr. Nov. LXV).
Il bando non è tuttavia solo l’«appannaggio» dei potenti: è una frequentissima forma di punizione per varî tipi di trasgressione o di reati comuni (cfr. Nov. LXXXXII, LXXXXIIII e LXXXXVIIII) applicata anche a persone di modesta condizione sociale. Sembra che per il Sercambi si tratti d’una soluzione incompiuta o lasciata a metà: il trasgressore non può piú far male ed è quindi «neutralizzato», ma ciò non equivale alla giustizia, soprattutto se il malfattore può nonostante tutto godersi ugualmente i frutti dei proprî reati (cfr. Nov. LXXXXII). Spesse volte il bandito commette nuovi crimini che portano all’unica, per il narratore, giusta soluzione finale ch’è la pena capitale (cfr. Nov. CXV, 57: «li fé tagliare la testa come la ragion vuole»; e CXXXIII, 20: «con belli et onesti modi la donna morire fé»).
Si potrebbe sostenere che nella raccolta novellistica del Sercambi il motivo dell’esilio / allontanamento focalizzi due aspetti dell’intero suo progetto narrativo. Da una parte si tratta d’una forte carica idealizzante e moralizzante: l’abbandono dello spazio domestico può equivalere all’abbandono dei vizî quotidiani e di routine, al rinnovamento spirituale e alla ricerca d’una vita nuova e migliore. Dall’altra, invece, l’esilio è intrinseco elemento della realtà sociale e soprattutto politica che va affrontato con mezzi pragmatici ed efficaci. Si tratta di fenomeni e situazioni fondamentalmente diversi e che vanno valutati, e soprattutto gestiti, con criterî diversi.38
La terza raccolta che vorrei ricordare in questa sede è Il Pecorone di ser Giovanni Fiorentino, opera rimasta finora sostanzialmente anonima in quanto nessun tentativo d’individuarne l’autore storico ha portato a risultati soddisfacenti.39 In proposito, una delle piste da seguire sarebbe, secondo taluni esegeti, per l’appunto legata al motivo dell’esilio, che nel Proemio della raccolta appare in modo tale da meritare che vi ci si soffermi. Come nei casi precedenti, anche in questo il narratore si autopresenta:
[…] ritrovandomi io a Doàdola, isfolgorato e cacciato dalla fortuna, come per lo presente libro leggendo nello fotturo potrete udire, e avendo inventiva e caggione da potere dire, cominciai questo negli anni di Cristo MCCCLXXVIII, essendo eletto per vero e sommo apostolico della divina grazia papa Urbano sesto, nostro italiano; regnando lo ingesuato Carlo quarto, per la Dio grazia re di Buemmia, e imperadore e re de’ Romani.40
La breve presentazione è ricca di puntuali riferimenti politici: nell’inquieto anno 1378 a Firenze si ricorreva piú frequentemente del solito a condanne al bando che dovevano colpire collettivamente, a ondate, gli avversari politici.41 Nel definire o caratterizzare in modo succinto e adeguato quel momento storico, l’autore si serve spontaneamente dei riferimenti alle massime autorità politiche, a lui ben note. Anche la scelta di Dovadola per rifugio sembra alludere a condizionamenti di carattere politico: si trattava infatti d’un feudo dei conti Guidi, casata ben presente nelle vicende politiche toscane e fiorentine. La problematica politica ritornerà poi massicciamente nelle novelle, piú della metà delle quali riprende brani interi della Cronaca del Villani, che viene introdotta nel discorso come «uno morale e alto ragionamento».42 Tutto ciò non permette tuttavia di precisare meglio le condizioni dell’esilio del narratore, e la lettura delle novelle «del presente libro» risulta da questo punto di vista deludente. La questione rimane sospesa e perciò, come tante altre del Pecorone, ambigua fino alla fine. Le allusioni politiche s’intrecciano tuttavia ad altre di ben diversa natura. L’autore intraprende il proprio compito apparentemente sulla scia del Boccaccio:
per dare alcuna stilla di refriggero e di consolazione a chi sente nella mente quello che nel passato tempo ho già sentito io, mi muove zelo di caritevole amore a principiare questo libro, nel quale, per la grazia di Dio e della sua santissima Madre, tratteremo di uno frate e d’una sorore, i quali furono profondatissimamente innamorati l’uno dell’altro, come per lo presente potrete udire; e sepponsi sí saviamente mantenere, e si seppon portare il giogo dello isfavillante amore, che a me dierono materia di seguire il presente libro.43
Il giovane uomo menzionato dal narratore non è poi altro che l’autore stesso, come si può facilmente desumere dal nome, Lauretto, che n’è un semplice anagramma. Pur ammettendo che il suo esilio avesse motivazioni politiche, va rilevato ch’esse non sembrano avergli causato dolori sufficienti a raccontarne piú estesamente le miserie. Il soggiorno a Dovadola, nei pressi di Forlí, luogo delle antiche passioni dell’autore, l’ozio forzato di questi e il molto tempo libero a sua disposizione, sembrano tuttavia aver ben ravvivato in lui la memoria delle cose passate: la raccolta di novelle sarebbe in un certo senso un by-product, un imprevisto effetto dell’esilio. Notiamo infine che, contrariamente alle raccolte citate in precedenza, nel Pecorone non si accenna al ritorno in patria e, in questo senso, non v’è alcun lieto fine. Non è infatti quello l’obiettivo del narratore, che raggiunge il proprio scopo nel momento stesso in cui ricorda la felicità passata:
e’ detti due amanti con singularissimo diletto piú e piú volte s’abbracciorono insieme con molte amorose e dolcissime parole […]. E cosí il detto frate Oretto ebbe dalla Saturnina quella consolazione e quel diletto che onestamente si può avere. E cosí puoson fine a’ lor disiati e dilettevoli ragionamenti, e ciascuno si partí con buona ventura.44
La funzione dell’esilio sembra interamente esaurirsi nell’occasione materiale e nello stimolo psicologico da esso offerti per tornare con la mente ai momenti felici del passato. «Ricordarsi i tempi felici nella miseria» non è motivo di dolore, ma induce riflessione, pace e consolazione. Un sapiente atteggiamento mentale permette di trovare anche nell’esclusione forzata dal proprio ambiente abituale – nella condizione di uomo «isfolgorato e cacciato dalla fortuna» – un tempo di serena tregua dalle stressanti battaglie quotidiane. Appare coerente con quest’impostazione il fatto che il motivo dell’esilio compaia alquanto sporadicamente nelle novelle, sia quelle «familiari» della prima parte della raccolta che quelle “storiche” desunte dalla Cronaca del Villani, non diventandovi mai centrale e riducendosi, anzi, a pochi e scontati ricordi delle reciproche «cacciate» delle varie fazioni politiche nelle città d’Italia, oppure a far da sfondo ad avventurose vicende di carattere fiabesco.
Ciò che può invece sorprendere è la consolazione che offre a se stesso lo sfortunato autore / amante. Carlo Muscetta suggerí decennî fa che vi si rinvenisse addirittura un intento parodistico.45 Il ricordo rievocato con nostalgia è infatti una strana storia, psicologicamente immotivata, in cui i due amanti, «per mitigar la fiamma dell’ardente amore, del quale ismisuratamente ardieno»,46 s’incontrano castamente nel parlatoio di un convento e si raccontano vicendevolmente delle novelle, all’inizio spesso salaci e poi di carattere storico-erudito, talvolta smisuratamente lunghe ma comunque presentate come «la leggiadra inventiva e la vaga maniera e l’innamorati ragionamenti che insieme teneano».47 Irrisolta rimane la questione delle vistosissime incongruenze del Pecorone, e impossibile il dire s’esse siano un involontario effetto dell’incapacità del narratore, o costituiscano messaggi cifrati od obliqui da scoprire, oppure risultino da un assemblaggio approssimativo di due testi preconfezionati ed eterogenei.48
Le osservazioni sin qui presentate non sono che l’abbozzo d’uno studio dell’uso del motivo dell’esilio fatto dalla novellistica italiana dei primi secoli. Nel pur specifico e limitato campione preso in esame si rispecchia la parentela della novella con la cronaca, con l’aneddotica, con la fiaba e con la parabola. Nel riflettere varî usi e manipolazioni diverse, esso ben illustra, soprattutto se confrontato con la letteratura umanistica e d’ispirazione «alta», da un canto, l’eccezionale versatilità del racconto novellistico e ricorda, dall’altro, come ogni convenzione possa esser trasgredita e tradursi in amplissimo e multiforme diapason trascorrente dal sublime all’umile.