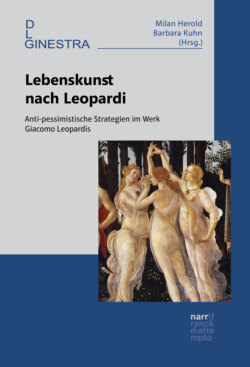Читать книгу Lebenskunst nach Leopardi - Группа авторов - Страница 17
Leopardi persuasore di vita?
ОглавлениеLeopardi als Lebensbejaher?
Antonio Panico
I due personaggi del Dialogo di Plotino e di Porfirio intrattengono un’intensa discussione intorno alla legittimità del suicidio. Porfirio, la mente affetta dalla verissima pazzia della ragione, manifesta l’intenzione di uccidersi, nella nichilistica consapevolezza della vanità delle cose. Plotino, l’uomo del sentimento, si sforza di convincere l’amico a mettere da parte il suo proposito, appellandosi a quella natura originaria che ci attacca alla vita e ci spinge all’amicizia e al conforto reciproco. Il Dialogo si svolge intrecciando la logica stringente delle argomentazioni di Porfirio (che richiama l’antico Egesia persuasore di morte) e le rassicuranti ragioni del cuore espresse da Plotino (che ancora crede nel «sogno di Platone»), in una tensione drammatica che non lascia spazio – nella lettura che proponiamo – ad alcuna conclusione definitiva, che resta così sospesa tra il silenzio insondabile di Porfirio, che sembra sottintendere la rinuncia a continuare qualsiasi discorso, e l’ultima parola di Plotino, che nonostante tutto incoraggia ancora a vivere. È in gioco l’indagine dello stesso Leopardi, sono chiamati in causa i diversi momenti e le faticose acquisizioni del suo ragionare, che si intersecano e si condizionano sul piano dialettico, alla ricerca di una sintesi che – a nostro avviso – non si lascia intravedere. Si confrontano le sue due anime tormentate, l’uomo secondo natura e il mostro secondo ragione, la spinta irriducibile della speranza e la persuasione necessaria della morte come unica via d’uscita, in un dialogo impossibile che rivela la contraddittoria e irrisolvibile coesistenza di due sguardi sul mondo che, di fronte alla Natura matrigna e nel deserto del senso, pure richiedono lo stesso coraggio.
Die beiden Figuren des Dialogs zwischen Plotin und seinem Schüler Porphyrios führen eine intensive Diskussion über die Legitimität des Selbstmords. Porphyrios, dessen Verstand vom wahrhaftigsten Wahnsinn [Zib. 104] der Vernunft befallen ist, bezeugt – im nihilistischen Bewusstsein der Nichtigkeit des Seins – die Absicht, sich das Leben zu nehmen. Plotin, der Gefühlsmensch, bemüht sich, den Freund zu überzeugen, von seinem Plan abzulassen, indem er sich auf jene ursprüngliche Natur beruft, die uns am Leben hängen lässt und uns zur Freundschaft und zum gegenseitigen Trost drängt. Der Dialog entwickelt sich, indem er die stringente Logik der Argumente des Porphyrios (der an den antiken Hegesias als Bejaher des Todes erinnert) und die beruhigenden und emotionalen Gründe Plotins (der noch an den ‹platonischen Traum› glaubt), auf eine dramatische Weise verflicht, die – gemäß der hier vorgeschlagenen Lektüre – keinen Raum lässt für eine irgendwie geartete, endgültige conclusio. So entsteht eine Spannung, die in der Schwebe bleibt zwischen dem unergründlichen Schweigen des Porphyrios, das den Verzicht auf jegliche Fortsetzung des Gesprächs nahezulegen scheint, und dem letztem Wort Plotins, der trotz allem immer noch dazu ermutigt weiterzuleben. Hier geht Leopardis eigene Auseinandersetzung mit dem Thema ein; in Frage gestellt werden die unterschiedlichen Phasen und die mühsam errungenen Resultate seines Nachdenkens, die sich überschneiden und dialektisch bedingen, auf der Suche nach einer Synthese, die sich – unserer Meinung nach – nicht erkennen lässt. Es stehen seine beiden gequälten Seelen einander gegenüber, der naturgemäße Mensch und das vernunftgemäße Ungeheuer, der unbeugsame Drang der Hoffnung und die notwendige Überzeugung, dass der Tod der einzige Ausweg sei, in einem unmöglichen Dialog, der die widersprüchliche und unauflösbare Koexistenz zweier Sichtweisen auf die Welt enthüllt, die in Anbetracht der ‹stiefmütterlichen Natur› und der Wüste des Sinns, doch denselben Mut erfordern.
Parole chiave: natura, ragione, vita, suicidio, illusione
Schlagwörter: Natur, Vernunft, Leben, Suizid, Illusion
Il coraggio di sopportare
tutto il peso del dolore,
il coraggio di navigare
verso il nostro libero mare,
il coraggio di non sostare
nella cura dell’avvenire,
il coraggio di non languire
per godere le cose care.
(Carlo Michelstaedter, I figli del mare, vv. 150–1571)
Nel ragionare intorno alle Strategie anti-pessimistiche nell’opera di Giacomo Leopardi, questo lavoro intende soffermarsi in particolare sul Dialogo di Plotino e di Porfirio del 18272. Una lettura in chiave positiva di questa operetta, che avrebbe come sbocco ideale la Ginestra3, rappresenta un argomento significativo in favore dell’anti-pessimismo di Leopardi, che nella fase matura del suo pensiero, alla visione tragica della nullità delle cose – risultato ultimo della sua filosofia –, si sforzerebbe di opporre le ragioni dell’«amicizia» richiamata da Plotino, nel suo inno alla vita nelle battute finali del Dialogo, e il motivo della «social catena» degli uomini, invocata dalla «nobil natura» della Ginestra4. Il fiore del deserto diviene così il simbolo di un’umanità che cerca riscatto sulle ceneri prodotte dalla forza annichilente del Vesuvio, volto terribile della Natura che, come aveva già scoperto l’Islandese, mostra di non avere nessuna cura per gli uomini5.
Rileggendo il Dialogo di Plotino e di Porfirio ci siamo via via convinti della necessità di una maggiore cautela interpretativa e dell’esigenza di adottare un punto di vista problematizzante. In quest’ottica proviamo qui a considerare il Dialogo, interrogandoci su pessimismo e anti-pessimismo in Leopardi, senza dare per scontata alcuna presa di posizione definitiva. In questa sede, dunque, ci proponiamo di prendere in esame il Dialogo – dedicato, com’è noto, al suicidio, questione presente in Leopardi già a partire dal Frammento sul suicidio6 e che, come si evince dai Disegni letterari7, sarebbe stata sviluppata in una progettata operetta intitolata Egesia pisatánato, per poi essere ampiamente trattata in tutto il complesso percorso dello Zibaldone8 – alla luce di interrogativi che, a nostro avviso, non hanno una facile soluzione.
Nel Dialogo Leopardi mette in forma letteraria la sua riflessione filosofica sul suicidio – quale emerge in particolare nello Zibaldone –, facendo confrontare dialetticamente due punti di vista antitetici: Plotino e Porfirio. Ci chiediamo se questo confronto giunga ad una conclusione e se essa risieda nella parola di Plotino, che formalmente chiude l’operetta, o nel silenzio di Porfirio, che potrebbe indicarci, più che una conclusione, una rinuncia a continuare il discorso. La domanda da cui partiamo è se Leopardi concluda con Plotino o piuttosto non concluda con Porfirio: se, con il primo, risolva in proposta etica (la posizione di Plotino) il suo nichilismo (la posizione di Porfirio)9, aprendo ad una visione anti-pessimistica che si affida all’«amicizia» e poi alla «social catena» degli uomini, nonostante la consapevolezza della nullità delle cose; o se, con il secondo, non riesca a trovare una sintesi tra il punto di vista teoretico (Porfirio) e il punto di vista etico-pratico (Plotino), non sciogliendo la riserva sul suicidio, lasciando aperta la questione se il suicidio sia o meno l’ultimo approdo del suo sistema10. In altri termini, ci domandiamo se Leopardi sia veramente e fino in fondo persuasore di vita – e così diamo conto anche del titolo del nostro contributo e in generale del carattere problematico di questa occasione di riflessione, che può essere soltanto un momento di un’indagine che meriterebbe più ampi sviluppi.
I due personaggi del Dialogo, non i filosofi Plotino e Porfirio realmente esistiti11, esprimono due tesi opposte: la tesi della vita (Plotino) e la tesi del rifiuto della vita (Porfirio). Sono le «due anime del Leopardi»12 che insieme discorrono sull’arduo problema del suicidio. Un’estrema richiesta di vita (Plotino) si incrocia con un’altrettanto estrema esigenza di rigore e coerenza della ragione (Porfirio), in una tensione drammatica alla ricerca di una sintesi che non si lascia intravedere. Da un lato, Plotino, il persuasore di vita, la voce del sentimento, che riconosce che non siamo soltanto ragione; dall’altro, Porfirio-Egesia, il persuasore di morte, la voce della sola ragione, che non vede altro che la vanità di tutte le cose e che sa che non c’è altra via d’uscita che il suicidio.13 Si confrontano così due contrapposte concezioni della realtà. In Zib. 102–104, tra le «maniere di vedere le cose» distinte da Leopardi, ve n’è una poetica per cui si guarda la realtà a partire dall’«immaginazione» e dal «cuore» e contraddistinta da un «rapporto continuo delle cose coll’infinito e coll’uomo» (la maniera di Plotino), e una filosofica, propria della sola ragione, per cui «le cose non hanno nè spirito nè corpo, ma son tutte vane e senza sostanza» (la maniera di Porfirio). In questo luogo emerge come l’«uso intero della ragione», la fissazione nella «considerazione» e nel «sentimento continuo del nulla veriss[imo] e certiss[imo] delle cose», l’incapacità di distogliere la mente da questo «pensiero», ci paralizzano (questo è lo stato di Porfirio) e come noi riusciamo a vivere e ad agire soltanto in virtù della «distrazione» e della «dimenticanza» e cioè grazie a forze assolutamente contrarie alla ragione (alle quali ricorre Plotino). Senza la possibilità di distrarci e di dimenticare, cioè di illuderci, come vuole la natura – intesa qui in un senso specifico, su cui ritorneremo più avanti – siamo in balìa della «veriss[ima] pazzia» della «ragione pura e senza mescolanza» (pazzia, perché impossibile da sostenere, ma verissima perché la «più ragionevole», anzi la «sola cosa ragionevole», la «sola intera e continua saviezza») e delle sue «operazioni materialiss[ime] e matematiche» (Zib. 107). Si affrontano e si scontrano due visioni del mondo agli antipodi: quella di Plotino che argomenta dal punto di vista del sentimento e quella di Porfirio che argomenta dal punto di vista della fredda e spietata ragione. Se vi sia tra di loro una conciliazione possibile – che spiegherebbe la ragione stessa del dialogare di queste due anime tormentate – è ciò su cui qui ci interroghiamo.
Il proposito suicida di Porfirio viene annunciato nel preambolo dell’operetta: per Plotino si tratta di un pensiero che non viene da «discorso di mente sana», ma da «indisposizione malinconica» (DPP 542). La discussione avviene tra una mente sana e una mente che si suppone malata. Plotino fa derivare l’intenzione di Porfirio da cause contingenti, senza rendersi conto che i motivi di Porfirio sono puramente teoretici. Il discorso di Plotino si pone su un altro piano rispetto a quello razionale:
Porfirio, tu sai ch’io ti sono amico; e sai quanto: e non ti dei maravigliare se io vengo osservando i tuoi fatti e i tuoi detti e il tuo stato con una certa curiosità; perché nasce da questo, che tu mi stai sul cuore. […]
[…] Vedi, Porfirio mio, non mi negare il vero; non far questa ingiuria a tanto amore che noi ci portiamo insieme da tanto tempo. So bene che io ti fo dispiacere a muoverti questo discorso; e intendo che ti sarebbe stato caro di tenerti il tuo proposito celato: ma in cosa di tanto momento io non poteva tacere; e tu non dovresti avere a male di conferirla con persona che ti vuol tanto bene quanto a se stessa. Discorriamo insieme riposatamente, e andiamo pensando le ragioni: tu sfogherai l’animo tuo meco, ti dorrai, piangerai; che io merito da te questo: e in ultimo io non sono già per impedirti che tu non facci quello che noi troveremo che sia ragionevole, e di tuo utile. (DPP 543sq.)
Plotino ricorre alle ragioni dell’amicizia, del cuore, dell’amore che si consolida nel tempo. Il socratico discorrere e lo sfogo degli animi aiuteranno l’amico a trovare la giusta via. Porfirio, dal canto suo, sa che ogni conversare è inutile, perché in gioco sono questioni che meritano «silenzio altissimo» e richiedono che la mente resti «solitaria e ristretta in se medesima più che mai» (DPP 544). La sua «inclinazione» riguarda il «fastidio della vita», il «tedio», il «non solamente conoscere, ma vedere, gustare, toccare la vanità di ogni cosa» (DPP 544sq.). Non soltanto la mente, ma ogni sensazione del corpo è ingombrata da questo fastidio. È una «disposizione» che proviene in qualche modo da un certo «mal essere corporale», ma ciononostante è «ragionevolissima», anzi tale che «tutte le altre disposizioni degli uomini fuori di questa, per le quali, in qualunque maniera, si vive, e stimasi che la vita e le cose umane abbiano qualche sostanza; sono, qual più qual meno, rimote dalla ragione, e si fondano in qualche inganno e in qualche immaginazione falsa» (DPP 545). È lo status proprio della ragione, condizione ragionevolissima, di chi sa che pensare che le cose della vita abbiano valore è inganno e falsità, che «nessuna cosa è più ragionevole che la noia», che i piaceri, i dolori, i timori, le speranze, sono vani, laddove soltanto la noia «la qual nasce sempre dalla vanità delle cose, non è mai vanità, non inganno; mai non è fondata in sul falso» (DPP 545). Ecco la verissima pazzia della ragione, che riconosce che continuare a vivere richiede una logica senza fondamento e cioè che la vita per esser vita dev’essere infondata, ché fondati sono soltanto la noia e la conseguente volontà suicida.
Plotino ammette le ragioni di Porfirio, ma tenta comunque altre vie. La formula tipica del suo interloquire è sì… ma…, a dimostrazione che i piani del ragionamento dei due personaggi sembrano conservare sempre un certo scarto. A suo supporto, Plotino chiama in causa Platone che rifiuta il suicidio; Porfirio ribatte prontamente di lasciar stare Platone, le sue «dottrine» e «fantasie» (DPP 546). Il primo sente il bisogno di affidarsi all’autorità per convincere l’amico a mettere da parte le sue cattive intenzioni, il secondo sa che un conto è apprezzare le opinioni dei maestri «nelle scuole e nei libri», un altro è «seguitarle nell’uso pratico» (DPP 546). Per Porfirio, il pensiero di Platone – implicitamente, il cristianesimo – intriso di riferimenti alla vita ultraterrena, ha gettato gli uomini in preda al «dubbio» e al «sospetto circa lo stato loro dopo la morte» (DPP 547). La natura, «perpetuamente inimica della nostra specie», se da un lato ci ha resi infelici, dall’altro ci ha anche dato la morte come «medicina di tutti i mali» (DPP 547sq.). Chi ascolta il «discorso dell’intelletto» non può che desiderare la morte (DPP 548). Aspettare e pensare la morte come destinazione necessaria sarebbe un «conforto dolcissimo nella vita nostra» se non fosse per il «dubbio terribile» che Platone ha instillato nella mente degli uomini, che sono giunti al punto di respingerla più di ogni altra cosa, finendo per «temere più il porto che la tempesta»14 e per odiare l’unico «rimedio e riposo […] alle angosce presenti e agli spasimi della vita» (DPP 548). In più, argomenta Porfirio, la logica delle punizioni e delle ricompense, implicita nell’idea di un mondo ultraterreno, non ha avuto sugli uomini gli effetti desiderati, consegnandoli piuttosto ad una vita di angosce e di paure (cf. DPP 548–552), e proprio in ciò risiede la «crudeltà» di Platone, che supera di gran lunga quella della stessa natura:
per le tue dottrine il timore, superata con infinito intervallo la speranza, è fatto signore dell’uomo: e il frutto di esse dottrine ultimamente è questo; che il genere umano, esempio mirabile d’infelicità in questa vita, si aspetta, non che la morte sia fine alle sue miserie, ma di avere a essere dopo quella, assai più infelice. Con che tu hai vinto di crudeltà, non pur la natura e il fato, ma ogni tiranno più fiero, e ogni più spietato carnefice, che fosse al mondo. (DPP 551sq.)
Così, per Porfirio, non c’è niente di più barbaro che non poter con l’uccidersi mettere un punto ai tormenti della vita. Gli animali non conoscono il suicidio, perché in loro l’infelicità è limitata e la vita meno sentita; soltanto l’uomo desidera morire e tuttavia, per quel «dubbio» che nessun animale avrebbe e che comunque a nessun animale impedirebbe di uccidersi qualora lo volesse, gli è vietata quella «libertà» che sarebbe per lui la fine di ogni sofferenza (cf. DPP 552sq.):
La natura, il fato e la fortuna ci flagellano di continuo sanguinosamente, con istrazio nostro e dolore inestimabile: tu accorri, e ci annodi strettamente le braccia, e incateni i piedi; sicché non ci sia possibile né schermirci né ritirarci indietro dai loro colpi. In vero, quando io considero la grandezza della infelicità umana, io penso che di quella si debbano più che veruna altra cosa, incolpare le tue dottrine; e che si convenga agli uomini, assai più dolersi di te che della natura. (DPP 553sq.)
La lunga parentesi del Dialogo su Platone – che vale, come si accennava, in particolare per la dottrina cristiana – rivela la profonda divergenza tra le posizioni dei due protagonisti. L’invettiva che Porfirio rivolge a Platone esprime emblematicamente il dispiegarsi della forza negativa della ragione che demolisce le acquisizioni e le certezze anti-pessimistiche della tradizione occidentale; acquisizioni e certezze che Plotino con difficoltà riesce a sostenere e a difendere. Plotino rappresenta l’uomo platonico-cristiano ancora fiducioso nel destino ultraterreno dell’uomo, pensa nella prospettiva di minacce di castighi eterni e promesse di premi futuri, abita una visione del mondo per cui è ancora possibile avere scopi o valori e nutrire fede o speranza nel fatto che il mondo possa non risolversi tutto in quello terreno. Porfirio, invece, è l’«uomo copernicano»15 che ha ormai rinunciato all’iperuranio platonico-cristiano, ha svelato la «spaventevole, ma vera proposizione e conchiusione di tutta la metafisica» che vuole che «l’uomo […] non nasce per goder della vita, ma solo per perpetuare la vita, per comunicarla ad altri che gli succedano, per conservarla» (Zib. 4169), per cui viene meno ogni finalismo, ogni residuo di antropocentrismo, ogni presunta idea di superiorità dell’uomo e anzi riaffermato il primato della sua infelicità.
Plotino avverte di dover lasciare da parte l’autorità e «discorrere per ragione» (DPP 555). Non Platone, né nessun altro filosofo, ma la «natura stessa» ci dice che il suicidio è un atto illecito:
se tu penserai un poco, non può essere che tu non conosca da te medesimo che l’uccidersi di propria mano senza necessità, è contro natura. Anzi, per dir meglio, è l’atto più contrario a natura, che si possa commettere. Perché tutto l’ordine delle cose saria sovvertito, se quelle si distruggessero da se stesse. E par che abbia repugnanza che uno si vaglia della vita a spegnere essa vita, che l’essere ci serva al non essere. Oltre che se pur cosa alcuna ci è ingiunta e comandata dalla natura, certo ci comanda ella strettissimamente e sopra tutto, e non solo agli uomini, ma parimente a qualsivoglia creatura dell’universo, di attendere alla conservazione propria, e di procurarla in tutti i modi; ch’è il contrario appunto dell’uccidersi. E senza altri argomenti, non sentiamo noi che la inclinazione nostra da per se stessa ci tira, e ci fa odiare la morte, e temerla, ed averne orrore, anche a dispetto nostro? Or dunque, poiché questo atto dell’uccidersi, è contrario a natura; e tanto contrario quanto noi veggiamo; io non mi saprei risolvere che fosse lecito. (DPP 555sq.)
In fondo alla posizione di Plotino vi è una specifica idea di natura, che emerge nelle obiezioni che egli pone a Porfirio nel seguito della discussione. La natura cui si richiama Plotino – ed è un aspetto essenziale della complessità del significato della natura in Leopardi – è quella forza originaria per cui ogni essere attende alla propria conservazione in tutti i modi possibili. In questo ordine di idee, la natura va intesa come sinonimo di vita, senso che emerge chiaramente in questo brano dello Zibaldone:
La natura è vita. Ella è esistenza. Ella stessa ama la vita, e proccura in tutti i modi la vita, e tende in ogni sua operazione alla vita. Perciocch’ella esiste e vive. Se la natura fosse morte, ella non sarebbe. Esser morte, son termini contraddittorii. S’ella tendesse in alcun modo alla morte, se in alcun modo la proccurasse, ella tenderebbe e proccurerebbe contro se stessa. S’ella non proccurasse la vita con ogni sua forza possibile, s’ella non amasse la vita quanto più si può amare, e se la vita non fosse tanto più cara alla natura, quanto maggiore e più intensa e in maggior grado, la natura non amerebbe se stessa […]. Quello che noi chiamiamo natura non è principalmente altro che l’esistenza, l’essere, la vita, sensitiva o non sensitiva, delle cose. (Zib. 3813sq.).
Ogni vivente si sforza di conservare la vita, vuole la vita e la continua, per questo in ogni momento della sua esistenza cerca per sé il piacere e fugge il dolore16. La natura non può essere morte, il vivente non può voler morire, vita e morte sono in contraddizione. L’ordine delle cose sarebbe sovvertito, cioè sarebbe contraddittorio, se le cose si distruggessero da se stesse, se i viventi veramente volessero non vivere, se l’essere fosse destinato al non-essere. Plotino ha così buon gioco nel sostenere l’assurdità del suicidio, gesto contrario alla natura e anzi il più contrario di tutti.
Ma agli occhi di Porfirio, il presupposto di Plotino, cioè la sostanziale identificazione della natura e del principio di non contraddizione, per cui la natura risulta essere in armonia con se stessa e libera da contraddizioni, non regge17. Come si legge in un passo decisivo dello Zibaldone, il principio di non contraddizione perde di significato nel momento in cui si tiene conto delle «contraddizioni palpabili» che esistono nella natura:
Non si può meglio spiegare l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale […] che dicendo essere insufficienti ed anche falsi, non solo la estensione, la portata e le forze, ma i principii stessi fondamentali della nostra ragione. Per esempio quel principio, estirpato il quale cade ogni nostro discorso e ragionamento ed ogni nostra proposizione, e la facoltà istessa di poterne fare e concepire dei veri, dico quel principio. Non può una cosa insieme essere e non essere, pare assolutamente falso quando si considerino le contraddizioni palpabili che sono in natura. (Zib. 4099)
Non solo il vivente non può essere felice né non essere infelice, e di conseguenza, per costituzione, non può realizzare se stesso, il suo bene, la sua perfezione, ma arriva al punto di rifiutare la vita, di non voler continuare a vivere, di preferire non essere piuttosto che essere. Le contraddizioni risiedono nell’essere stesso della natura; e che esistere implichi necessariamente il male, supporre che per il vivente l’infelicità non sia un male ma un bene, che non essere sia meglio che essere, è mostruoso:
l’essere dei viventi è in contraddizione naturale essenziale e necessaria con se medesimo. La qual contraddizione apparisce ancora nella essenziale imperfezione dell’esistenza […] cioè nell’essere, ed essere p[er] necessità imperfettamente, cioè con esistenza non vera e propria. Di più che una tale essenza comprenda in se una necessaria cagione e principio di essere malamente, come può stare, se il male p[er] sua natura è contrario all’essenza rispettiva delle cose e perciò solo è male? Se l’essere infelicemente non è essere malamente, l’infelicità non sarà dunque un male a chi la soffre nè contraria e nemica al suo subietto, anzi gli sarà un bene poichè tutto quello che si contiene nella propria essenza e natura di un ente dev’essere un bene per quell’ente. Chi può comprendere queste mostruosità? Intanto l’infelicità necessaria de’ viventi è certa. E però secondo tutti i principii della ragione ed esperienza nostra, è meglio assoluto ai viventi il non essere che l’essere. Ma questo ancora come si può comprendere? che il nulla e ciò che non è, sia meglio di qualche cosa? (Zib. 4099sq.)
L’infelicità dei viventi è necessaria: vivere significa inevitabilmente volere e non poter essere ciò che si vuole, e in questa incapacità sentita e vissuta come continua insufficienza consiste l’infelicità; il suicidio è un dato di fatto: noi vediamo che tra i viventi vi è chi giunge a togliersi la vita spontaneamente. La natura ha in sé la contraddizione: cade il principio di non contraddizione, stanno insieme il vivere e l’infelicità, l’essere e il non-essere. La natura rivela le sue «mostruosità»: rimane per noi incomprensibile come sia possibile che sia bene il male (l’infelicità), che sia meglio non vivere (il non-essere).
Alle spalle del confronto dialettico tra i due protagonisti del Dialogo vi è questa profonda diversità di vedute. Porfirio conclude il suo discorso nel segno della radicalità della ragione18:
in fine, noi possiamo conoscere che (eccetto il timor delle cose di un altro mondo) quello che ritiene gli uomini che non abbandonino la vita spontaneamente; e quel che gl’induce ad amarla, e a preferirla alla morte; non è altro che un semplice e un manifestissimo errore, per dir così, di computo e di misura: cioè un errore che si fa nel computare, nel misurare, e nel paragonar tra loro, gli utili o i danni. Il quale errore ha luogo, si potrebbe dire, altrettante volte, quanti sono i momenti nei quali ciascheduno abbraccia la vita, ovvero acconsente a vivere e se ne contenta; o sia col giudizio e colla volontà, o sia col fatto solo. (DPP 565)
Plotino, invece, rilancia ancora la natura:
lascia ch’io ti consigli, ed anche sopporta che ti preghi, di porgere orecchie, intorno a questo tuo disegno, piuttosto alla natura che alla ragione. E dico a quella natura primitiva, a quella madre nostra e dell’universo; la quale se bene non ha mostrato di amarci, e se bene ci ha fatti infelici, tuttavia ci è stata assai meno inimica e malefica, che non siamo stati noi coll’ingegno proprio, colla curiosità inaccessibile e smisurata, colle speculazioni, coi discorsi, coi sogni, colle opinioni e dottrine misere: e particolarmente, si è sforzata ella di medicare la nostra infelicità con occultarcene, o con trasfigurarcene, la maggior parte. (DPP 565sq.)
Nell’ultimo momento del Dialogo, all’esortazione finale in favore della vita da parte di Plotino corrisponde il silenzio di Porfirio. La natura chiama ancora alla vita (Plotino), anche se la ragione ha tirato le somme e ha concluso per il rifiuto della vita (Porfirio). Il Dialogo si chiude con l’ultima parola di Plotino o, si può anche dire, si interrompe quando Porfirio trae le logiche conseguenze del suo ragionamento. L’accorato appello di Plotino è una disperata richiesta di amore e di vita che viene dalla natura, l’atteggiamento di chiusura e silenzio di Porfirio rappresenta il punto di non ritorno della logica infallibile della ragione. È una dialettica inconclusa: Plotino parla ancora con la forza del sentimento, Porfirio si vede costretto a tacere, perché nell’ottica della ragione pura nessuna replica sarebbe ancora possibile. Con le sue ultime parole Plotino implora ancora una volta l’amico a desistere, Porfirio soffre in silenzio la rinuncia di chi sa che la verità comunicata non può essere compresa fino in fondo. Le due anime leopardiane – la spinta per la vita e la coscienza della legittimità del suicidio – vivono qui il momento di massima tensione e al tempo stesso rivelano la loro incolmabile distanza.
Si può leggere la conclusione del Dialogo – e a questo punto bisogna sospendere il giudizio su quale sia la conclusione leopardiana – limitandosi ad ascoltare l’appassionata perorazione di Plotino, tanto debole sul piano del logos quanto forte su quello del pathos, e a prendere atto del silenzio di Porfirio, nella consapevolezza dell’aporetica coesistenza della speranza irriducibile della vita e della persuasione necessaria della morte. Plotino è la voce del sentimento,19 di una ragione misurata usata per la vita e non contro la vita,20 Porfirio esprime il silenzio di una ragione assoluta che non accetta compromessi con le retoriche della vita. La scelta è tra l’essere uomo secondo natura o mostro secondo ragione (cf. DPP 567), ma è una scelta impossibile, perché l’uomo che con la natura riaccende le illusioni e le speranze necessariamente convive con il mostro che con la ragione le spegne.
La preghiera finale di Plotino lascia trasparire uno spiraglio di luce al cospetto del silenzio insondabile di Porfirio:
Ora io ti prego caramente, Porfirio mio, per la memoria degli anni che fin qui è durata l’amicizia nostra, lascia cotesto pensiero; non volere esser cagione di questo gran dolore agli amici tuoi buoni, che ti amano con tutta l’anima; a me, che non ho persona più cara, né compagnia più dolce. Vogli piuttosto aiutarci a sofferir la vita, che così, senza altro pensiero di noi, metterci in abbandono. Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della vita. La quale senza alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e anche in quell’ultimo tempo gli amici e i compagni ci conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volte ci ricorderanno, e ci ameranno ancora. (DPP 569sq.)
Plotino apre alla possibilità di un campo di strategie anti-pessimistiche con cui la verità persuasa al suicidio può riscattarsi nell’illusione che ci tiene attaccati alla vita: il richiamo all’amicizia come condizione necessaria per la costituzione della comunità degli uomini; la disponibilità a soffrire insieme, a confortarsi reciprocamente, a tenersi compagnia e a darsi soccorso per affrontare le sfide che la vita presenta; la disposizione ad attendere la morte con serenità e giudizio e con la speranza del conforto dei propri cari e del ricordo dei posteri come incentivi ad agire, a difendersi, a continuare a lottare.
Porfirio è vero sapiente perché ha imparato a morire, ma è vero sapiente anche chi si sforza di recitare la parte avuta in sorte, di resistere alle insidie e ai colpi della Fortuna, per quanto impari siano le forze in gioco. Rifiutare la vita con ponderata e saggia decisione, ma anche affrontarla con distacco nella lucida consapevolezza del suo scarso valore, per quanto possano sembrare posizioni agli antipodi, pure richiedono lo stesso coraggio. Scriverà Leopardi nello Zibaldone: «il semplice rider alto vi dà una decisa superiorità sopra tutti gli astanti o circostanti, senza eccezione. Terribile ed awful è la potenza del riso: chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire» (Zib. 4391). Il peso dell’angoscia di chi è persuaso a morire (Porfirio) e la leggerezza di chi vive la vita pur non tenendola in gran conto (Plotino) insistono nello stesso dramma.