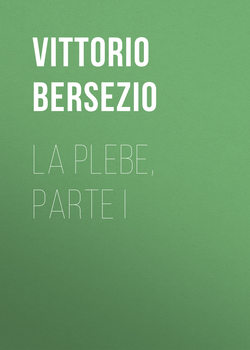Читать книгу La plebe, parte I - Bersezio Vittorio - Страница 12
CAPITOLO XI
ОглавлениеMaurilio giunse sino alla metà della piazza di San Carlo, e poi si fermò. Il suo sguardo acceso corse alle alte finestre del palazzo da cui pioveva tanta luce nella tenebria della notte. Pareva che volesse penetrarvi per entro, e con esso il suo spirito. Un'intensa aspirazione di desiderio vedevasi dipinta sul volto di lui, la quale tenevalo colà immobile coi piedi affondati nell'umido strato della neve, sotto i densi fiocchi che gli cadevano sulle spalle.
Ad un punto, con un evidente sforzo ch'egli fece, tolse gli occhi da quel bagliore in cui s'affissava, e li reclinò su se stesso. Un profondo sospiro dapprima gli uscì dal petto, poi un amarissimo ghigno gli stirò le pallide labbra, e quindi ruppe in una secca risata che avrebbe fatto pena l'udire.
– Come potrei io comparire in mezzo a tanto splendore, allato a tanta bellezza ed a tanta eleganza?
Si tolse dal luogo in cui pareva inchiodato e camminò con passo frettoloso come se rattamente volesse partire di là; ma il suo andare venne ben tosto rallentandosi; non era giunto per anco all'estremità della piazza, che diede volta, e venne lento lento, di nuovo, verso il palazzo dell'Accademia.
Sostò di colpo mandando un'esclamazione, e gettato indietro il cappello, percotendosi la fronte, come si fa quando ci sovraccoglie il lampo d'una idea:
– Ah! Diss'egli: come fu commosso Benda al vederla!
Il pensiero che si conteneva dietro queste parole parve profondamente turbarlo. I suoi lineamenti si scomposero in modo da far pietà, e giungendo convulsamente le mani, egli esclamò con un accento d'angoscia infinita:
– Gran Dio! Francesco l'ama!
Stette un momento come annientato sotto il peso di quella rivelazione che si affacciava alla sua mente con tutta l'evidenza della verità. Al campanile della vicina chiesa di San Carlo cominciarono a suonare a lenti rintocchi le ore. Maurilio alzò a poco a poco il capo che gli era caduto sul petto e stette ascoltando, mentre le sue labbra, quasi meccanicamente, contavano l'un dopo l'altro i colpi della campana.
– Dieci ore! Diss'egli quando l'orologio ebbe finito di suonare; e colà mi aspettano. Suvvia! Andiamo.
Questa volta camminò di passo veramente risoluto verso la via di S. Teresa; da questa s'intromise poi nella strada che era scritta sulle cartoline ch'egli avea dato a Gian-Luigi ed alla Gattona, e giunto alla porta numero sette vi entrò.
Messer Barnaba, non ostante tutti gli andirivieni di Maurilio, con una pazienza che è una delle prime qualità del mestiere, non aveva cessato mai di tener d'occhio il giovane, ed ora era venuto seguitandolo dalla lungi sino alla casa in cui questi si era intromesso.
– Sta egli qui o viene soltanto a trovarci qualcheduno? si era domandato il poliziotto. Vediamo.
Era entrato ancor egli sotto il portone, e traverso un finestrino sopra del quale stava scritto: PARLATE AL PORTINAIO, aveva visto al fioco lume d'una lucerna una donna nella loggetta del portiere, la quale faceva andare i ferri in certe sue calze.
– Una portinaia! Aveva egli detto fra sè. Buono! Gli è il fatto mio.
E picchiando discretamente nell'uscio che vide allato al finestrino, domandò con una voce insinuante, tutto gentilezza:
– Si può?
– Avanti: rispose la portinaia alzando il naso dalla sua calza.
E Barnaba sgusciò dentro tutto umile e in sembianza peritoso. Verremo poi ad udire che discorsi avess'egli colla portinaia; per ora vi piaccia seguitare Maurilio che più triste in volto di quella notte nevosa va su per le scale sino al quarto ed ultimo ripiano.
Colà c'erano due usci. A quello in prospetto della scala era attaccata con quattro bullette una polizza, su cui stava scritto in mezzo a girigori a colori: Antonio Vanardi pittore; l'uscio a sinistra di quello era socchiuso ed una riga di luce ne usciva ad allungarsi per lo spazzo di quadrelli, facendo impallidire al confronto l'umile lanternino appeso sopra la scala, il quale misurava una scarsa luce a chi la salisse fin colassù.
Maurilio sospinse quest'ultimo uscio ed entrò.
Una stanza piuttosto grande: sulle pareti tappezzeria da poco prezzo a fiorami bianchi su fondo bigio scuro; appiccatevi su ai quattro lati, due per parte, delle litografie incorniciate di legno nero, che rappresentavano il trasporto delle ceneri di Napoleone; un camino e sopra la pietra di sporto un busto di Dante in gesso, ed al di qua ed al di là due altre figurine di gesso, l'una Gianni che ride, l'altra Gianni che piange; presso al camino, appese al muro a chiodi e funicelle, una dozzina di pipe d'ogni dimensione, forma, materia e colore, e inoltre più saccoccie da tener tabacco; un paravento separava un angolo della stanza nascondendo dietro sè i misteri d'un letto; in tondo presso alla finestra, da una parte una scrivania, dall'altra una scancia con suvvi pochi libri, tutti in disordine; vicino a questa scancia un uscio metteva in altre stanze. Nel mezzo della camera una gran tavola e sopravi una lampada con coprilume. Nel camino ardeva un vivissimo fuoco, il quale più che non facesse la lampada mandava un brillante chiarore per tutta la stanza. Seduti presso la tavola stavano tre giovani, i quali all'entrar di Maurilio si volsero vivamente e lo salutarono con molta cordialità.
Questi tre giovani erano gli amici di Francesco Benda e di Maurilio. A quest'ultimo da due anni tenevano luogo di famiglia ed erano come fratelli.
Il meno giovane, che era presso a compire i sei lustri, aveva nome Romualdo. Viveva modestamente d'un piccolo patrimonio lasciatogli dal padre, ch'egli con alcune follie di gioventù aveva alquanto sminuito, ma che bastava pur tuttavia ai gusti rimessi che aveva acquistati colla disillusione nelle cose della vita. Aiutava uno degli amici (il quale stava appunto in quel momento seduto alla sua destra), in qualche lavoro letterario, onde questi cercava alcuno stentato guadagno.
Quest'amico, per nome Giovanni Selva, era un bello, robusto ed aitante giovane, bruno di carnagione, d'occhi, di capelli, alto di persona, di atletiche membra, di franco, gaio e simpatico aspetto. Come Romualdo e come Francesco Benda, che abbiamo lasciato al ballo dell'Accademia Filarmonica, era avvocato, e tutti tre s'erano conosciuti e fatti amici intrinseci all'Università, benchè Romualdo fosse di alcuni anni più attempato e quindi più innanzi negli studi.
Giovanni Selva apparteneva ad un'agiata famiglia borghese, ma se n'era e viveva separato per dissensioni profonde colla madre, vecchia bigotta tutta in mano d'un intrigante di confessore, la quale per far guadagnare al figliuolo la vita del paradiso si era impuntata a fargli intollerabile quella della terra.
Messo fuor di casa dall'influenza d'un cattivo prete e d'un tristo fratello, senza sovvenzione alcuna, Giovanni s'era trovato nel caso di dovere trar profitto dal suo lavoro personale. Avea dapprima voluto provare il mestiere dell'avvocato: ma dalle tasche polverose degli atti di lite non aveva tardato ad allontanarlo la faccia arcigna della noia. Allora s'era abbandonato all'aggradevole, ma poco fruttuosa occupazione della poesia e delle lettere.
– Che vuoi tu? (Quando s'incontrarono, disse a Romualdo, Giovanni con quel suo piglio scherzoso e vivace che era una delle sue maggiori attrattive.) Mia madre ed io non c'intendevamo. Era un concerto di strumenti discordi; ho pensato meglio di romperlo per amore dell'armonia… domestica. Ho lasciato le soglie materne consolate dalla santità di mio fratello teologo, e mi sono ridotto sul monte Aventino. Tu sei solo ed io pure. Andiamo insieme. Uniamoci contro il nemico comune, che sono le difficoltà della vita, troviamoci insieme la nostra strada; andremo per essa a braccia intrecciate, lavorando di compagnia, da buoni fratelli, al conquisto dell'avvenire.
Un terzo dei loro amici, ed era appunto quello che stava con essi quella tal sera di cui vi narro, aveva preso moglie, teneva in affitto un quartiere, di cui poteva cedere la maggior parte ai due compagni, e deliberarono vivere tutti insieme che sarebbe un gusto ed una economia. Questo terzo amico si chiamava Antonio Vanardi e faceva il pittore. Ancor egli era un profugo della famiglia. Possedeva uno zio ricco e droghiere nel quale si era tutta concentrata l'autorità domestica verso di lui. Lo zio aveva pensato dapprima, per ambizione, fare di Antonio un avvocato come tanti altri; e mandandolo a quest'uopo all'Università gli aveva dato occasione di stringere amicizia con Romualdo, con Giovanni Selva e con Francesco Benda; ma il buon Antonio, per quanta buona volontà ci mettesse, non era riuscito mai di farsi entrare in capo un bricciolo di Diritto romano; onde battuto tre volte di seguito alla prova degli esami, avea dovuto rinunziare alla toga dottorale con gran dispetto e disappunto del bravo zio droghiere.
Non potendo farne un Cicerone, il buon zio sperò almeno che Antonio diventerebbe un valente venditore di droghe e robe vive. Niente affatto: quel pazzerello s'era cacciato in testa di voler essere artista e di fare il pittore. Il nipote era testardo e lo zio più testardo ancora. Il primo fu scacciato di casa; ed egli corse allegramente a riparare in una soffitta colla tavolozza e coi pennelli. Forse la collera dello zio non avrebbe tardato a placarsi, se quel benedetto figliuolo non l'avesse rinfocolata con un'altra ed a senno dello zio assai peggiore pazzia: quella di sposare una povera fanciulla, che non aveva un soldo di dote e lavorava colle sue sante dita per vivere. Il droghiere, al colmo dello sdegno, aveva giurato che non avrebbe più perdonato ad Antonio, che non l'avrebbe più voluto veder mai, e finora aveva mantenuto il suo giuramento.
Francesco Benda, come ho già detto, non ostante il suo modo signorile di vita, non aveva scemato d'un punto l'amicizia che lo congiungeva a questi tre compagni, e veniva di spesso a visitarli.
Così vivevano essi, la moglie di Vanardi, che si chiamava Rosa, una buona creatura tutto ciarla e tutto cuore, facendo da donna di casa per tutti; quando un mattino Romualdo, entrato di buon'ora nella stanza di Selva, che non avea visto tornare la sera innanzi, lo trovò seduto al capezzale del proprio letto, sostenendo amorosamente colle mani la testa abbandonata d'un giacente a volto sparuto, il cui sonno l'irrequietudine soltanto distingueva dall'apparenza della morte.
Romualdo stupito fu per muovere un'interrogazione, e Giovanni fattogli cenno tacesse, depose con attenzione sovra i cuscini il capo ardente dell'addormentato e disse sotto voce:
– Lo riconosci?
Romualdo rispose col capo di no.
– Egli è quel giovane che venne due giorni sono a domandarci lavoro, e che noi mandammo a quella terra.
Quindi, tratto l'amico nell'altra stanza per potere più liberamente discorrere, soggiunse:
« – Un poveretto che ho salvo dal suicidio. Ieri sera mi sono fermato un po' più tardi in casa la Adelina; e ciò ha fruttato a me una buona azione, a costui la vita. Egli era là sul ponte di Po, che fissava lo sfilar dell'acqua sotto gli archi con quell'occhio che l'affamato un tozzo di pane. Lo vidi tra l'ombre spiccarsi per un salto, non poterlo, ricadere a terra. Accorsi: era svenuto. Lo riconobbi tosto e sentii quasi un rimorso del non averlo potuto soccorrere quando se ne venne qui elemosinando pudicamente lavoro. Che cosa fare? Tutte le botteghe erano chiuse, e non passava un'anima per colà. Me lo presi in braccio e venni più affrettatamente che potei verso la più vicina spezieria, deliberato a fracassare anche la porta per entrarci. Egli tornò in sè. Volle essere deposto in terra e camminare. Ma nol poteva, ed io dovetti sorreggerlo. Mi disse, quasi in delirio, che non aveva famiglia, non tetto, non pane, non più coraggio: lo lasciassi morire. – Ed abbandonato sarebbe morto senza fallo. La farmacia non mi venne aperta per quanto chiasso facessi; ma si apri il fondaco d'un liquorista, ed io gli feci bere un bicchierino di rhum. Questo gli diede forza, ma gli salì con impeto al cervello. Uscimmo, ed io lo accompagnava sostenendolo, e non sapevo dove. Ei si mise a parlare. Furono strani discorsi i suoi, in cui c'era un po' di tutto: scienza e poesia, erudizione e mattane fantastiche, ingegno e pazzia, un farnetico d'infermo, un vaneggiamento della febbre, un racconto straordinario di Hoffmann. Ma in quella confusione di cose balenava a vivissimi sprazzi il genio. Stupito, commosso, talvolta rapito d'entusiasmo io non credeva a me stesso. Oh! come ha parlato questo demonio!.. E poi ha uno sguardo in que' suoi occhi verzigni che incanta; una testa che non è d'essere volgare; una fronte tanto vasta da posarvisi comodamente tutto un mondo di pensieri.
«Ho di subito determinato associarlo al nostro destino, e gli ho proposto di esserci fratello. Tacque un istante, tremò di tutte le membra e poi disse con accento da scendere nell'anima:
« – Dio v'ascolti!
«Venne meco e qui il suo male sovraccogliendolo di nuovo, dovetti io stesso spogliarlo e metterlo a letto. Tutta la notte delirò con parole tronche, inintelligibili. Ora corro per un medico, lo faccio guarire, e lo avremo nuova recluta nella nostra piccola schiera. Egli mi ha detto ad un punto mostrandomi questo suo piccolo involto:
– Qui, è tutto ciò ch'io posseggo; ma qui (e si toccava la fronte), qui sta la mia ricchezza.
«Lo ha detto con tale accento di convinzione e di verità che non ne ho riso, te lo giuro. Se non avesse una così bella testa direi che gli è un avventuriere; se non m'avesse incantato colle sue parole, avrei sentito compassione della sua miseria, ma non l'avrei amato così ad un tratto. Lì dentro c'è una grand'anima. Quando l'udrai, l'amerai anche tu.»
In quel piccolo involto che il povero giovane aveva seco non si contenevano che pochi libri: Dante – Orazio – Virgilio – Macchiavelli – La Scienza nuova del Vico – il Trattato di economia politica di G. B. Say, – ed un manoscritto tutto spiegazzato ed a strappi, su cui stava scritto a grossi caratteri: – Farragine.
Romualdo diede la sua approvazione a Selva con una stretta di mano; gliela diede eziandio Vanardi; e stettero aspettando con ansia lo svegliarsi del nuovo venuto.
Ed ecco che dalla stanza di Selva un grido richiama la loro attenzione. Ci corrono e trovano lo sconosciuto che, levatosi a sedere sul letto, getta le magre gambe fuori delle coltri per torsi di là, infuocato nelle guancie, gli occhi orribilmente fuor del punto, le mani agitantisi in moto convulso.
Giovanni fu in un salto allato al giovane e lo trattenne. Il delirante gli si abbrancò alle braccia e glie le serrò da fargliene sembrare le sue mani tanaglie di ferro. Le carni gli scottavano.
– Che avete? che volete fare? Gli domandò Selva; e l'altro, fissandogli negli occhi i suoi tutti smarriti, con voce affannosa, a balzi e vibrata, gli disse:
– Trista cosa è la vita! Un'empia lotta, che vince eterna la sventura. Ai primi passi tu se' di questa via d'affanni, e ti par che sorrida all'uom la terra felicemente, e duol supremo estimi il mister della morte. Oh folle! oh folle! Io spesso, il credi, ad invidiar mi trassi la sepolcral de' morti ignota pace; e i dolor della creta maledissi, che s'assuperba nel chiamarsi viva.
– Misericordia! Esclamò Romualdo, giungendo le mani, e' parla in una specie di versi. È matto!
– L'ho detto io che era un fratello: disse Giovanni. È poeta.
Poi, facendolo ricoricare a forza, disse al delirante:
– State quieto; e se avete bisogno di qualche cosa, ditecelo.
– Pace! Ripigliava l'altro. Pace! Pensi tu che l'abbiano da godere i morti?.. Se tutto di noi va in cenere, bene! Un buffo di vento che spegne una candela, e buona sera. Se lo spirito non muore, come avrà pace? Come, perchè spogliatosi di questi ceppi di carne, sarà egli giunto di botto alla fine dei suoi travagli?.. Il rimedio sarebbe troppo facile… Non sai? Io qui dentro ci ho un tumulto che è peggio d'ogni battaglia… Ci bollono tante cose! Tante facoltà che lottano, tanti pensieri che si cozzano, tante immensità che non furono mai dette, perchè non si possono dire. E tutto questo avrà da finire senza conclusione colla poca vita della mia materia?.. Guardate! se ne dovrebbe piangere lagrime di sangue. L'anima continuerà a vivere e tramenarsi di dolore in dolore, di dubbio in dubbio, di morte in morte, donec longa dies, perfecto temporis orbe, concretam exemit labem, purumque reliquit ætherium sensum atque aurei simplicis ignem. Lo ha detto con indovinamento di poeta e con sentimento di cristiano il pagano Virgilio.
I tre amici che tenevano il delirante alle braccia si guardarono spaventati da quel latino.
– Io ho qui intorno al fronte un cerchio di ferro arroventato che m'arde e mi costringe in questa poca sfera lo spirito immortale… Oh! se potessi allargare il mio cranio!.. Se non fosse di questo cerchio, il mio spirito ha penne tali da pervolare tutto l'infinito degli spazi, di mondo in mondo, di sole in sole, di plaga in plaga di questo gran circolo della creazione che ha il centro dapertutto e la circonferenza in nessun luogo… sino ad andar posare il capo sulle ginocchia di Dio! Questo cerchio fatale che mi stringe la fronte, lo sapete? gli è il Zodiaco. I suoi segni mi danzano intorno un trescone d'inferno… Li sento che mi cantano: – «Tu se' schiavo qui, tu se' condannato alla nostra carcere… va là, va là che hai da gingillarti per un pezzo in una burlesca contraddanza fra il cancro e lo scorpione!» Pazienza! Fate fiammare la vaporiera. Io corro il mio regno su d'una via ferrata fatta sull'etere cosmico. Voglio visitare la Vergine che è l'innocenza, e la Libbra che è la giustizia; ma la seconda fu trovata coi pesi falsi, e la prima s'è acconciata a stare in via de' Pelliciai… Il mio regno! È quello del pensiero; quello dove si gettano i germi del vero, nasce il sofisma e si raccoglie la confusione… Inchinatemi. Io sono l'ingegno dell'umanità dagherotipato sulla lastra d'un uomo. Datemi la penna. Essa è il mio scettro; in mia mano avrà ad essere una spada d'Alessandro da troncare l'eterno nodo gordiano dell'astruso problema che è la società all'uomo, che è l'uomo a se stesso.
Selva affissandosi nella faccia contratta del vaneggiante, disse:
– Poverino! Qui c'è uno squilibrio delle forze intellettuali colle fisiche.
– In altri termini, soggiunse Romualdo, gli è pazzo per davvero.
– Non tardiamo a domandare un medico: disse Vanardi; e la sua osservazione fu trovata la più giusta.
Il medico, venuto sollecitamente, pronunziò:
– È una famosa febbre cerebrale, e bisogna in fretta in fretta salassare alla brava.
Rosa, la moglie del pittore, da quella buona donna che era, si piantò al capezzale del malato, e gli fece un'assistenza da suora di carità. Francesco Benda, senza pur dire una parola agli amici, provvide del suo ad ogni spesa. Il giovane fu salvo per allora; ma il medico, dando siffatta assicurazione a Giovanni Selva che ne lo interrogava con molto interesse, come quegli che aveva posta una subitamente profonda affezione nello sconosciuto; il medico soggiungeva:
– È salvo per ora; ma il germe del male non è distrutto. Quello è un organismo che porta seco un elemento potente di sua distruzione, il quale alla prima circostanza opportuna può scoppiare di nuovo ed accopparlo. Deve aver sofferto troppo.
Maurilio (poichè desso era il giovane raccolto da Selva), salvato di quella guisa dalla morte per opera di Giovanni prima, di tutti gli altri di poi, circondato d'ogni amorosa cura, entrò in quell'amichevole consorzio, ne divenne anzi parte essenziale, ne fu amato come si ama una buon'opera nostra, ed amò come glie ne faceva obbligo la riconoscenza che era il solo ripago ch'egli per allora di tanto bene fattogli potesse dare.
Quand'egli fu guarito del tutto, con una semplicità di nobile orgoglio, disse agli amici:
– Ora aiutatemi a trovar lavoro.
Selva gli propose di collaborare con lui nelle sue opere letterarie; Maurilio sorrise un po' amaramente.
– Io vorrei, diss'egli, un lavoro che fruttasse il pane; e la nostra letteratura del giorno d'oggi non è tale.
Aveva una bella calligrafia. Si fece scrivano. Ebbe la fortuna di conoscere un causidico che gli diede atti di lite da copiare. La sua sollecitudine nel lavoro e la nitidezza della sua scrittura valsero a fargliene avere di molto di questa bisogna; e fra il copiare e il tener le ragioni di qualche mercatante, dandoci dentro al lavoro giorno e notte, era giunto a guadagnarsi dalle ottanta alle cento lire al mese.
Risanato, Maurilio non era mai più venuto in propositi che somigliassero a quei suoi farnetichi del primo giorno; ed ogni qualvolta Selva aveva voluto metterlo in siffatti discorsi, egli o s'era allontanato, od aveva pregato lo lasciasse tranquillo.
Parlava di rado; talvolta calava a sorridere e barzellettare; era buono, affettuoso, gentile il più spesso; ma a tratti, senza un visibile perchè, si faceva aspro, triste e scontroso. Allora la sua taciturnità s'accresceva, come pure la scarna pallidezza delle sue guancie, stava in sè, solo il più che potesse, presso che l'intiera notte vegliava passeggiando, quasi non mangiava, e si dava per disperato all'opera manuale del copiare. Sulle prime gli amici avevano cercato svagarlo e rompergli quegl'insulti splenetici di indefinita, profonda melanconia, ma poi, visto che gli era peggio, lo compativano, tolleravano, e vedendolo soffrire, soffrivano ancor essi.
Quando l'avevan visto, oppresso da troppo lavoro, starne le tante ore col petto incurvato al tavolino, in danno della sua salute, ne l'avevan voluto dissuadere, ma invano: gli avevano offerto con insistenza il loro aiuto, ed invano eziandio.
– Lasciatemi fare: diceva egli. Ne ho bisogno. La mano si affatica, ma la testa riposa. Se fossi stato robusto da tanto, avrei preso volentieri in mano la stiva dell'aratro, e sarei stato più utile al mondo.
Selva lo rimproverava alcune volte di che, con tanto ingegno quanto era il suo, nulla facesse, nulla imprendesse, nulla tentasse da recar fama al suo nome e giovamento al mondo.
All'udir menzione della fama lo strano giovane sorrideva compassionevolmente e recitava i versi di Dante: «Non è il mondan rumore altro che un fiato, ecc.»
– Che cosa cale a me della fama? Il mio nome è nulla, voglio essere tale. Non è un nome degno di risuonare nei secoli. Giovamento al mondo? quello sì lo vorrei. Ma se niente opero gli è perchè niente mi si presenta ch'io possa fare utilmente. Intanto penso.
Ma da qualche tempo l'occasione pareva venuta di poter fare alcuna cosa. Un'opera lentamente preparata era sul punto di vivamente intraprendersi con infinito ardore e colle più lusinghiere speranze. Gli amici tutti di Maurilio si erano ad essa consecrati col più vivo trasporto dell'anima; ed ancor esso vi si era accinto, ma con un certo maggior riserbo che non era freddezza ma quasi una preoccupazione di quesito diverso e forse anco superiore.
Quale fosse quest'opera lo vedremo tosto.
Entriamo intanto nella stanza che ho detto, la quale era appunto quella abitata da Maurilio, e vediamo insieme i quattro amici raccolti.