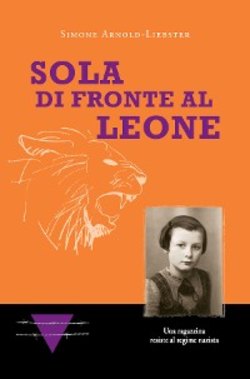Читать книгу Sola di fronte al Leone - Simone Arnold-Liebster - Страница 9
ОглавлениеCAPITOLO 1
La mia infanzia tra città e campagna
Giugno 1933
La mia famiglia abitava a Husseren-Wesserling, un piccolo e grazioso villaggio situato nella valle di Thann nei Vosgi, non lontano dalla fattoria dei nonni. La nostra casa era incantevole: un rigoglioso pergolato di rose consentiva l’accesso al giardino e ai prati. Il mio paese si trovava in Alsazia-Lorena, una regione di frontiera teatro di lunghe contese tra Germania e Francia.
Avevo quasi tre anni quando la mamma, il papà, io e la mia cagnetta Zita ci trasferimmo a Mulhouse, al terzo piano di un palazzo situato in Rue de la Mer Rouge al numero 46. A quel tempo la mia famiglia era tutto il mio mondo. Nemmeno nei miei più inquietanti incubi avrei potuto immaginare le sofferenze, la miseria e il terrore che sarebbero piombati su di noi. Il nome della nostra via, Rue de la Mer Rouge – Via del Mar Rosso – sarebbe divenuto il simbolo del nostro destino: disperazione, separazioni, viaggi, ma soprattutto speranza. Mi domando se i miei genitori abbiano mai riflettuto sull’affinità fra il significato storico del nome della via e le nostre future vicissitudini.
La stazione ferroviaria di Mulhouse-Dornach segnava l’inizio della lunga Rue de la Mer Rouge, che si snodava tra giardini e prati, e serviva agli abitanti di una serie di case popolari e di palazzine. Il numero 46 era un edificio di quattro piani e otto appartamenti, dove abitavano alcuni operai della ditta Schaeffer & Co., una stamperia tessile rinomata in tutto il mondo. Il papà vi lavorava come consulente artistico.
In città non mi era permesso di avvicinarmi troppo alle finestre di casa e tanto meno di uscire per strada da sola. Che tristezza per una ragazzina di campagna! Anche i fiori sul balcone erano prigionieri dei loro vasi!
Fortunatamente tornavamo spesso alla fattoria dei nonni. Viaggiavamo in treno fino a Oderen, un luogo di pellegrinaggio dedicato a Maria Vergine. Da lì un sentiero si inerpicava su per la montagna, costeggiava un fresco ruscello montano, poi saliva bruscamente, arrampicandosi lungo un pendio scosceso, fino a Bergenbach, una pianura verdeggiante ricoperta da diversi tipi di alberi da frutto.
La fattoria dei nonni si trovava tra rocce, felci e boscaglia. Oltrepassata la minuscola porta, occorreva qualche istante prima che gli occhi si abituassero alla penombra e potessero distinguere in un angolo l’ampio camino nero, dove era stata installata una grossa cucina a legna. L’odore del fumo mescolato all’aroma del fieno e dei cereali era per il mio olfatto la fragranza più gradevole. Fuori c’era una fontana di pietra: il placido gorgoglio delle sue acque era stato la dolce ninnananna di tante generazioni.
Negli anni ’90 del XIX secolo la mia nonna Maria aveva lasciato la casa paterna per ritornarvi da vedova con le sue due bambine, Emma ed Eugénie, rispettivamente mia madre e mia zia. Dal secondo marito, Remy Staffelbach, aveva avuto altri due figli: mia zia Valentine e mio zio Germain. Remy era un vero nonno per me.
La nonna era una persona dinamica: dalla mattina alla sera si prendeva cura degli animali della fattoria e si occupava del giardino, mentre gli uomini si guadagnavano da vivere altrove.
La mansione del nonno consisteva nel preparare i colori in una stamperia tessile e zio Germain lavorava in una cava. La nonna era sempre in ansia per lui. Siccome era sordo, temeva che non si accorgesse del segnale che precedeva lo scoppio della dinamite con la quale venivano fatte esplodere le rocce. Così ogni volta che sentiva un boato provenire dalla cava – in qualunque luogo si trovasse e qualsiasi faccenda stesse sbrigando – si fermava e recitava una preghiera per suo figlio. Con le lacrime agli occhi e la voce tremante, la nonna mi narrava spesso la solita storia: “Siccome tua madre voleva diventare suora missionaria in Africa, ci siamo recati al convento per avere informazioni, ma la dote richiesta era troppo alta. Avremmo dovuto vendere tutte le nostre mucche…” Ogni volta che riascoltavo quel racconto mi domandavo se, per servire Dio, fosse necessario un tale sacrificio.
“La famiglia ha preso allora la decisione di mandare la tua mamma a lavorare e di usare parte del suo guadagno per le spese del collegio per sordi dove Germain stava conseguendo un’istruzione scolastica. Così è diventata tessitrice di stoffa damascata e ha incontrato tuo padre, Adolphe, un artista orfano e senza soldi, non un agricoltore purtroppo, ma almeno un buon cattolico!”
Non avevo difficoltà a comunicare con zio Germain. Mi piaceva il vivace linguaggio dei segni che lui stesso aveva ideato.
Lo zio possedeva una decina di alveari e sapeva lavorare il legno, scolpire la pietra e innestare le piante. Durante le nostre visite alla fattoria ci mostrava sempre, con un largo sorriso di autocompiacimento, la sua ultima creazione. La sua più grande gioia consisteva nel rendersi utile. Era molto legato a sua madre e come lei era molto religioso. Anch’io lo ero!
La nonna doveva essere stata molto bella da giovane. L’età non aveva assolutamente scalfito il fascino dei suoi bei lineamenti armoniosi. La sua abbronzatura attenuava l’azzurro intenso dei suoi occhi. I capelli bianchi, raccolti sulla testa in una piccola crocchia, alla luce del sole brillavano come un’aureola. Durante la settimana, la nonna indossava un austero vestito nero protetto da un ampio grembiule, invece la domenica metteva un allegro abito a fiori rosa e lilla, che addolciva il suo viso serio.
Nel corso degli anni la nonna Maria era diventata un po’ robusta, eppure ciò non le impediva di affaccendarsi lentamente, ma senza posa. Appena entravo in cucina, iniziava una vivace conversazione: “Adesso prepariamo la zuppa di patate per il maialino”. Le schiacciava con le mani. “Ora vi aggiungiamo un po’ di crusca, gli avanzi del pranzo, ovviamente senza ossa, e il latticello del formaggio. Vieni, piccola mia, versiamo il tutto nella mangiatoia”. Il naso rosa del maialino si tuffava nella zuppa: ch-ch-ch. “Guarda questo sciocco che cerca prima i pezzi migliori!”
Le galline si radunavano di fronte alla porta della cucina. “Devono essere le cinque. Buttiamo una manciata di grano anche per loro!”
“Sciò! Sciò!”, gridava battendo le mani per tenere indietro i polli più forti che volavano addosso agli altri. “Hai visto, piccolina? Sono proprio come le persone: non hanno nessuna considerazione per i più deboli!”
“Ora è il turno dei gatti. Micio, micio! Venite, ecco il vostro latte”. Era la schiuma del latte della mucca che il nonno aveva appena munto. Ne avevo già gustato la mia parte in una ciotola nera, la mia tazza personale. Una delle micie lasciò prima bere il suo piccolo. “Vedi, questa sì che è una vera mamma!” I gatti venivano a strofinarsi contro le nostre gambe e facevano le fusa. “Guarda come ci ringraziano tutti!”
Appena possibile i miei genitori e io trascorrevamo le domeniche a Bergenbach. Che privilegio per me accompagnare il nonno a messa! Zio Germain usciva di casa sempre dopo di noi, ma in qualche modo arrivava in chiesa per primo! Dopo la funzione andavamo tutti e tre al bar, dove gli uomini del villaggio si ritrovavano a discutere quasi sempre di politica e del loro bestiame:
“Ho comprato una mucca dal venditore”.
“Da quale? Dall’ebreo o dall’alsaziano?”
“Dall’ebreo, e mi ha imbrogliato di nuovo!”
“Perché non vai dall’alsaziano?”
“Beh, sai, è troppo caro! Esagera sempre sulla qualità dell’animale e poi gonfia il prezzo. È disonesto!”
Non riuscivo a seguire il loro ragionamento: se non sopportavano gli ebrei, perché preferivano comunque rifornirsi da loro? Secondo me non aveva senso.
Risalire la montagna per tornare a Bergenbach in piena estate e sotto la canicola di mezzogiorno era, a detta della nonna, un sacrificio che dava maggior valore alla nostra partecipazione alla messa. Sicuramente aveva ragione, però io avrei preferito che non facesse così caldo!
Il viso del nonno era rosso quasi quanto i suoi capelli. Indossava un completo di velluto marrone scuro e teneva la catenella dorata dell’orologio infilata nel taschino della giacca che portava sempre sbottonata; con un fazzoletto si asciugava continuamente il sudore dalla nuca. Zio Germain, correndo come una gazzella su per la salita, ci precedeva e, una volta a casa, si nascondeva e ci aspettava. Quando arrivavamo nelle vicinanze, saltava fuori, accogliendoci con la sua caratteristica risata simile a un nitrito.
La nonna assisteva alla prima messa del mattino, così rincasava in tempo per preparare i suoi deliziosi pranzetti domenicali, incluso ogni tipo di dolce casereccio. Durante i pasti le conversazioni erano sempre animate e interessanti e, fintantoché a tavola eravamo in sei, rimanevano pacifiche. Era tutt’altra cosa quando zia Valentine, la figlia più giovane della nonna, veniva in visita con suo marito Alfred e mia cugina Angèle. Alfred, un uomo di statura alta, monopolizzava la conversazione: sapeva tutto su tutto! Mentre lo zio parlava e parlava, mio padre restava in silenzio. Questo proprio non mi piaceva: il papà era ben più in gamba. Perché non interveniva?
Sembrava che zio Alfred provasse piacere nel suscitare polemiche e ci riusciva senza difficoltà, parlando di argomenti irritanti. Il nonno disapprovava il rigore autoritario dei tedeschi. Aveva prestato servizio nella marina per quattro anni e aveva visto con i suoi stessi occhi alla punizione dei marinai ribelli: veniva legata loro una corda intorno alla vita e poi, gettati in mare, erano trascinati dalla nave per ore intere. Quei marinai – pensavo fra me – dovevano essere degli eccellenti nuotatori, per reggere una simile velocità!
La nonna criticava sempre i francesi, perché li considerava dei fannulloni. Non aveva dimenticato che durante la Grande Guerra soldati francesi a corto di cibo avevano requisito le sue mucche e nessuno l’aveva mai risarcita della perdita. Al contrario aveva solo parole di ammirazione per i recenti successi di Hitler in Germania.
Al termine di questi dibattiti il nonno sembrava rimpicciolirsi e la nonna diventare più grande. Le mani di lei si irrigidivano per la collera, mentre raccoglieva bruscamente i piatti da dessert dalla tavola. Quelle stoviglie antiche, decorate con minuziosa finezza, erano bellissime e io temevo che un giorno ne avrebbe ridotta qualcuna in cocci con uno dei suoi gesti troppo energici.
Dopo il dessert Angèle e io sparivamo all’aperto per giocare. Avevo costruito una bambola. A una piccola patata ben rotonda, la testa, avevo incastonato due piccole pietre a mo’ di occhi. L’avevo fissata con un bastoncino a una carota, il corpo, mentre il vestito era una grossa foglia. Mia cugina, una pura cittadina, non apprezzava la mia bambola artigianale. Preferiva sdraiarsi e subito i suoi occhietti blu si chiudevano. Le sue ciglia rosse sembravano delle cuciture a sopraggitto e la boccuccia imbronciata era come una fragolina. Le gote rotonde, belle e rosse incorniciavano un nasino cosparso di lentiggini e i magnifici boccoli dei suoi capelli ramati si spandevano sull’erba verde come raggi di sole. Col suo delicato vestito blu ornato di nastrini diventava la mia bambolina che richiedeva le mie cure. Cercavo una grossa foglia da usare come parasole, poi mi sdraiavo anch’io per terra sotto la felce, godendo del suo profumo familiare. Da quella posizione ascoltavo il ronzio delle api e seguivo con gli occhi la pigra sfilata delle nuvole o l’improvviso balzo di una cavalletta. Immersa in quella pace, riflettevo sulle conversazioni degli adulti cercando di capirne il senso.
♠♠♠
Un giorno la nonna mi regalò un’altra piccola immagine sacra da aggiungere alla mia collezione. Quando mio padre la vide, il suo viso tondo sembrò allungarsi. Inarcò le sopracciglia sbarrando gli occhi e serrò le labbra perplesso. Lessi sul suo volto un grosso punto interrogativo. L’espressione della mamma invece non era né seria né sorridente. Gli angoli della sua bocca si abbassarono e gli occhi fissarono il vuoto. Fece un piccolo cenno con la mano destra e stese tutte e cinque le dita. I miei genitori non erano entusiasti della mia immagine sacra!
“Mettila nel tuo messale”, mi ordinò il papà. Avevo già ricevuto quel messale bianco, ricoperto di madreperla, molto prima di iniziare la scuola. “No!”, replicai risoluta. Quell’immagine benedetta dal prete era un dono della nonna; volevo metterla sull’altare della mia cameretta. “La nonna ha detto che scaccerà gli spiriti cattivi”, protestai. “Lei stessa ne ha appese diverse persino sopra la porta della rimessa!”
Il papà non andò oltre. Lasciò l’ultima parola alla mamma che mi permise di sistemare l’immagine sul mio altare personale. Così mi andava bene. Da quando aveva comprato una nuova macchina da cucire, lei lavorava nella mia cameretta e quindi il nuovo santo avrebbe protetto anche lei.
Seduta sul pavimento col mio orsacchiotto di peluche, rimanevo affascinata dalla grossa ruota della macchina da cucire che la mamma azionava con i piedi. Nessuno avrebbe potuto farlo più velocemente di lei! Adoravo il rumore dei pedali accompagnato dal suo canticchiare. Che soave melodia! Ero incantata vedendo quelle stoffe trasformarsi in splendidi vestiti e in camicie stupende che facevano di mio padre un gran signore.
♠♠♠
Giugno 1936
Un giorno la mamma smise di canticchiare. Camminava avanti e indietro con un’andatura stanca, poi si fermava, nascondendo il volto fra le mani. Di tanto in tanto si alzava e andava a guardare fuori dalla finestra. Quando le domandai: “Mamma, non stai bene?”, scosse la testa e si voltò. Mi sedetti accanto a lei e mi accarezzò i capelli.
Il papà si era recato al lavoro alle tredici e trenta per il turno pomeridiano. lo aspettai inutilmente che mia madre giocasse con me come di solito. Arrivò poi l’ora di andare a letto. La mamma mi accompagnò in cameretta e mi diede l’acqua santa per fare il segno della croce. Recitò una preghiera e, prima di rimboccarmi le coperte, mi baciò teneramente.
Di solito la mamma chiudeva le persiane, ma quella sera si sedette sul bordo del mio letto e rimase in silenzio. Pian piano calarono le tenebre e la luce della luna le illuminò i capelli neri e mossi. La sua carnagione di porcellana aveva assunto un colorito ancor più pallido. Non riuscivo a vedere i suoi occhi blu scuro, ma li sentivo su di me. Lentamente il suo profilo si dissolse. Mi addormentai alle otto, l’orario in cui abitualmente andavo a letto.
Spesso mi svegliavo alle dieci e un quarto di sera, disturbata dal rumore delle biciclette degli operai che tornavano a casa dalla fabbrica. Sentivo il papà mentre sistemava la sua nel garage e saliva gli scalini di legno che scricchiolavano sotto i suoi piedi. Poi faceva girare la chiave nella serratura e apriva la porta il più silenziosamente possibile. La mia cagnolina Zita, che dormiva nel bagno vicino all’entrata, lo accoglieva festosamente e lo seguiva in cucina. Lì il papà si toglieva le scarpe, infilava le pantofole e appendeva la giacca. A quel punto tiravo su la coperta del letto fino al naso e serravo forte gli occhi. Ed ecco il magico momento in cui il papà entrava nella mia stanza, si chinava su di me, sfiorava il mio viso col suo respiro caldo e posava sulla mia fronte un bacio leggero come una farfalla. Le sue mani accarezzavano i miei capelli corti e, mentre fingevo di dormire assaporando intensamente quel soave istante, sentivo su di me il suo sguardo pieno di amore.
Quella notte, invece, mi svegliai improvvisamente con l’angosciante sensazione di essere sola. Chiamai disperatamente e la mamma accorse subito in camicia da notte e con i capelli ondulati raccolti in una retina.
“Dov’è il papà? Non è venuto a darmi il bacio della buona notte!”
“Sst, sono le tre passate. Il papà deve dormire e anche tu!” Si sedette vicino a me accarezzandomi i capelli intrisi di sudore per il panico.
Il mattino seguente il papà non era seduto con noi a tavola per la colazione e non c’era neppure la sua tazza.
“Il papà starà via per qualche giorno”, mi disse la mamma con voce tremula, trattenendo a fatica le lacrime.
Il mio papà ci aveva lasciate! Se n’era andato! Ecco perché negli ultimi tempi mi era sembrato così triste, teso e preoccupato. Ricordai una recente conversazione tra lui e la mamma. “È stato un errore! Non sarebbe dovuto accadere!”, le aveva sussurrato, pensando che non li sentissi. “Adolphe, non ti preoccupare! Può capitare a chiunque di sbagliare!” Come aveva osato la mamma accusare il papà di avere commesso degli errori? Lui non sbagliava mai. Ne ero sicura! Doveva essersene andato via mortificato da quell’offesa.
Ma dove poteva essersi diretto? Sicuramente a Kruth, il villaggio situato in fondo alla valle. Era uno dei miei luoghi preferiti. Avrei voluto fuggire con lui, lontano da quella mamma così meschina.
A Kruth viveva Paul Arnold, zio e patrigno del papà. Io lo chiamavo “nonno-padrino”. Aveva l’abitudine di stare in piedi con la mano destra appoggiata allo stipite della porta, proprio sotto la croce scolpita nell’architrave di pietra, dove erano state incise delle cifre. Quando sorrideva, i suoi occhi sparivano fra le rughe del viso. Era così vecchio e rugoso che assomigliava a un pruno! Portava i calzoni arrotolati più volte attorno alla cintura. Avrei tanto voluto essere da lui!
Perché il papà non mi aveva portato con sé?
Invece me ne stavo lì imbronciata nella mia cameretta e poco dopo iniziai a piangere.
“Adolphe, Adolphe, sei riuscito a tornare a casa!” La voce eccitata di mia madre mi fece sussultare. Stavo sognando? Balzai in piedi e mi precipitai fra le braccia di mio padre; intanto la mamma corse in cucina a preparargli un pasto caldo.
Il papà ci spiegò l’accaduto: “Gli operai della fabbrica hanno scioperato fermando le presse senza neppure togliere la stoffa dalle stampanti! Tutti sono corsi fuori precipitosamente, ma chi indossava le camicie bianche è stato costretto a rientrare. Alcuni sono stati perfino picchiati! Nessuno poteva più entrare o uscire1 ”.
1 In seguito alla vittoria del Fronte Popolare nel giugno 1936, scoppiarono scioperi bianchi in diverse zone della Francia.
“E tu come hai fatto a scappare?”
“Sono andato a dormire con gli ingegneri nel magazzino dei tessuti. Da lì sentivamo gli slogan e le minacce degli operai. Vi assicuro, era veramente spaventoso! Ma sapevo che alle due del pomeriggio alcuni colleghi stampatori, coloristi e incisori sarebbero arrivati all’entrata. Quindi sono sceso. Appena mi hanno visto, hanno aperto la porta gridando: ‘È dalla nostra parte, anche se porta una camicia bianca! Lasciatelo uscire!’ Ho avuto bisogno della loro protezione a causa degli operai che non mi conoscevano”.
Mio padre aveva avuto bisogno di protezione? Aveva avuto paura? E aveva dormito in un magazzino pieno di bidoni di inchiostro senza fare una sola macchia sui suoi abiti? Non ci capivo niente!
Mangiava e raccontava con parole che non mi erano familiari. Non l’avevo mai visto così agitato. La sua faccia era tutta rossa e la voce tesa. Temevo che cadesse morto stecchito, proprio com’era successo tempo addietro a suo padre.
Continuò il suo discorso con termini inconsueti: proletariato, comunisti, socialismo, rivendicazioni, salari, diritti umani, classe dirigente, fiducia.
A un certo punto non ne potei più di tutto quel parlare febbrile. Uscii sul balcone. La luce della cucina rischiarava le petunie blu e bianche e i gerani rossi, ma la notte aveva zittito il canto degli uccelli e il ronzio delle api.
“Guarda, papà! Il cielo ha di nuovo indossato il suo mantello di velluto nero trapunto di diamanti”.
Allora lui smise finalmente di parlare e mi raggiunse. Mi sollevò fra le sue braccia, mentre la mamma sparecchiava la tavola.
“Simone, quei diamanti lì sono stelle. Sono molto, molto grandi e anche tanto lontane”. Ne indicò alcune sopra la nostra testa e proseguì: “Le vedi quelle quattro disposte in quadrato con le altre tre che formano una coda?”
“Oh, sì! È una pentola”.
“Si chiamano Orsa Maggiore”.
“Non riesco a vedere l’orsa!”
“Non riesci, perché non puoi vedere tutte le stelle che la formano”.
“Oh! Adesso ho capito, l’orsa è nella pentola!”
Da quella sera continuai a scrutare il cielo stellato per cercare di trovare l’Orsa Maggiore, ma la pentola rimaneva disperatamente vuota.
♠♠♠
Estate 1936
La mamma e io avevamo trascorso le vacanze estive dai nonni. Ora la stagione calda giungeva gradualmente al termine, portandosi via le belle giornate soleggiate e la mamma aveva quasi terminato i suoi lavori di cucito. Zio Germain era estasiato dalle sue camicie nuove, il nonno era soddisfatto dei calzoni di velluto e la nonna andava fiera del suo cappello letteralmente trasformato: ornato con i fiori e quei nastri color lilla, avrebbe fatto colpo alla messa domenicale.
Per quell’anno il nonno aveva deviato un’ultima volta la fredda acqua della montagna, che serviva ad alimentare la fontana. Quella rimasta nella vasca si sarebbe scaldata al sole di mezzogiorno, così avrei potuto sguazzarci dentro con mia cugina Angèle, ma non prima del riposino pomeridiano. Mentre eravamo stese sul divano tra i quadri di San Giuseppe e della Vergine Maria, una luce soffusa entrava dalle persiane accostate; sotto erano allineati dei vasetti pieni di marmellata messa a raffreddare. Qualche raggio di sole ne faceva scintillare il contenuto rosso scuro e giallo brillante, trasformandolo in rubino e oro. Ascoltavo con piacere il ronzio delle api e delle mosche che cercavano instancabilmente di entrare dalla finestra. Quanto amavo quelle melodie! Sognavo a occhi aperti, immaginando di essere una santa in cielo.
All’annuncio della mamma: “Il papà sarà qui domani dopo la messa di Kruth!”, saltai dalla gioia.
Il mattino seguente, il nonno si alzò di buon’ora per lavarsi alla fontana. Immerse la testa e il torso nell’acqua gelida. Poi, osservando i nuvoloni neri sopra la foresta tra Oderen e Kruth, decise che quel giorno, invece di andare a messa, avrebbe messo al riparo le mucche, prima dell’arrivo del cattivo tempo sulla fattoria di Bergenbach. Ero delusa. Mi piaceva tanto accompagnare il nonno a messa!
Osservò: “Spero che Adolphe ce la faccia ad arrivare alla fattoria. Sembra che si stia avvicinando un brutto temporale”.
La nonna e la mamma tornarono di corsa dalla prima messa. Il vento soffiava così forte da obbligare la nonna a trattenere il suo cappello “nuovo”, mentre la mamma litigava col vestito. Arrivarono entrambe trafelate e sbuffando nervosamente. In quel medesimo istante, giunsero anche le mucche che si accalcavano per entrare nella stalla. In previsione di un’interruzione di corrente, zia Valentine, che quel giorno era affaccendata in cucina, iniziò a cercare tutte le candele della casa. Poi corse in giardino per cogliere qualche lattuga, prima che fossero tutte distrutte da un’eventuale grandinata.
Ancora non pioveva, ma il rimbombo del tuono segnalava l’avvicinarsi del temporale. La nonna si rifugiò nell’angolo più nascosto della fattoria col rosario stretto a sé. La sua paura era contagiosa. Angèle cominciò a piangere e sua madre a tremare. Zio Germain divenne bianco come un cencio e a gesti mi incitò a rientrare. Mi indicò il cane che era rintanato nella sua cuccia e teneva la testa fra le due zampe anteriori, implorando con i suoi grandi occhi umidi. Una sfacciata raffica di vento sventagliò le piume della coda del gallo che rientrava nel pollaio per ultimo.
Un gocciolone cadde sulla mia testa e un altro mi colpì il naso, mentre un lampo illuminò Bergenbach. “Uno… due…”, contò il nonno e il tuono rombò. “Il temporale è a soli due chilometri da qui”, concluse. Mi sedetti per terra sulla soglia che separava la cucina dalla stanza vicina e guardai il viso della mamma. Da esso traspariva la stessa preoccupazione che vi avevo letto quando il papà era stato trattenuto in fabbrica.
Poi l’acquazzone scoppiò. “Se ora si trova nella foresta, sarà pericoloso per Adolphe!” La voce di zia Valentine assunse un tono più drammatico, mentre continuava: “Se ne è già uscito, almeno non cercherà riparo sotto un albero”. Poi, rivolgendosi verso noi bambine, ci raccomandò: “Ricordatevi bene, ragazze! Non rifugiatevi mai sotto un albero quando ci sono i fulmini!” Per impedire che il bollito si scuocesse, tolse la pentola dalla cucina a legna e si rivolse a sua sorella che era rimasta silenziosa: “E se corre in cerca di un nascondiglio, il fulmine potrebbe colpirlo!” Mentre alimentava il fuoco con un ceppo umido, continuò il suo monologo: “E non si deve mai correre, mai usare l’ombrello!”
La mamma vagava da una parte all’altra della cucina, così come la scodella del cane, trascinata qua e là nel cortile dalle raffiche di vento.
Una figura si profilò vicino alla vigna e si diresse fin verso l’entrata. Era il mio papà, bagnato fradicio tanto da sembrare alto la metà. Ma che sollievo provammo quando varcò la soglia!
Cadde un fulmine, seguito da un tuono così repentino da non avere nemmeno il tempo di contare. “Questo ha colpito proprio la roccia dietro casa!”, sentenziò il nonno. Vidi il papà entrare in cucina ancora tutto ricurvo per ripararsi dalla pioggia e dal vento. Si raddrizzò, prestando attenzione a non urtare il paralume di porcellana appeso al soffitto. La mamma lo aiutò a togliersi la giacca bagnata e andò a prendergli dei vestiti asciutti; intanto zia Valentine gli porse una scodella di zuppa calda.
Il papà iniziò a mangiare. Chiese a zio Germain una sigaretta anche se, come tutti gli altri, aveva condannato vigorosamente il giovane abate della parrocchia, che fumava segretamente. Alla parete era appeso un accendino elettrico. Nel preciso istante in cui il papà lo stava usando per accendere la sigaretta, un fulmine colpì il melo cresciuto di fronte alla casa, proprio accanto alla linea elettrica. Mio padre fu scaraventato verso il soffitto e ricadde violentemente sulla schiena. Tutti gridarono: “Adolphe, Adolphe!”
Zia Valentine accese subito delle candele. Sotto quella luce tremolante scorgemmo il papà disteso sul pavimento, pallido come un cadavere.
“Respira”, costatò zia Valentine rivolgendosi alla mamma riapparsa proprio allora con i vestiti asciutti. Entrambe le sorelle esclamarono: “Oh Dio mio, grazie!” A poco a poco il papà riaprì gli occhi.
“Riesci a muovere le gambe?”
Il papà provò e ce la fece. Io invece no: ero paralizzata dall’emozione.
“Tutto a posto, mi gira solo un po’ la testa”, disse, e per rassicurarci si alzò, appese i suoi abiti bagnati e infine bevve un’intera scodella del famoso brodo di carne della domenica.
Un altro fulmine ci fece rabbrividire, ma fortunatamente cadde più lontano e colpì l’altra parte della vallata. Poi l’acquazzone cessò. Le piante del giardino giacevano a terra appesantite dalla pioggia, quasi dovessero riposarsi da quell’estenuante intermezzo. La nonna sbucò dal suo nascondiglio, si diresse immediatamente verso l’acquasantiera e si fece il segno della croce. “Siamo sfuggiti per un pelo a un incendio, con tutto quel fieno secco depositato in soffitta!”
La calma dopo la tempesta sembrava aggiungere a quel pranzo festivo un sapore insolito. La nonna tracciò col coltello una croce sulla pagnotta fresca e poi tagliò delle grosse fette per ognuno dei commensali. Fuori gli alberi emersero lentamente dalla nebbia come fossero dei fantasmi.
“Bambine, se volete giocare, potete andare in solaio”, ci concesse la nonna. Era una fortuna, perché lassù potevamo evitare tutte quelle noiose conversazioni degli adulti sugli scioperi.
“Prima voglio un altra fetta di torta”, pretese Angèle con tono imperioso. E gliela diedero! Se io avessi chiesto qualcosa in quella maniera, mia madre avrebbe fatto orecchio da mercante! “Le signorine non dicono mai ‘io voglio…’ – mi soleva ripetere – dicono: ‘mi farebbe piacere avere…’ o ‘vorrei…’”
Le scale che conducevano al solaio si trovavano in un angolo della casa. Sulla parte destra della soffitta era stato riposto del fieno. Sulla sinistra, in corrispondenza col soggiorno, c’era un baule dove era custodita ogni sorta di ricordini preziosi con i quali ci era permesso giocare. Attraverso gli interstizi del pavimento ci giungevano voci, fumo di sigarette e aroma di caffè. Svuotammo la parte del baule che conteneva vecchi vestiti e giocammo “alla casa” con tazze e piatti dell’Ottocento.
Da sotto sentivamo la voce della nonna: “Se fossimo tedeschi, non ci sarebbe nessuno sciopero! Dall’altra parte del Reno nessuno sciopera!”
“Rifletti!”, ribatté il nonno. “Quando la madre di Adolphe era tra i promotori del primo vero sciopero socialista, non eravamo tedeschi a tutti gli effetti? Eppure, quando andò a confessarsi, il prete la rimproverò e la schiaffeggiò, minacciando di farle perdere il lavoro se si fosse impegnata ancora in quelle attività!”
“Ma questo avveniva prima della Grande Guerra. Ora, sotto il regime di Hitler, i tedeschi hanno tutti un lavoro e una buona paga. Stanno prosperando!”, aggiunse la nonna.
La pioggia tornò a martellare il tetto. Al piano inferiore gli adulti stavano ancora bevendo caffè e liquori: vino dolce fatto in casa per le donne, acquavite forte per gli uomini.
La nonna riprese a lamentarsi: “Adolphe, è per colpa dei francesi e dei loro alleati che la moneta tedesca ha perso valore, e non perché i tedeschi siano dei lazzaroni! I francesi sono pigri – asserì – sono apatici e disorganizzati…” Parlava e parlava, ma non c’era disputa poiché nessuno ribatteva.
“Mamma, per avere un punto di vista obiettivo, sarebbe meglio che leggeste altri giornali, oltre a quelli che parlano a favore della Germania”, buttò lì qualcuno2 .
2 Alla fine della prima guerra mondiale la popolazione dell’Alsazia-Lorena era per il 75 % di lingua tedesca. Il governo francese incontrò una viva resistenza quando cercò di sopprimere i giornali tedeschi.
“Simone! Angèle! Scendete dal solaio. Non piove più!”
Qualcuno suggerì di approfittare dei pallidi raggi di sole e uscimmo tutti. Ma, appena arrivammo all’incrocio, il nonno adocchiò la cima delle montagne: “Non sarebbe prudente allontanarci troppo dalla fattoria”.
Allora attraversammo il prato fino al limite della rupe dove zio Germain aveva costruito una panca di legno e aveva piantato tre pini. La panca era troppo bagnata per potervici sedere, ma da lì si godeva il panorama di tutta la vallata: Kruth, il paese natale del papà; Oderen, il nostro villaggio; Fellering con le sue due chiese, in centro quella cattolica e in periferia quella protestante.
Ricordai che una volta avevo domandato alla nonna quale fosse la differenza tra le due confessioni. “I protestanti sono nemici dei cattolici”, mi aveva risposto.
“Figliole, dovreste affrettarvi a prendere la via del ritorno”, avvertì il nonno indicando delle nuvole violacee.
“Certo, vedete quella nebbia laggiù?”, aggiunse la nonna. “Sta salendo, il che significa che qui ricadrà sotto forma di pioggia. Se vi sbrigate, riuscirete a prendere il prossimo treno ed eviterete così di inzupparvi fino alle ossa”.
♠♠♠
Appena giunti a casa, la mamma raccolse alcuni fiori in giardino “per ridare un po’ di vita alla baracca”. Le dalie gialle e rosse disposte nel bel vaso alsaziano di creta grigia con motivi blu crearono subito un ambiente accogliente e facilitarono il nostro ritorno alla vita cittadina.
“Vieni Simone, andiamo sul balcone a riordinare le petunie”.
“Mamma, guarda! Il pezzetto di zucchero è sparito!” In effetti, prima di andare dai nonni, avevo lasciato una zolletta di zucchero sul balcone.
La mamma sorrise. “Pensi che sia stata la cicogna a portarlo via?”
“Certo!”, fu la risposta che udimmo dal balcone vicino. Era la voce della signora Huber, una nostra vicina, che aggiunse: “Lo zucchero è sparito. Adesso puoi aspettarti una sorellina o un fratellino. La cicogna ritornerà in primavera e potrebbe portarti un bimbo”.
Qui a Mulhouse i bambini venivano portati dalle cicogne; invece a Wesserling i bambini si sceglievano la mamma nascondendosi sotto un grosso cavolo. A Mulhouse non c’erano mai stati bambini nei cavoli, al massimo si trovavano dei vermi! Ero sicura che ci fosse un bambino in arrivo. Non avevo forse scelto la migliore mamma del mondo? Desideravo tanto un fratellino o una sorellina!
Ogni tanto nella nostra palazzina capitavano altri bambini. Il signor Eguemann, un vicino, aveva due nipotine che venivano di tanto in tanto a trovarlo. “Porta fuori la cagnetta e gioca con loro – mi diceva allora la mamma – e trattale come se fossero le tue sorelline”.
Ma non mi sentivo più a mio agio con loro. Il loro nonno mi guardava in malo modo ogni volta che mi incontrava, perché un giorno lo avevo sorpreso a rubare. Era successo una mattina molto presto, quando la mamma mi aveva fatta scendere per prendere il latte e il pane. Tutte le sere, le otto famiglie del nostro stabile, appendevano al muro dell’entrata il secchiello per il latte e un paniere col denaro e, mentre ancora tutti dormivano, passavano il lattaio col suo carretto trainato da due cani e il panettiere col suo cane bardato: entrambi servivano ogni focolare a seconda della somma di denaro lasciata. E quella mattina colsi in flagrante il signor Eguemann intento a frugare nel paniere di qualcun altro.
Io e la mia cagnetta Zita trascorremmo comunque dei bei momenti insieme con le nipoti del signor Eguemann. Un giorno eravamo così prese dal gioco da non sentire che mia madre mi stava chiamando per la cena. L’indomani si ripeté la stessa scena.
“Adesso ascoltami bene!”, mi avvertì. “Oggi ho dovuto chiamarti di nuovo tre volte. Che cosa penserà la gente? Che la figlia della signora Arnold è una bambina disubbidiente e che la sua mamma è troppo tollerante con lei e non riesce a farsi rispettare!” Con uno sguardo severo e la fronte corrugata sottolineò, scandendo bene le parole: “Se domani dovesse succedere di nuovo, dovremo riservarti la stessa punizione data a Brumel, la mucca ribelle”. Dopo un silenzio interminabile aggiunse: “Guai a te se devo chiamarti ancora tre volte!”
Ero avvilita e abbassai la testa. La mamma mi avrebbe veramente trattata come Brumel? Non mi aveva mai sculacciata prima e nemmeno il papà, ma sapevo che ne aveva il diritto. Avrebbe potuto attuare la sua minaccia.
Una cosa era certa: la mamma aveva un’espressione veramente seria. Ubbidire divenne improvvisamente una questione di capitale importanza. Adesso ero grande, in fondo avevo già sei anni! Così, quando sarebbe arrivata la chiamata per la cena, avrei dovuto essere pronta a rientrare.
Il giorno dopo, nel sentire la mamma mi affrettai a raccogliere i giocattoli sparpagliati qua e là. Al secondo richiamo mi precipitai verso casa, ma in quel momento una delle bambine che correva davanti a me, cadde e si sbucciò i gomiti. Ci mettemmo a piangere tutt’e due. La mamma insisté per la terza volta. Terrorizzata, lasciai lì l’amichetta e salii le scale di corsa. La porta dell’appartamento era aperta e vidi una racchetta da ping-pong sul mio letto. Mi sentii mancare. Prima che mi rendessi conto della situazione la mamma mi afferrò per il maglione, mi trascinò in cameretta, mi buttò sul letto, mi abbassò le mutandine e, senza una parola, mi diede una bella sculacciata. Poi uscì dicendo: “Quando avrai finito di piangere, potrai venire a mangiare la tua zuppa. Se aspetterai troppo si raffredderà”. Nascosi la faccia nel copriletto e piansi a dirotto. Il peggio era la vergogna del mio sedere all’aria. Ero anche amareggiata, perché la mamma non sapeva che io ero stata pronta a ubbidire!
Il campanello della porta di entrata squillò. Era il signor Eguemann: esigeva che fossi punita in sua presenza, perché secondo lui avevo urtato la sua nipotina. Ero spaventata a morte, ma la mamma rispose con voce ferma: “Signor Eguemann, la punizione di mia figlia è affar mio, non vostro!”
“Allora sarà meglio che vostra figlia non giochi più con le mie nipotine!”, concluse in tono minaccioso.
Finalmente la mamma intuì ciò che era successo e capì perché non avevo risposto subito quando mi aveva chiamata per la cena. Entrò piano piano nella mia cameretta, mi rigirò teneramente verso di lei e si sedette accanto a me sul letto.
“Mi dispiace di essermi sbagliata. Mi si spezza il cuore. Mi perdoni?”
Mia madre che mi domandava di esser perdonata! Le mie lacrime si asciugarono all’istante! “Vieni a mangiare la tua zuppa, te la riscaldo”. Anche se il mio sederino bruciava ancora, mi sentivo molto meglio. E, visto che il papà era ancora al lavoro, avevo la mamma tutta per me.
Dopo cena la mamma mi dedicava sempre tutto il suo tempo. Mi invitava nella stanzetta che i miei genitori chiamavano con orgoglio “il salotto”. C’era appena lo spazio sufficiente per il divano verde, la poltrona e il tavolino a forma di mezzaluna accostato al muro. Una grossa lampada col paralume di seta arancione, confezionato dalla mamma stessa, diffondeva nella stanza una luce calda che sapeva di tramonto. La porta era stata rimossa per poter installare una stufa nell’angolo sinistro del locale. A fianco c’era un ripiano sul quale erano appoggiati una radio e un mappamondo. Lo specchio appeso in corridoio sopra una mensolina, rifletteva il mazzo di dalie, la porta finestra del balcone e la lampada; così il nostro salottino sembrava due volte più grande. Zita amava accucciarsi dove il papà metteva di solito i piedi mentre leggeva o “viaggiava” facendo ruotare il mappamondo.
Che giornata! Avevo imparato l’importanza dell’ubbidienza e del rispetto. La mamma mi aveva anche insegnato l’umiltà: aveva riconosciuto il suo errore e mi aveva chiesto scusa. Fu una di quelle lezioni che si sarebbero rivelate di grande valore nella mia vita futura.
Mi sentii pienamente soddisfatta quando quella sera, china sul mio letto, la mamma mi rimboccò le coperte. Lo sguardo profondo dei suoi occhi blu, il tenero bacio e le sue ultime parole – le prime parole in inglese che io imparai – “Good night, my darling”, furono il punto finale di quel giorno indimenticabile.
♠♠♠
1° ottobre 1936
La fresca brezza mattutina mi aiutò a tenere aperti gli occhi ancora assonnati. Era il primo giorno alla scuola femminile e, anche se conoscevo bene la strada per raggiungerla, la mamma mi dovette accompagnare. L’edificio, una costruzione in pietra rosa a tre piani, si trovava accanto alla chiesa. Ci fecero radunare davanti alla scalinata. In cima, sul gradino più in alto, troneggiavano la direttrice e la maestra che aveva in mano una lista. Solo poche ragazze possedevano una cartella nuova di zecca. Quando avevamo comprato la mia, la mamma aveva detto: “Il cuoio deve essere di buona qualità, perché la cartella dovrà durare per i prossimi otto anni”.
“Le lezioni si terranno dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 eccetto il giovedì, che resterà libero”, si leggeva nel regolamento. “Ogni allieva dovrà munirsi di cartella da portare in spalla e di una lavagnetta alla quale saranno attaccati, mediante una cordicella, uno straccetto asciutto e una spugna umida. Dovrà indossare un grembiule a maniche lunghe abbottonato sulla schiena, abbastanza ampio da coprire l’intero vestito e avrà sul davanti due tasche, una delle quali conterrà un fazzoletto. Il grembiule resterà a scuola per l’intera settimana, ma ogni sabato sarà riportato a casa per essere lavato e stirato”. Sotto le mani di fata di mia madre presero forma un grembiulino rosa, uno azzurro e uno verde acqua: l’ennesimo prodigio con la sua macchina da cucire. E perché potessero “crescere” con me almeno per i prossimi due anni, la mamma aveva lasciato i vivagni e gli orli dei miei grembiuli abbastanza larghi.
“Simone Arnold!” Fui la prima a essere chiamata. Avanzai di un passo in direzione della signorina e alzai lo sguardo su di lei, cominciando dagli stivaletti e proseguendo verso l’alto lungo il suo vestito grigio. Aveva un aspetto imponente, come quello della madre del papà sulle fotografie del nostro album di famiglia. Il colletto di pizzo bianco e i capelli di un grigio cenere, legati all’indietro, facevano apparire il suo volto rotondo come una luna piena. Dietro i cerchi degli occhiali i suoi occhi blu acciaio mi ricordavano quelli di mia madre. Da ognuno dei porri che punteggiavano il suo viso usciva un pelo, proprio come quelli di zia Eugénie. Era una signora attempata come la nonna Maria, però esternava la stessa autorità del papà! Mi sentii perfettamente a mio agio, poiché in lei vedevo l’insieme dei tratti di coloro che amavo.
La signorina mi assegnò il posto accanto a Frida. “Questo banco è ancora abbastanza nuovo e non ha nessuna macchia di inchiostro. Visto che sei fra le più piccole, siediti qui in seconda fila”. Capii subito che avevo la sua approvazione. Quel primo giorno volò.
Nella mia via abitavano quattro mie compagne di classe. Al rientro da scuola passavamo prima dalla casa di Frida, poi dalla mia palazzina, mentre Andrée, Blanche e Madeleine vivevano un po’ più lontano. Frida tremava continuamente come una foglia di pioppo. Sentivo di doverla proteggere. Era molto gracile. Con i capelli biondi, la pelle diafana, le guancette rosee e le occhiaie nere sotto gli occhi brillanti sembrava particolarmente fragile.
“I bambini con grembiuli grigi oppure blu scuro vengono da famiglie povere”, mi aveva spiegato la mamma. Quelli di Frida non solo erano blu, ma anche senza forma e rattoppati e la sua cartella era logora.
Noi cinque andavamo a scuola tutte insieme: percorrevamo la Rue de la Mer Rouge per circa un chilometro. Dopo una prima curva giungevamo alla stazione ferroviaria, procedevamo lungo un quartiere operaio e passavamo davanti alla panetteria, alla merceria, alla drogheria e infine alla latteria. Da quel punto il nome della via diventava Zu-Rhein, dal nome di una famiglia di nobili la cui residenza si trovava sulla destra, immersa in un esteso parco. Sulla sinistra c’erano delle stupende ville con ampi balconi.
“Adolphe, hai letto la circolare?”, domandò la mamma. Veniva comunicato che il venerdì l’intera classe, senza alcuna eccezione, avrebbe dovuto fare una doccia. Alle allieve sarebbero stati forniti gratuitamente un costume da bagno e del sapone. Alle dieci tutte le bambine che venivano da famiglie sostenute da sussidi sociali avrebbero ricevuto una scodella di latte e un panino.
“Ai miei tempi non avevamo tutte queste agevolazioni – disse il papà – ma non mi meraviglio. Muhlouse è una città socialista”.
“Papà, che cos’è una città socialista?”
“È una città dove i lavoratori si uniscono per difendere i loro diritti e combattono per ottenere delle condizioni più giuste. Il loro stipendio è così basso che si tratta di un’ingiustizia lampante”.
“Papà, che cos’è un’ingiustizia?”
Il papà additò un quadro a olio alto mezzo metro appeso in salotto. Rappresentava un pastore che recitava l’Angelus a mezzogiorno. Lo aveva dipinto lui a quindici anni, quando frequentava la Scuola di Arti e Mestieri. “Era stato esposto durante una mostra di lavori degli allievi e aveva ottenuto il voto più alto. Ma, quando distribuirono i premi, ricevetti la medaglia d’argento anziché quella d’oro. Il mio patrigno si recò dal direttore della scuola per chiedere spiegazioni”. Il papà si sedette, mi prese in braccio e con tono amareggiato proseguì:
“Simone, non dimenticare mai la risposta del direttore: ‘È semplicemente impensabile dare una medaglia d’oro a un ragazzino che viene dalle montagne e il cui nome non significa niente per nessuno. La medaglia d’oro è già stata assegnata al figlio del signor Tal dei tali, che ci sostiene finanziariamente ed è un uomo conosciuto in città!’” Seguì un lungo silenzio.
“Il direttore aggiunse perfino: ‘Se non le va bene, posso riprendermi la medaglia d’argento’”. Io aprii il cassetto e osservai quella medaglia, mentre il papà ripeteva: “Ingiustizia, ecco contro che cosa si devono battere gli operai. Essere socialisti significa proprio questo”.
♠♠♠
Nel cortile della scuola l’albero di tiglio stava ingiallendo. Il vento gli strappava via le foglie e le sparpagliava qua e là ancor prima che noi stesse riuscissimo ad afferrarle per giocare. Ma Frida non correva mai dietro le foglie. Si limitava a guardarci giocare standosene seduta, mentre mangiava il panino con burro e marmellata che io avevo scambiato col suo pezzetto di pane asciutto. Non mi sentivo a mio agio col grembiule rosa. Non volevo essere considerata una “bambina ricca”.
“Sembri stanca, Frida”, le dissi preoccupata.
“È solo che non mi piace il vento”, rispose tra due colpi di tosse.
“Dove lavora tuo padre?”
“Nel suo giardino”.
“Ma allora non può ricevere un salario, vero?”
“No. È invalido”.
Decisi di indagare su quella strana attività. Nemmeno lei era in grado di spiegarmelo. Era troppo timida. Un lunedì mattina non si presentò a scuola. Quando passai davanti a casa sua, le persiane delle finestre che davano sulla strada erano chiuse come sempre. Fortunatamente quel pomeriggio Frida venne a scuola. Mi era mancata tanto e avevo offerto la mia merenda a un’altra ragazzina. Con quale coraggio avrei potuto mangiare il mio panino col burro davanti a tante bambine così povere?
Il lunedì seguente ricominciò a piovere e Frida era nuovamente assente. “È fatta di zucchero?”, mi domandai. Perché mai aveva paura della pioggia? Le mantelline col cappuccio, i capelli bagnati e le scarpe inzuppate diffondevano nell’aula un odore di stalla. Quel mattino dalle quattro grandi finestre non riusciva a penetrare sufficiente luce. E durante il rituale appello le lampadine sotto i paralumi di porcellana ci rischiaravano a malapena.
Venendo a scuola avevamo visto i pompieri, l’ambulanza e la polizia, e ora Blanche e Madeleine ne parlavano animatamente. “Sta arrivando la signorina!”, avvertì qualcuno. Ci precipitammo tutte ai nostri posti per riporre il materiale in ordine sui banchi: la lavagnetta di ardesia con la cornice di legno bianco ben lucidata, la spugna pulita e il fazzoletto piegato accuratamente. Anche le nostre dieci dita dovevano allinearsi alla perfezione sul banco. All’arrivo dell’insegnante piombò improvvisamente il silenzio, come quando si spegne una radio. L’ispezione richiese parecchio tempo perché la signorina esaminava tutto: le scarpe, le gonne e perfino le orecchie!
Quel giorno non riuscivo a togliermi dalla mente l’agghiacciante spettacolo osservato nello Steinbächlein, il fiume che scorreva dietro casa nostra per poi sparire sotto terra. Qualcosa di azzurro veniva trasportato dalla corrente e due uomini cercavano di tirarlo fuori con dei ganci. “Simone, presto, entra in casa!”, mi aveva ordinato la mamma. Più tardi avevo sentito i vicini commentare la scomparsa di due gemelli di tre anni. Il corpo di uno era stato ritrovato, mentre quello dell’altro era stato inghiottito da un mulinello gorgogliante.
“Mamma, dove sono ora i gemelli?”
“Si trovano in cielo, sono degli angioletti”.
Mentre camminava tra le file, la signorina ci avvisò dei pericoli del fiume. “La riva può essere traditrice. Il suolo può cedere sotto i vostri piedi”. Comprendemmo subito che quel giorno non ci avrebbe parlato come il solito dei santi, della loro vita o dei loro sacrifici, ma dell’annegamento e della morte. Ero molto dispiaciuta di perdere la lezione di religione.
Quando tornavamo da scuola nel tardo pomeriggio, ero sempre triste di lasciare Frida davanti a casa sua. Non aveva la mamma ad aspettarla, né una dolce musica di benvenuto, niente tè per riscaldarla né una bevanda fresca per dissetarla, neppure un cagnolino che l’accogliesse festoso. Invece io avevo la mia mamma ad attendermi al ritorno. Nelle giornate di pioggia mi faceva sempre trovare il catino con l’acqua calda per un pediluvio e una deliziosa fetta di pane con della marmellata.
Mi piacevano anche le conversazioni confidenziali tra noi due. Potevo aprirle il mio cuore e rivelarle tutto, o quasi. Avevo un piccolo segreto: provavo un’ammirazione travolgente anche per un’altra donna, ma, siccome temevo di farla ingelosire, avevo deciso di non parlargliene. Una giovane signora si era trasferita nel nostro quartiere. Ammiravo la sua bellezza e la sua eleganza. Divenne il mio modello. Ogni giorno, alla stessa ora, passava sotto casa nostra e io mi precipitavo alla finestra col batticuore per scorgerla. Quanto avrei voluto vederla da vicino!
Il papà prendeva molto sul serio i miei compiti. Non accettava nessuno scarabocchio e se ce ne erano mi faceva ricominciare il lavoro, anche se mettevo il broncio. Amava ripetere: “So che puoi fare di meglio. Non dimenticare che porti il mio nome”. Esercitava la sua autorità in maniera dolce e piacevole. I rari momenti di ribellione mi facevano sprofondare dalla vergogna. Allora dicevo fra me: “Perché tenere testa a un papà così tenero?”