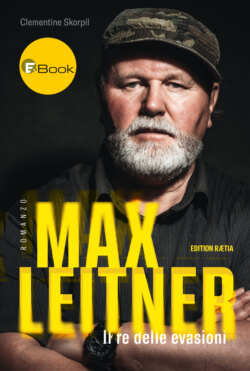Читать книгу Max Leitner - Clementine Skorpil - Страница 11
IL VALZER DELLA BIONDINA
ОглавлениеAndare alla scuola elementare di lingua italiana fu solo un breve sollievo prima che i miei genitori mi comunicassero una nuova, funesta notizia. Le persone sfortunate imparano presto a leggere i volti di coloro che popolano il loro mondo. Cattive notizie come “Andiamo a trovare tuo cugino Stefano, fa’ il bravo con lui!” sono date con un’aria seria. Le sopracciglia si aggrottavano, le guance tremavano, la pelle diventava rossa fino alla radice dei capelli: voleva dire arresti domiciliari o divieto di vedere la televisione. In questo caso, però, mentre mi toglieva la terra da sotto i piedi mia madre aveva un’aria raggiante. Raggiante come se stesse per dirmi che potevo andare a vedere la finale di Coppa dei campioni o che Pelé mi aveva invitato in Brasile. Non presagivo niente. E non volevo crederci, mi sembrava uno scherzo, una storiella. Invece non era così: la mamma era incinta, non ero più l’Unico.
In quell’istante finì la mia infanzia. Da allora mia madre non si sedette più con me a fare i compiti, non mi mise più a letto, non mi lesse più niente ad alta voce. E da allora sentii quella frase, la frase che ho giurato di non dire mai ai miei figli: “Quando avevo la tua età…”. Sì, papà, quando avevi la mia età hai sgobbato sui libri perché questo ti dava gioia. Perché eri contento quando vivevi tra i libri e non tra le persone. Ma io, papà, volevo stare fuori a giocare a calcio, leggere i fumetti e guardare i cartoni animati in tv. Io, da solo.
Dopo un anno e mezzo arrivò un altro marmocchio. Violetta. Mio fratello non sperimentò mai l’orrore di trovarsi accanto un fratello senza volerlo. Lui era felice, era uguale a papà. Paolo sapeva leggere già prima di andare a scuola. Era contento di andarci, alla fin fine in lui inclinazione e dovere si sposavano alla perfezione. Ma Violetta era la più felice perché poteva fare quello che voleva. Quando studiava i miei genitori erano orgogliosi, quando non studiava la trovavano dolce, estrosa e affascinante.
Quello che non viveva affatto una vita idilliaca ero io. Trascorsero anni densi e oscuri come la pece, su cui da lontano sventolava la bandiera a scacchi del traguardo con un numero: sedici. Sedici anni e un motorino. Tutti erano sollevati quando lo ero io. Il goffo sbattere delle mie membra troppo lunghe in un ambiente che mi sembrava ostile, la svogliatezza, la scontrosità, il sentirmi diverso, la rabbia che provavo avevano un nome: pubertà. Che aveva appunto i suoi difetti: membra troppo lunghe, svogliatezza, rabbia. Invidiavo i ragazzi che studiavano in collegio, perché su di loro la melassa della famiglia si riversava solo nel fine settimana.
Andammo in auto fino a Lasa, dove c’è un acquedotto. Pardon, un impressionante acquedotto. Papà favoleggiò di antiche tecniche idrauliche, ci spiegò che gli Etruschi, che se ne intendevano parecchio, a Roma avevano costruito la Cloaca Maxima. Paolo lo ascoltava attentamente, mentre accanto a loro due io ciondolavo. A mio padre non piaceva la mia faccia, e neppure a me piaceva. Avrei voluto assomigliare a Charles Bronson, e invece ero quello che in Alto Adige si definisce un Milchgesicht, uno sbarbatello.
“Perché hai quell’aria?”, mi chiese mio padre. “Non ti interessa proprio niente?”
No, niente. Ero fatto così. Cosa sarebbe potuto venire fuori da uno del genere? La cattiva strada mi si spalancava inevitabilmente davanti, così come un canale della Cloaca Maxima finiva nel successivo.
Uno strumento largamente sottovalutato nella prevenzione dei crimini sono le camminate della domenica. Invece di lasciarmi a casa, come quando andavo ancora alle elementari, mio padre aveva ricominciato a portarmi con sé.
Il giorno 20 andai in montagna, ora però vestito in modo civile. In auto papà osservò che avrei dovuto essere contento. Contento, e perché? Perché non saremmo andati da soli. Ci accompagnava un suo paziente, il direttore del club alpino di lingua tedesca. Anche mio padre era socio del club alpino, quello italiano ovviamente. Dovevamo incontrarci con una specie di Almöhi, il nonno di Heidi, che avrebbe portato con sé sua figlia. L’avevo sognata: ciabattavo su e giù per i Monti pallidi con una Heidi smorta e saccente, dalle guance incavate e dal petto completamente piatto.
Invece non era affatto smorta e non aveva le guance incavate: era bionda e somigliava a Grace Kelly. Anzi, era ancora più bella, molto di più. Ed era interessata a me più o meno quanto io mi appassionavo alla Cloaca Maxima. Il sentiero saliva, diventò persino ripido, e io avevo il batticuore. Arrivati in cima mio padre mi diede una pacca sulle spalle e farneticò qualcosa sul panorama e sulla vista limpida. Mangiammo i nostri panini e le nostre mele. O meglio: gli altri mangiarono i panini e le mele, perché io non avevo appetito.
Grace Kelly – chi l’avrebbe mai detto – era una specie di camoscio. Si arrampicava sui detriti e sulle pietre con una tale abilità da farmi venire le vertigini. A me sembrava che la notte prima i miei arti fossero cresciuti in maniera incontrollata. Così mentre i tre assi del club alpino scendevano rilassati e tenendo un buon ritmo io restavo indietro inciampando nelle mie zampe da capra di montagna dalla lunghezza spropositata, e quando arrivammo al parcheggio ero triste. Avevamo scambiato in tutto cinque frasi: io quattro, lei una.
I giorni successivi trascorsero in qualche modo. Mi mangiavo le unghie e ogni tre metri inciampavo dieci volte nei miei stessi piedi. Se fossi rimasto alla scuola elementare tedesca ormai avrei padroneggiato perfettamente la lingua.
Nel fine settimana un’altra escursione. E un’altra ancora in quello successivo. La questione era sempre se con o senza di lei. Io andavo anche se lei non c’era, per tenermi in allenamento. Imparai ad arrampicare oltre a qualche nozione di geografia, orientamento o biologia. Dopo qualche settimana riconoscevo la soldanella ancora prima che papà infilasse l’indice nel suo tenero calice violetto. Scoprii che i licheni non sono muschi che vivono in verticale ma una simbiosi tra un fungo e un’alga, che credevo vivesse solo in mare.
Furono giorni, settimane, mesi di equivoci chiariti e non chiariti. Lei aveva quattordici anni, io da poco sedici. Avevo bisogno di un motorino, più di qualsiasi altra cosa al mondo. Funziona così: le ragazzine di quattordici anni di sera hanno il permesso di andare solo dalle amiche, di cui in genere abbondano. Arrivate là qualcuno passa a prenderle per andare insieme a fare cose proibite. Preferibilmente con un’auto. O almeno con un motorino. Un landò, un aereo da turismo o un dirigibile andavano ugualmente bene. Anita era esperta, erano già venuti a prenderla due tizi in motorino.
L’anno scolastico volgeva al termine. In geografia, tedesco e biologia ero tra i più bravi e se non avessi raggiunto a malapena la sufficienza almeno in italiano e fisica sarei passato per un vero secchione. Il che non mi giovava di certo. A fine maggio mia madre mi chiese cosa desiderassi per il mio compleanno. Un motorino, che altro? Mia madre disse di no. La sua risposta mi rimbombò nelle orecchie. Perché no? Lei dipinse quadri raccapriccianti di traumi al cervello che certi ragazzi si erano procurati subendo incidenti gravi, di stati vegetativi e di paraplegici. Io non credetti a una sola parola.
I miei genitori: capitalisti, medici che guidavano un’Alfa Romeo, proprietari di una casa, e non mi concedevano neppure un motorino. La mamma bussò alla porta, disse che doveva parlarmi. Io restai nella mia stanza, almeno per il momento. Ci sono persone che sanno come si fa ad avere un motorino, e volevo essere anch’io uno di loro.