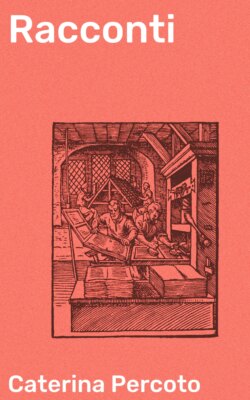Читать книгу Racconti - Caterina Percoto - Страница 3
NICCOLÒ TOMMASEO A' LETTORI.
ОглавлениеQuando una forma ci si offre di buono o di bello, giova cercare il come e il perchè la sia nata, non per imporne l'esempio ad altrui come legge tiranna, ma per dedurne un qualche documento a noi stessi. Così, vedendo negli scritti della signora Caterina Percoto lo spirito della poesia spirare dalla schietta prosa senza quasi mai ricerca d'ornamenti poetici; ricevendo dalle semplici sue narrazioni un diletto più vero che da romanzesche avventure intrigate insieme, sorge in me desiderio d'investigare per che via ella sia giunta fin là; e mi fo ardito ad esporre le mie congetture, lasciando a chi conosce più davvicino l'autrice giudicare s'io colga nel vero. Quelli che ad altri parrebbero impedimenti, dico l'essere lei vissuta lontano dalle grandi città, e nel consorzio di povera buona gente, vissuta straniera alle raffinatezze della letteratura accademica e ai solletichi di sempre nuove letture e esperienze degli uomini e delle cose; questi a me paiono appunto i sussidi che meglio la fecero quel ch'ell'è.
La educarono i sacri dolori e le gioie schiette della famiglia, nella cara loro uniformità variate, e che però meglio d'ogni rettorica insegnano a conciliare la soavità con la forza, ch'è il pregio e della virtù e dello stile. Amica e sorella alla madre, rimanendole pur sempre figliuola, in quest'affetto continuò ad educarsi, e ad apprendere il segreto difficile dell'educare lo spirito altrui. L'essere lei nata contessa le giovò non tanto alla gentilezza del sentire e de' modi che in altre condizioni può essere non meno delicata e forse più schietta, quanto al culto di certe tradizioni che la nobiltà della stirpe insegna a serbare per secoli, parte per coscienza di dovere, parte per amore d'utile che se ne abbia o se ne speri, parte per orgoglio e per vanità; ma laddove non hanno luogo le cagioni vili, quel culto partecipa della religione, ed è alla verace nobiltà de' pensieri incessante alimento. E molto più quando, come qui, la persona collocata un po' più in alto, e per il mutare de' tempi, e meglio per virtuosa e liberale volontà, e per bisogno dell'animo e della mente si volga, benevola ancor più che benigna, ai minori, non per tingerli de' propri difetti o farli servire alle proprie debolezze, ma per nobilitare e rinvigorire del loro esempio sè stessa. Cresciuta in agiatezza modesta, l'autrice di queste Novelle vide poi dì men lieti, ma forse allo spirito più sereni; e non tanto per tirannia di fortuna o per propria negligenza, quanto per elezione d'anima veramente eletta, per amore del semplice, e per istinto di quella verace uguaglianza che non condiscende se non per assumere gli altri a sè, e non ambisce appareggiarsi ne' vantaggi e ne' trastulli ma sì piuttosto ne' danni e ne' dolori, spontanea si condusse alle angustie di povera vita; e quando poteva freddamente, se non duramente, comandare, si fece a sè e ad altri, come insegna l'Amico degli uomini, ilaremente ministra; e acquistò così, non che perdere, dignità. Non è mica che la Contessa si contentasse d'andare, così per balocco e quasi per burla, a cogliere margheritine ne' prati, e chinandosi lasciasse cadere come elemosina una parola alle povere contadine, beate di quel raggio piovuto dall'alto su loro, e maravigliate che le contesse camminino su due piedi; non è già che per chiasso e come in maschera la si vestisse da contadinella e andasse ne' dì solenni a' perdoni, e quindi alle veglie, non contraffacendo ma naturalmente tenendo il linguaggio del paese, acciocchè l'umile popolo a lei non conosciuta si desse a conoscere meglio. Ma essa davvero convisse con loro, e si prestò a tutti i servigi di massaia, intanto che i nepoti lavoravano nel podere proprio; ben disgraziati se dall'incallire alquanto le mani e dall'abbronzare la faccia non acquistassero gentilezza allo spirito, e all'anima umanità. Non è dunque arcadico in lei l'amore de' campi, è patimento insieme e diletto, com'ogni affetto vero dev'essere nella vita. E dal conoscere la natura morale ne' campagnuoli le venne il poter meglio sentire, e però meglio dipingere, le bellezze della esteriore natura, non in genere o in ombra per circonlocuzione accettate da' libri, ma quali stanno ne' luoghi da essa abitati. Nè le bellezze de' luoghi potevano davvero piacerle se le fosse uggiosa la gente che vive in essi, s'ella non sapesse discernere non solo sotto i difetti il pregio, ma anche sotto i pregi il difetto; giacchè il troppo abbellire dall'un lato con la rettorica delle scuole o con quella delle conversazioni, è dall'altro un imbruttire al di là del vero e fin del possibile; e chi adula il male, da ultimo calunnia il bene, perchè smarrisce e le norme del conoscerlo e la potenza ad amarlo.
Non tanto la nascita e le consuetudini domestiche e gli studi ameni e la vicinanza di colte città e la conoscenza d'uomini ornati di lettere diedero all'autrice il poter congiungere agli ammaestramenti della natura i sussidi dell'arte, e l'uno con l'altra aiutare anzichè disservire; ma questo benefizio le venne principalmente dall'essere lei italiana, e d'una delle province del Veneto, dove, quasi al par che in Toscana e più che nelle altre, le memorie e gli abiti della civiltà sono sparsi per le campagne, e ne fanno altrettante contrade d'una medesima terra; dove i piccoli villaggi rammentano illustri nomi d'artisti e scrittori, mostrano opere d'arte invidiabili a molte capitali d'Europa, e rare in talune d'Italia stessa. Così le fu dato sentire talune almeno tra le ispirazioni e della natura e dell'arte, conciliare alcuni vantaggi e attenuare alcuni inconvenienti delle due vite diverse, e spesso per nostra colpa repugnanti, la campestre e la cittadina. Non già che le fosse possibile indovinare tutti i segreti nè della squisitissima nè della corrotta urbanità, per maniera che nel dipingere uomini e cose non famigliari a lei, la non ecceda talvolta nell'abbellire, e che, per forza d'inevitabili disinganni, la non sia tratta a giudizi severi e a diffidenze acerbe alla bontà dell'anima sua. Ma qual è l'uomo esperto di quel che chiamasi mondo nelle grandi città, che conosca a pieno e al vero tutti i segreti del cuore, che possa fedelmente ritrarli? In tutti i dipintori dell'affetto umano, anche sommi, chi ne conoscesse intera la vita, discernerebbe delle opere loro quelle parti che non in tutto si conformano a verità o per la poca esperienza o per l'osservazione non sufficientemente esatta; e chi ben riguardasse quelle opere, senza conoscerne punto la vita, ne indovinerebbe da esse un qualche arcano agli autori medesimi non conosciuto. Ma quella di cui ragioniamo, osservando riverentemente l'uomo là dov'egli è più schietto, e intravvedendolo ad ora ad ora anche là dove è meno, scelse la parte migliore; e in questo s'accosta più ai veri intenti dell'arte che spesso non faccia Giorgio Sand con le sue massime prestabilite, con la sua passione che vuol parere sistema, ed è pregiudizio; con la sua perpetua querela ribelle non tanto alle presenti condizioni della società, quanto all'eterna natura delle cose, querela di rancore più che di accoramento, più che di pietà, di vendetta.
Il pregio di questi scritti più raro (e così raro non fosse!) si è che l'autrice parla di cose a lei note per quanto si può; che non cerca almeno l'incognito a bello studio per gabbare sè stessa; come fanno taluni che si figurano che quel ch'essi non sanno debba essere ignorato da tutti, e che però tutti abbiano a farsene ammiratori sorpresi, nessuno giudice intelligente. Il reale che l'autrice si pone dinnanzi non è del più basso, nè affettatamente volgare, come in certuni che cercano col fuscellino il mostruoso dell'inerzia, l'eroico della trivialità. Ma la realità ch'ella prende a ritrarre è nobilitata, non però trasmutata, da quel senso del conveniente, ch'è l'ideale più sicuro all'artista, appunto perchè un senso tale, seguendo la legge del bene, muove dalla norma del vero, ch'è il bello sovrano. E il sentimento del bene fu in essa educato da quegli affetti di stima e di ammirazione i quali si nutrono meglio nella solitudine che nella frequenza, e sono quasi gli affetti domestici ampliati, e in nuovo modo applicabili. L'abito dello stimare con soverchia indulgenza, dell'ammirare con credula docilità, può portare disinganni e dolori; e nelle anime meno gentili qualche eccesso in contrario; ma gli è pur sempre meno pericoloso, gli è pur sempre migliore indizio dell'anima, che non sia l'abito della diffidenza, del dispregio, dello scherno. E anche in questo ella si può chiamare fortunata, che Dio la scampò dalle ammirazioni premature degli uomini, dalle lodi che, se non corrompono, fiaccano, dalle cerimonie tra galanti e accademiche, che prosificano e istupidiscono. La si venne svolgendo da sè, come germe, per naturale temperie della terra e del cielo, non per calore di stufe: i suoi primi fiori caddero a ornare quasi riconoscenti la terra che li nutrì, nè mano straniera li colse per sgualcirli con voglia irriverente. Le fu privilegio il non essere lodata troppo, il non essere tentata a far pompa dell'ingegno e dell'arte, e stemperare l'essenza del suo pensiero in volumi, come insegnarono al sesso detto debole i romanzieri del sesso forte, che d'un fiasco di vino empiono botti d'acquerello. E a non ammontare libri sopra libri le insegnò lo studiarne e l'amarne pochi; la Bibbia sopra tutti, e Virgilio. E le giovò l'apprendere la lingua tedesca sulla Messiade, e per la Messiade: poema dove Dio e gli Angeli e gli uomini parlano troppo, ma più alto e più puro che nel Paradiso perduto, come si conveniva cantando il cielo racquistato e la terra redenta.
Ho già rammentato Giorgio Sand; con la quale, fra molte differenze, ha la signora Percoto alcune conformità, ma nel bene. Essa non conseguirà mai la fama che toccò in sorte alla donna francese, più svestita forse che travestita; non la conseguirà sì perchè qui il paradosso con le apparenze della novità non colora le cose vecchie, sì perchè la fantasia qui non fa sfoggio di sè in lunghi intrecci felici; sì perchè l'Italia divisa e ignota a sè stessa non offre agl'ingegni nè le tentazioni nè i premi che la Francia; sì perchè a scrittore italiano manca lo strumento richiesto a diffondere nelle moltitudini il senso e l'affetto della bellezza, manca un linguaggio comune a tutta la nazione, determinato, vivente, che faccia con l'affetto e con l'idea, come corpo con ispirito, un ente solo. E anco qui la gentildonna, per divinazione di poeta, si fece più popolo che molti scrittori del popolo stesso non degnino: e non potendo al dialetto toscano, attinse al proprio dialetto, ch'ella scrive con garbo d'artista; e col linguaggio de' libri lo contemperò come meglio sapeva, meglio però che assai celebrati non sappiano. Sentì per istinto come nel fondo di tutti i dialetti italiani è un che di comune alla nazione tutta; come pensando il friulano pretto ella fosse men lontana dal vero toscano di que' tanti che toscaneggiano per grammatica, e sfiorettano non co' Fioretti di San Francesco (più friulani anch'essi e più milanesi e più siciliani di quel che paia), ma col Boccaccio e col Bembo. Non già che qualche o improprietà di linguaggio mezzo erudito o affettazioncella di stile quasi accademico non dia fuori anche qui, ma non frequente così come in altri: e la verità del sentire infondendosi nella schiettezza del dire, è qui tanto più notabile quanto men ricercata bellezza. Quest'è uno degli insegnamenti che noi dall'esempio di questa donna possiamo dedurre: ma il migliore, e che tutti li comprende e ne dà la ragione, si è l'indicato già, non mai raccomandato abbastanza: parlare delle cose che meglio si conoscono, di quelle che si amano, parlarne appunto nel modo che le si veggono e sentono; e a tal fine trascegliere tra le conosciute le più gentili, tra le amate le più meritevoli dell'amore di tutti.