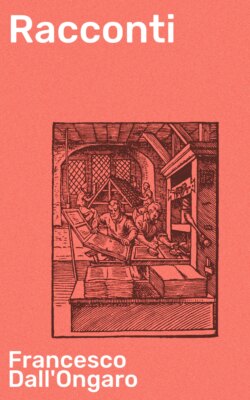Читать книгу Racconti - Francesco Dall'Ongaro - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеIndice
Terminata questa tetra istoria, narrata dall'ospite mia, con meno pretensione drammatica ma con più verità, chè tutte le sue parole uscivano vestite di quell'accento che solo può dare l'intima persuasione del vero, primo il Franceschi, e poi ciascuno della brigata si provò a dare alla conversazione un colore più gaio. Ma per quanto ognuno si sforzasse a celiare sulle antiche leggende, e non si risparmiassero le più lepide allusioni, non ci fu verso di rallegrare i nostri spiriti, tanto erano rimasti sopraffatti da quel racconto.
Intanto l'ora s'era fatta assai tarda, e m'accorsi che gli ospiti miei non erano abituati alle nostre veglie cittadinesche; onde mi credetti in obbligo di gittare una parola sull'ora tarda e sulla mia propria stanchezza. Il Franceschi alzandosi senza più, si scusò di non mi poter alloggiare convenientemente in sua casa, e disse che m'aveva fatto apprestare una camera nel castello. — Già voi, soggiunse, non m'avete faccia da spaventarvi, se pure la Donna Bianca si pensasse di farvi una visita!
— Pensate! risposi, non sarei poeta! —
Così dicendo, presi congedo dall'ospitale famiglia, e preceduto da un servo, m'incamminai verso il vicino castello.
Alzavasi fra l'ombre della notte l'immensa mole bruna, misteriosa, terribile. Il gigantesco torrione pareva una scolta che vegliasse sopra il resto dell'edificio, le cui forme mal distinte lasciavano libera la fantasia di foggiarsele sotto le più strane e mostruose figure! Entrai per una postierla che metteva per un basso ed umido corridoio alle stanze più interne. Sempre preceduto dal servo, i cui passi suonavano nel vuoto del deserto castello, passai per un numero di stanze che non presi pensiero di numerare, ma che non finivano mai. Una sala ornata dai bruni ritratti della famiglia, metteva ad un gabinetto, questo a una dozzina di camere, variamente addobbate; poi altri gabinetti, altre sale, altre camere; e il famiglio domandavami scusa di sì lunghi andirivieni, annunziandomi sempre vicina la stanza assegnatami, la quale mi sfuggiva pur sempre dinanzi. In altri tempi avrei potuto tenermi per ispacciato; ma prima che questo pensiero m'entrasse nella mente, come a Dio piacque, la mia guida fermossi, ed accese due candele in una piccola ma gentil cameretta, prescelta, ei mi disse, da non so quale dei conti attuali, più letterato degli altri, come la più silenziosa e più confacente a' suoi studi. Un letto di ferro, avviluppato da un candido padiglione, n'occupava un buon terzo, i mobili erano d'ebano, una sola finestra s'apriva a mezzodì scavata, per così dire, nella muraglia, la cui spessezza poteva ben essere di due metri.
Terminata questa rassegna, il servo si credette in obbligo di avvertirmi che appena fuori della mia stanza c'era la sua, che a caso non mi credessi solo in quell'enorme edificio. Egli pronunciò questo benevolo avviso con una cert'aria significativa, quasi con bel garbo volesse dirmi: non abbiate paura. Come io mostrai d'intenderlo, e gli risposi, sorridendo, che nulla m'occorrerebbe, egli si scusò dicendo che questa era l'abitudine del signor conte, il quale, benchè abituato al castello, pure non avrebbe osato dormirci solo. Anche un professore di Padova, soggiunse, che fu qui non ha molto per tenere a battesimo il bambino del padrone, confessò una mattina che non avea potuto pigliar sonno in tutta la notte che vi dormì. — Egli diceva, soggiunse, che l'immaginazione alcune volte suol fare di brutti scherzi. Onde, signore, ho creduto mio dovere di dirglielo. Perdoni.
Lo ringraziai, congedandolo, e mi chiusi nella mia cameretta. Rimasto solo, non potei trattenermi dal sorridere, pensando al professore ch'io conoscevo per uomo scevro di pregiudizi, cinico anzi che no, e di spiriti assai positivi. Non lo avrei detto, ma lo pensai, che alcune volte le apparenze sono smentite dai fatti, e m'apparecchiai, io suo scolaro e in odor di poeta, m'apparecchiai, dico, a far arrossire col mio fermo contegno il freddo filologo, e l'uomo, come suol dirsi, di mondo. Gli vo' domandare, dissi fra me, come prima io lo vegga, che faccia avesse la Donna Bianca, quando gli comparve al castello di San Salvadore. D'idea in idea, nel breve intervallo che dovetti passare prima di addormentarmi, venni fino a desiderarmi l'apparizione, almeno in sogno, di quell'ospite misteriosa di cui s'era tanto parlato. Così saprei s'era bianca o bruna, diss'io, e le domanderei la ragione di queste sue visite. Così dicendo, o meglio, così fantasticando fra me, mi voltai sull'altro lato, e un placido sonno sospese il corso de' miei pensieri.
— Scommetto che questo è il posto d'un sogno, dirà qualcuno de' miei lettori. Nè più nè meno; e lascerò credere a chi lo vuole che sia uno di quelli che i poeti ritrovano sì spesso e sì a tempo nel fondo del lor calamaio. Il fatto sta, che il sogno ch'io vi annunzio fu sognato davvero; ed ho mestieri di crederlo sogno, o lettori, perchè altrimenti dovrei prestar fede alle apparizioni favolose, e non potrei più ridere alle spalle del mio professore d'Università. Lascio poi la pena ai fisiologi di chiarire da quali elementi sorgesse, se dal luogo dov'io mi trovava, da quella camera solitaria, dai discorsi avuti o dalle memorie risguardanti la famiglia Collalto che avevo leggicchiato prima d'addormentarmi, e che avranno dato probabilmente una tal direzione alle idee. Checchè ne fosse, ecco il sogno.
Erano, sulle prime, figure indistinte che procedevano a coppia a coppia, non saprei dir di qual sesso. Mi parevano come persone che, nelle fitte e nebbiose notti, ci passano inavvertite da canto, e appena ce n'accorgiamo al fruscìo della veste e al batter de' passi. Ma queste apparizioni sfumavano lievi senz'arrestarsi un momento, tanto ch'io potessi raffigurare le loro sembianze. Però la processione continuava, e, come se l'atmosfera si andasse un po' diradando, le immagini mi si facevano più distinte. Erano bei vecchi dalla barba candida o grigia, vestiti di lucide armature, ciascuno accompagnato da una grave matrona, riccamente abbigliata, con baveri inamidati o bei merletti di Fiandra rimboccati dal collo. Io discerneva già bene il lor volto, ma non mi parea di conoscerli. Quando, tutto ad un tratto, ne vidi uno, la cui fisonomia m'era nota.
Era il conte Tolberto. Ecco la sua dolce guardatura, la sua aria amorevole e trista! L'antipatica dama che gli sta a fianco, e par che sdegni porgergli il braccio, non è punto da dubitarne, è Aica da Camino. Mi sembra ch'io volessi rivolger loro qualche parola, ma, come segue ne' sogni, la voce non rispondeva alla volontà. Intanto anche questa coppia era sparita, e tutto era rientrato nell'oscurità. Ma se gli occhi più non discernevano alcuna cosa nell'ombra, l'orecchio era percosso da un sordo gemito che partiva come da una tomba.
Raddoppiai l'acume della pupilla, come cercando da qual parte uscisse quel doloroso guaìto. Ma non discernevo altra cosa che una parete bianchissima, ch'io potevo scambiare con quella della mia camera. Tutt'ad un tratto la calce parea sollevarsi in un canto, e presentare alcune ineguaglianze, alcune prominenze che offerivano i contorni d'una figura umana scolpita in bassorilievo. A poco a poco però le membra tondeggiavano, si spiccavano dal fondo e si campavano nell'aria. La statua non era più statua, ma sibbene un simulacro di donna avvolta in candida veste, pallida in volto e impressa i lineamenti d'un dolore ineffabile. Si chinò sul mio letto lievemente, e stette fisandomi d'uno sguardo tristo, prolungato e profondo.
— Oh! Bianca, parvemi ch'io le dicessi, povera Bianca! Quanto ho desiderato vederti e intendere le tue parole! Qual destino lega ancora la tua presenza in questi luoghi che ti dovrebbero essere così funesti? —
Ella crollò mestamente il capo, e il sentimento che mi parve dipingersi sul suo volto, era più d'amore che di odio.
— Che amore dovette essere il tuo, povera Bianca, se l'atroce supplicio a cui ti condannò la superba consorte, non te lo svelse dal cuore!
Ella chinò il capo quasi vergognando, e una lagrima parve rigarle il pallido volto: — Ah! una lagrima simile a quella ti tradì, sventurata, quel giorno fatale! — A queste parole che mi pareva d'indirizzarle, e ch'ella certo mi leggeva nell'animo, mandò un lamento così doloroso, che non mi ricordo d'averne udito alcuno di somigliante nel mondo. E come non potesse resistere alla penosa reminiscenza ch'io le avevo richiamata, la vidi allontanarsi da me, dileguarsi lentamente nell'aria, e addentrarsi di nuovo nell'opposta parete.
Addio speranze di udir la sua voce! Maledissi nel mio interno alla mia indiscrezione, rivolto pur sempre a quel punto della muraglia da cui l'avevo veduta svanire, quasi coll'intendimento di evocarla di nuovo per secreta attrazione magnetica. Tutto fu invano. L'aere s'era abbuiato, e mi si dipingeva tratto tratto in quelle fosche iridi che si veggono ad occhi chiusi la notte, e non hanno nome, cred'io, nella nostra favella. Ma quelle iridi, quelle sfere verdastre, azzurrognole, sparse di punti luminosi e vibranti, portavano scritto nel centro vari nomi che s'alternavano l'un dopo l'altro. Il primo ch'io potei leggere fu
SCHINELLA,[1]
e non appena l'ebbi letto, svanì col circolo raggiante dov'era scritto a lettere giallastre e fosforescenti. Non so quanti RAMBALDI e TOLBERTI lo seguitassero al modo stesso, finchè in una sfera di color rosato e cilestro, a lettere cangianti come l'opala, vidi apparirmi il nome di
GEMMA.
E poi una serie d'altri nomi che m'uscirono dalla mente, finchè in una ruota purpurea e come rabescata, lessi, il nome di
COLLALTINO.
Ma già il bruno campo nel quale agitavansi questi lucidi globi, si faceva ad ora ad ora più grigio, ed essi globi succedevano d'una tinta più languida e men distinta. A mano a mano che si confondevano nelle tinte del campo, anche le immagini della mia fantasia venivano perdendo d'intensità e di chiarezza. Vi fu un momento ch'io stetti come dimentico e inconscio di me medesimo: io passava evidentemente dal campo de' sogni a quello della realtà. Apersi gli occhi e m'avvidi che la luce del giorno avea già attenuato l'oscurità della stanza; balzai dal letto come trasecolato dalle visioni avute, delle quali ricordavo ancora e rannodavo alla meglio questi dispersi frammenti. Spinsi l'imposta quasi per finir di svegliarmi, e mi si aperse allo sguardo una scena che nessun pennello oserebbe dipingere.
Era una immensa pianura, la pianura della Marca Trivigiana, alla quale era termine l'Adriatico. Una tenue nebbiuzza la copriva a fior di terra, ammollendo i contorni delle piante sorgenti dal suolo, le quali apparivano come piccole macchie, anzi pur come punti dispersi nella vastità dello spazio soggetto. La Piave dappresso, più lontano il Sile, come un nastro d'argento volgeva i suoi lucidi meandri tra i regolari comparti dei seminati. Un rombo infinito, indistinto mi giungeva all'orecchio, e partiva dalle mille campane che dagli sparsi villaggi inneggiavano al sole nascente. Era la prima domenica di agosto. Sublime spettacolo! Questo suono era come la vita che animava la scena: come la voce della moltitudine, che da quelle mille villette destavasi a un'ora medesima, commossa da un sentimento comune.
Non ci voleva meno di questa scena così naturale, e pure così grandiosa e poetica, per tormi all'influenza de' sogni; poichè io sono così fatto, che basta un sogno talora a colorire d'una tinta conforme tutti i pensieri della giornata. Mi vestii frettoloso, e non senza fatica per quell'intricato labirinto di camere, trovai la via di uscir dal castello e recarmi alla casa dell'ospite mio.