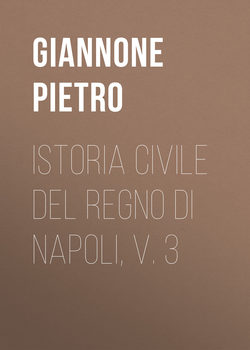Читать книгу Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3 - Giannone Pietro - Страница 20
LIBRO NONO
CAPITOLO I
Fondazione della città d'Aversa, ed istituzione del suo Contado nella persona di Rainulfo Normanno I, Conte d'Aversa
§. I. Venuta de' figliuoli di Tancredi Conte d'Altavilla. Morte di Corrado il Salico e sue leggi
ОглавлениеRainulfo veggendosi in cotal maniera stabilito in Aversa, attese a fortificarvisi ed incominciò a trattarsi da Principe: inviò Ambasciadori al Duca di Normannia, invitando i suoi compatriotti, che venissero a gustar con esso lui l'amenità del paese, ove già possedeva un Contado: l'invogliò a venire colla speranza di poter anch'essi impadronirsi di alcuna parte di quello. A questo invito venne in Italia un numero assai più grande de' Normanni, che per l'addietro fossevi giunto: con questi vennero i figliuoli primogeniti di Tancredi d'Altavilla capo della famiglia, di cui poc'anzi si narrò la numerosa prole, onde sursero gli Eroi, che conquistarono non pur queste nostre province, ma la Sicilia ancora. La spedizione de' figliuoli di Tancredi in queste nostre regioni deve collocarsi nell'anno 1035, i quali non tutti nell'istesso tempo ci vennero, ma i primi furono Guglielmo, Drogone ed Umfredo. Gli altri vennero da poi, e soli due rimasero nella loro patria[168].
Questi prodi Campioni andati prima a tentar la sorte in diversi luoghi, alla perfine cogli altri Normanni giunsero in Italia ed in Salerno sotto la protezione, ed a' stipendi di quel Principe finalmente si fermarono. Reggeva in questi tempi il Principato di Salerno Guaimaro IV, figliuolo del maggior Guaimaro, il quale sin dall'anno 1031 avea finito i suoi giorni. Questo Principe seguendo i vestigi di suo padre ebbegli cari, e riconoscendo questi novelli Normanni per giovani sopra tutti gli altri della loro Nazione molto distinti, ebbegli in maggior conto; fosse ciò per sua inclinazione o per politica, egli è certo, che in tutti i suoi affari valevasi di quelli, e ne faceva una grande stima, proccurando i maggiori loro ingrandimenti; e come Principe prudentissimo reggeva perciò con vigore e magnificenza il suo Stato.
Dall'altro canto Pandolfo Principe di Capua, che mal seppe conoscergli, era venuto, per la sua crudeltà ed avarizia, nell'indignazione di tutti: le frequenti scorrerie e rapine che faceva al monastero Cassinense erano così insopportabili, che finalmente obbligarono quei Monaci, per liberarsi della sua tirannia, di ricorrere in Germania all'Imperadore Corrado, al quale avendo esposto con pianti e querele i guasti che dava a quel Santuario, lo pregarono a calar in Italia per liberarlo dalle mani di quel Tiranno, rammentandogli dover a lui appartenere la loro liberazione, essendo quel Monastero sotto la tutela sua, come era stato sotto li suoi predecessori, e immediatamente sotto la sua protezione[169].
S'aggiunsero ancora, per affrettar la venuta di Corrado in Italia, le rivoluzioni accadute in quest'istesso tempo in Lombardia, autore delle quali in gran parte era riputato l'Arcivescovo di Milano[170]. Per queste cagioni finalmente fu risoluto Corrado intraprender il cammino verso queste nostre parti, e nell'anno 1036 con valido esercito, avendo passato l'Alpi entrò in Italia, ed a Milano fermossi, ove sedati i tumulti colla prigionia de' rebelli, imprigionò ancora l'Arcivescovo di Milano autore di quelli. Passò indi a poco in Roma, ove ascoltò le querele, che contro il Principe di Capua gli furon portate da gente infinita: volle conoscere de' suoi falli, e portatosi nel monastero di Cassino, mandò Legati a Pandolfo per ridurlo di buon accordo a restituire ciò, che ingiustamente avea occupato a quel monastero; ma ostinandosi nella sua perfidia, sdegnato Corrado venne a Capua egli stesso, e Pandolfo fuggendo la sua indignazione ritirossi nella Rocca di S. Agata. L'Imperadore ricevuto in Capua con solenne apparato ed allegrezza, nel giorno di Pentecoste fu quivi incoronato con gran celebrità, e colle consuete cerimonie. Era allor costume degl'Imperadori d'Occidente di replicar sovente queste funzioni ne' giorni più celebri dell'anno, nel che è da vedersi l'incomparabile Pellegrino nelle gastigazioni all'Anonimo Cassinense; poichè Corrado non in Capua fu la prima volta incoronato Re o Imperadore: fu egli prima salutato Re nell'anno 1026, ed Imperadore nell'anno seguente, quando la prima volta venne in Roma.
(In quest'anno appunto, che fu il 1027 fu coronato in Roma da Papa Giovanni l'Imperador Corrado, siccome narrano Wippone Prete pag. 433. Ottone Frisingense VI. cap. 29 che dice: Anno ab Incarnatione Domini MXXVII. Conradus Romam veniens etc. a summo Pontifice Joanne coronatus, ab omni Populo Romano Imperatoris, et Augusti nomen sortitur. Lo stesso scrissero Ermanno Contratto, Lamberto Schafnaburgense, Sigeberto Gemblacense, ed il Cronografo Sassone ad An. 1027. Passò in Puglia, e da poi in Germania fece ritorno. Nella fine da poi dell'anno 1036 ritornò di nuovo in Italia: sedò i tumulti in Milano: imprigionò quell'Arcivescovo, ed avendo celebrata la Pasqua dell'an. 1037 in Ravenna, sedati nel seguente anno 1038 i romori di Parma, tornò di nuovo in Alemagna. Così scrissero Wippone Prete pag. 440 et seqq. Ottone Frisigense VI. c. 31. dicendo: Italiam ingreditur, Nataleque Domini celebrans, per Brixiam ac Cremonam, Mediolanum venit, ejusdemque Urbis Episcopum, eo quod conjurationis erga cum factae reus diceretur, cepit, ac Pupioni Aquilejensi Patriarchae custodiendum commisit etc. Concordano Ermanno Contratto, gli Annali Ildesheimensi, il Cronografo Sassone, Alberico, e Lione Ostiense lib. 2. cap. 65.)
Intanto Pandulfo con tutti i mezzi proccurava placar l'ira di Corrado, chiedendogli perdono; finalmente gli offerì trecento libbre d'oro, la metà delle quali offeriva sborsar prontamente, l'altra metà a certo tempo, promettendo frattanto insino all'intero pagamento di dargli per ostaggi una sua figliuola ed un nipote: gli accordò l'Imperadore l'offerta, al quale egli tosto mandò il denaro e gli ostaggi. Ma non molto da poi pentitosi questo Principe del fatto, e reputando di poter con facilità rientrare in Capua, subito che Corrado se ne fosse partito, negò finalmente, dopo molto prolungare, di mandargli il restante dell'oro. Corrado allora avendo scorto l'animo di questo Principe, e che appena egli partito, sarebbe col suo mal talento ritornato ben presto alle rapine ed alle crudeltà, pensò di privarlo affatto del Principato di Capua, e darne ad altri l'investitura.
Convocò per quest'effetto un'assemblea di Proceri e Magnati, e di molti suoi Baroni, alla quale volle che intervenissero ancora i Magnati stessi di Capua, acciocchè anche col loro parere e consiglio il facesse, e nel caso di doversi Pandolfo deporre dal Principato, più maturamente innalzarvi altro personaggio, che ne fosse meritevole. Fu pertanto deposto Pandolfo, e non ritrovandosi chi potesse meglio sustituirsi in suo luogo, del Principe di Salerno Guaimaro, Principe prudentissimo, e ch'era in somma grazia dell'Imperadore Corrado, fu a lui conceduto: e furon allora veduti questi due Principati uniti in un'istessa persona.
Pandulfo lasciato suo figliuolo nella Rocca di S. Agata, andò in Costantinopoli a chieder soccorsi dall'Imperadore. Ma questi prevenuto da Guaimaro, in vece di somministrargli ajuto, lo mandò in esilio, ove per due anni, e più insino che visse l'Imperadore, dimorò: morto costui, dal suo successore fu liberato, ma non potendo ricever alcun ajuto, se ne tornò senza alcun frutto[171].
Allora fu che Guaimaro riconoscente de' segnalati servigj, che gli avean prestato i Normanni, non tralasciava occasion d'ingrandirgli, e di mostrar loro il desiderio, che nudriva in esaltargli, proccurò dall'Imperadore Corrado l'investitura del Contado d'Aversa a favor di Rainulfo[172]; poichè se bene, come abbiam narrato, Rainulfo da Sergio Duca di Napoli fosse sopra i Normanni stato fatto Conte; nulladimanco quel, che si fece allora, fu solamente un conceder in ufficio a Rainulfo quella dignità, cioè di costituirlo Capitano sopra i suoi commilitoni, come dottamente spiegò il Pellegrino. Gl'Imperadori d'Occidente riputavano allora ad essi solo appartenere il concedere ed investire i Feudi in tutta Italia, ed esser questa, loro singolar prerogativa: ad imitazion de' quali pretesero da poi i Pontefici romani, che ad essi soli s'appartenessero l'investiture de' Beneficj, di che ci tornerà occasione altrove di favellare. Perciò Guaimaro, per istabilire maggiormente i Normanni nel Contado d'Aversa, proccurò che Rainulfo dall'Imperadore ne fosse investito, in virtù della quale investitura se gli concedeva non solo in ufficio, ma anche in Feudo la Città, ed il Contado e tutte quelle regalie, che sogliono venir comprese in simili concessioni.
Ma ben Guaimaro ne fu corrisposto da' Normanni, poichè non molto da poi co' loro ajuti prese Sorrento, e ritenendo per se il titolo di Duca di Sorrento, concedè questa città a Guido suo fratello. Conquistò ancora col loro ajuto Amalfi, che per se la ritenne, ed al suo Principato la sottopose[173]. S'usurpò poco da poi, il titolo di Duca di Puglia e di Calabria; in guisa che nella sua persona s'unirono tanti titoli e Signorie, che non fu Principe alcuno veduto in questi tempi, innalzato a tanta sublimità e grandezza in queste nostre province, quanto lui. Per queste ragioni in alcune carte rapportate dall'Ughello nella sua Italia sacra, fatte sotto il Principato di Guaimaro IV si osservano tanti titoli, che a questo Principe s'attribuivano, come in una data in Melfi, Vigesimo sexto anno Principatus Salerni Domini nostri Guaimarii gloriosi Principis; et sexto anno Principatus ejus Capuae, et quinto anno Ducatus illius Amalfis, et Sirrenti; et secundo anno suprascriptorum Principatuum, et Ducatuum Domini Gisulfi eximii Principis, et Ducis filii ejus; et secundo anno Ducatus eorum Apuliae, et Calabriae, mense Junii duodecima Indictione[174].
Intanto Corrado, da Capua partito, portossi a Benevento, indi per la Marca andossene oltre i monti, portando seco gli ostaggi, che da Pandolfo avea ricevuti; ed appena scorso un altro anno finì i giorni suoi in Alemagna nell'anno 1039 lasciando per successore nell'Imperio Errico suo figliuolo, detto il Negro.
(Corrado appena scorso un anno, che ritornò da Italia, morì nel mese di giugno in Utrech nella Frisia in quest'anno 1039. Ottone Frisingense VI cap. 31. Non multo post reverso ab Italia Imperatore, Sanctamque Pentecostes in inferiori Trajecto Frisiae urbe celebrante, in ipsa solemnitate infirmatus XVII Regni, Imperii vero XIV anno diem ultimum clausit. Concordano Wippone pag. 402. Ermanno Contratto, Lamb. Schafnaburg, Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Corrado Ursperpense il Cronografo Sassone, e gli Annali Ildesheimensi).
Fra le molte prerogative, onde era Corrado adorno, fu la perizia delle leggi, ed il sommo studio, ch'ebbe in istabilirle: egli calando in Italia presso Roncaglia, siccome era il costume de' suoi predecessori, molte ne stabilì tutte prudenti e sagge. Alcune se ne leggono nel terzo libro delle leggi longobarde, altre ne' libri feudali, e moltissime altre ne raccolse Goldasto nei suoi volumi[175].
Egli fu il primo, che alle consuetudini feudali aggiungesse le leggi scritte per regolar le successioni: insino ad ora la successione de' Feudi si regolava secondo i costumi de' Longobardi, che in Italia gl'introdussero. I Feudi, secondo che abbiam veduto, per antica consuetudine non solevan concedersi se non a tempo[176], rimanendo in potestà del concedente, quando gli piaceva, ripigliarsi la cosa data in Feudo. Da poi fu introdotto, che per un'anno avessero la loro fermezza: in appresso s'ampliò durante la vita del vassallo, nè a' figliuoli s'estendeva; finalmente fu ammesso uno de' figli, ed era quando il Padrone al medesimo confirmava il Feudo, che al padre era stato conceduto: poi s'ampliò a tutti i figli, nè oltre, per le consuetudini feudali s'estese la lor successione.
Corrado il Salico, avanti che in Roma giungesse a prender la Corona dell'Imperio, nell'anno 1026 in Roncaglia, secondo il costume de' suoi predecessori, nell'assemblea de' Principi e del Popolo, richiesto dai suoi vassalli, che fosse contento d'ammettere alla successione de' Feudi non pur i figli, come erasi per le consuetudini feudali introdotto, ma anche i nepoti nati da' figli, e questi mancando, potessero succedere ancora i fratelli del defunto, glie lo accordò, e fu perciò promulgata legge, per la quale stabilì, che se il Feudatario non avrà figli, ma nipote dal suo figlio maschio, abbia questi il Feudo: e se non avrà nepoti ma fratelli legittimi, abbiano questi ancora il Feudo, che fu del loro comune padre[177].
Questa legge, che vien per intero rapportata dal Sigonio[178], ancorchè i Compilatori de' Libri Feudali non ve l'avessero interamente in quelli inserita, si legge però nel libro terzo delle leggi longobarde, ove tutte le altre leggi degl'Imperadori d'Occidente come Re d'Italia furono raccolte, le quali non solamente in Lombardia ed in tutte le altre parti di Italia, ma ancora in queste nostre province, toltone quelle, che all'Imperio de' Greci erano sottoposte, ebbero forza e vigore, per quelle ragioni, che altre volte abbiam detto nel corso di questa Istoria, e particolarmente ne' tempi di Corrado, ne' quali l'autorità degl'Imperadori d'Occidente era nel colmo della sua grandezza ne' Principati di Capua, di Salerno ed in quel di Benevento; essendosi veduto che essi deponevano i Principi stessi, e de' loro Principati disponevan a lor talento; anzi, siccome vedrassi più innanzi quando della compilazion di queste leggi e delle feudali tratterassi, maggiore fu nel nostro Regno la forza ed autorità delle leggi longobarde, che delle feudali.
Non è però, che Gerardo de Nigris Senator di Milano nel primo libro de' Feudi[179] non avesse rapportata la sentenza di questa legge; ed i Compilatori degli altri libri feudali la tralasciarono d'inserire tra le altre costituzioni feudali degli altri Imperadori, che a Corrado succedettero, per quest'istessa ragione che ritrovavasi già inserita ne' libri delle leggi longobarde, l'uso de' quali era più frequente presso i nostri maggiori, che quello de' libri feudali: se bene da un luogo d'Andrea d'Isernia[180] si raccoglie, che in alcuni Codici delle leggi feudali, che allora andavano attorno, ancor che in molti luoghi tronca e mutilata, era stata pure trascritta.
Altri Capitoli di questo Principe abbiamo nel libro secondo de' Feudi sotto il titolo de Capitulis Corradi, stabiliti parimente in Roncaglia, ove de' Feudi pur si tratta: nè, per dir ciò di passaggio, è condonabile l'errore di Carlo Molineo[181], il quale nell'istesso tempo, che biasima i nostri Interpreti, i quali per l'ignoranza dell'istoria caddero in molti errori, inciampa egli stesso in ciò che ad altri biasima; riputando questi Capitoli di Corrado, essere non del Salico, ma di Corrado II, quando quel Corrado di ch'egli parla, non fu mai in Italia, onde avesse quelli presso Roncaglia potuto stabilire.
Quindi ancora si convince l'altro errore di Molineo[182], nel quale non possiamo non maravigliarci esservi ancora caduto, oltre Cragio ed Ornio, il nostro diligentissimo Pellegrino[183], i quali per leggiere cagioni reputarono Lotario I, nipote di Carlo Magno, autore di quella costituzione, che si legge nel libro primo de' Feudi[184], per la quale la successione dei Feudi fu estesa anche al patruo; tantochè se fosse di quello Imperadore, non Corrado il Salico verrebbe ad esser il primo, che alle consuetudini feudali aggiungesse sopra ciò leggi scritte, ma Lotario I, che più di 200 anni prima di Corrado tenne l'Imperio di Occidente.
Ma si convince questa legge essere di Lotario III (che altri con più verità appellano II, poichè dell'altro Lotario, che per pochi giorni in tante rivoluzioni di cose invase l'Imperio dopo Berengario, non dee aversi conto) non già di Lotario I, per essere stata promulgata in Roma nell'anno 1133, o 1137 sotto il Pontificato di Innocenzio, non già d'Eugenio, come scorrettamente si legge ne' Codici vulgati, nell'Assemblea (com'era il costume) de' Sapienti e Baroni di molte città d'Italia; e fu confermata da Lotario la legge di Corrado intorno alla successione de' Feudi; ed oltre di ciò, ampliata la successione anche a favor del patruo, il che Corrado non avea fatto, siccome dottamente notò l'incomparabile Cujacio[185]
168
Malat. lib. 1 cap. 9, 11, 19 et 38. Ost. lib. 2 cap. 67.
169
Ost. lib. 2 cap. 65.
170
Antonin. 2 part. tit. 16 cap. 2. §. 1.
171
Ostiens. lib. 2 cap. 65.
172
Ostiens. lib. 2 cap. 65. Rainulfum quoque, ipsius Guaimarii suggestione, de Comitatu Aversano investivit.
173
Ostiens. l. 2 c. 65. Eodem tempore Guaimarius, Normannis faventibus, Surrentum cepit, et fratri suo Guidoni contulit. Amalfim nihilominus suo dominatui subdidit.
174
Ughell. de Archiep. Amalf. pag. 255 t. 7.
175
Goldast. t. 3 p. 312.
176
Lib. 1. Feud. tit. 1 §. 1.
177
Lib. 3. LL. Longob. tit. 8 de beneficiis, l. 4.
178
Sig. A. 1026.
179
Lib. 1 tit. 1 §. 2.
180
Audr. in Comm. in l. omnibus post tit. de prohib. Feud. alien. per Lothar.
181
Molin. de Feud. p. 51.
182
Molinaeus de Feud. n. 33.
183
Pellegr. in dissert. pag. 62.
184
Lib. 1. Feud. tit. 19.
185
Cujac. de Feud. lib. 2 tit. 17. Nam quod sequitur de successione Feudi, constat primum introduxisse Conradum, confirmavit autem Lotharius.