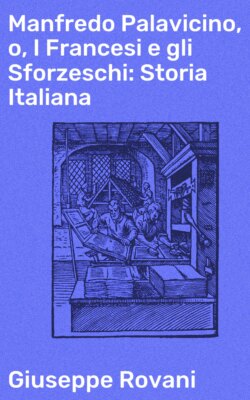Читать книгу Manfredo Palavicino, o, I Francesi e gli Sforzeschi: Storia Italiana - Giuseppe Rovani - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO VII.
ОглавлениеIndice
Ma lasciamo or da parte l'indole di costui, e teniam dietro piuttosto a' suoi passi e a quelli del suo giovane amico. Prendendo dunque così a caso, nel recarsi dal marchese Besozzo, per una delle più frequentate contrade di Milano, della quale era principale ornamento un vasto e magnifico palazzo di architettura gotica del secolo XIII, allora appartenente in proprietà ad una vecchia marchesa, di cui la storia non s'è presa la briga di tramandare il nome sino a noi, l'attenzione del Palavicino e del conte Galeazzo dovette necessariamente essere fermata dall'eccessivo splendore che riboccava dalle finestre appunto di quel palazzo, talchè pareva quasi fosse tutto quanto in fiamme; ma in fiamme non era certamente, perchè invece di strilli e di pianti e di voci lamentevoli, gli orecchi venivano intronati da un frastornio festoso da certi suoni e strimpellamenti e canti, i quali, manifestamente erano indizio di un'allegria smodata, di una gazzarra baccante. E ciò che produceva un'antitesi assai curiosa, era il genere di quei suoni e di que' canti, e la dignitosa magnificenza del palazzo. Canzonaccie per sè stesse sguajate, ma rese ancor più sguajate dalla natura delle voci strillanti che le mandavan fuori, pifferi e cornamuse e tiorbe e ribebe a due corde con accompagnamento di tamburelli, quali solevansi udire il giovedì e il sabbato grasso nelle bettole del Ponte Vetro, del Verzaro, del Bottonuto, con questa differenza, che tutte le orchestre particolari di ciascuna bettola erano state unite insieme e messe tutte a contributo per produrre il maggior frastuono possibile. Ogni tanto poi a qualcheduna di quelle finestre si vedeva comparire improvvisamente una figura d'uomo, la cui massa nera spiccava tagliata sul fondo luminoso delle sale, a mandare qualche acuto strillo che percorresse tutta la longitudine della contrada, a sacramentare per celia, a rivolger parole ed orazioni altitonanti alla folla che, stipata innanzi al palazzo, rispondeva con altri schiamazzi ed altre grida a quelle che facevano rimbombare le interne vôlte. Ed era una cosa strana, e che facilmente produceva la giocondità e il buon umore, il pensare a chi apparteneva quel palazzo, e l'uso che di presente se ne faceva. La marchesa proprietaria, vedova già da trent'anni, era vecchia, era ricchissima, era pinzocchera, era santa ed avara, due qualità che non potrebbero camminar di conserva, ma dessa ci avea trovato il modo. Ritirata in un cantuccio del palazzo, in una celletta oscura, conduceva una vita che avrebbe potuto essere un esempio cospicuo dell'umiltà cristiana, se i ventimila fiorini d'oro che tutti gli anni entravano a dormire un riposo eterno nelle casse ferrate intorno alle quali biascicando paternostri ella faceva la ronda piena di paurosa e gelosa sollecitudine, non avessero dato indizio che nel cervello della settantenne marchesa, c'era qualche cosa di guasto. Ora i ladri, i tôffi, i caramogi di porta Tosa, e tutta la parte più lercia della popolazione milanese, che conoscevano molto bene la vecchia, e il morto che teneva nascosto, aveva pensato prendere d'assalto il suo gotico palazzo e compensarlo in una sola notte della lunga solitudine e del profondo silenzio nel quale aveva passato trent'anni continui, giacchè il marchese defunto era stato un assai magnifico signore, e non s'era stato a dondolare. I pochi servi che, colla palandrana grattugiata, cadevano a brandelli per la vecchiaia, come le imposte tarlate e scardinate della porta del palazzo, non avevano saputo far testa pur un momento, e l'irruzione era stata così impetuosa, che in un istante tutto il palazzo fu gremito di popolaccio, il quale, sfondati gli usci, sfracellate le antiche vetriere, s'era precipitato in quegl'immensi e ricchi saloni che da tanto tempo eran vuoti, solitarj e silenziosi. Abbiamo detto che in questa notte memorabile la plebe, assai più che dall'istinto della violenza brutale, era animata da un buon umore straordinario, chè più che tutto gli premeva godersi quelle poche ore in tutta libertà, intanto che la legge, come talvolta accadeva pur troppo di que' giorni, trattenuta dalla chiragra, se ne stava a far capolino, ed ammicava irata e impotente dalle finestre del palazzo di giustizia.
Appena dunque che la folla, avvolta in un denso spolverío che s'alzava da tutte le parti, si trovò in quelle sale dorate, e al lume di certi razzi, di certi lampioni e lanterne che taluni facendo notte oscura aveva portate con sè, s'erano accorti delle lampade di cristallo che pendevano in lunga e densa fila dalle vôlte delle sale, subito s'alzò una voce strillante fra quella numerosa folla:
—Non si può negare che qui si stia assai meglio che alla taverna della Colonnetta, e se stanotte si aveva a strimpellare colà colle tiorbe dello Squinterna, e fare una scorpacciata di cipolle coll'olio di merluzzo che raspa in gola, per adesso ho cambiato parere, e l'oste potrà benissimo saltar lui con quella maladetta balena d'Onofria sua moglie, ch'io voglio far gazzarra qui stanotte.
E uno scoppio d'urli con accompagnamento di battimani disperati, avendo dato indizio che un simile partito era stato accolto a maggioranza di voti, in fretta e in furia un centinajo di bordellieri si sparpagliarono per tutti i canti della città, gli uni a reclutar pifferi e tromboni storti e tamburelli e ribebe e unicordi e tiorbe, gli altri a insaccarsi in tutti gli angiporti della città, destando dall'impuro letargo gli sciami schifosi delle briffalde, le quali, volessero o non volessero, tempestate da certi inviti strani, misti di cortesie, di bestemmie ed anche di pugni altitonanti, dovettero sgomitolarsi come vipere intrecciate al sole che sian percosse da una verga e seguire la turba. Altri a spandersi per le botteghe dei vend'arrosti, sagrando e minacciando perchè subito s'allestisse tutto quanto era sui fornelli. Fatto sta, che in poco d'ora tutto fu in ordine, in un momento la folla già stipata si raddoppiò per gli atrii e per le sale; tutto il putridume e la mondiglia che stava accatastata nelle cloache e ne' mondazzai della città si scaricarono in quel sontuoso palazzo. Nelle lampade di cristallo si mise olio quanto bastasse a fare grosse fiamme; e torcie e razzi e fiaccole e lanterne e lampioni furono aggiunti ad accrescere l'illuminazione e a far giorno di notte. Tutto però non avea potuto condursi colla tranquillità medesima, chè quando corse voce che il Cecco ferrajo aveva scassinata la cassa, la folla, attirata dai fiorini della marchesa, s'era riversata così impetuosa nell'angusto camerotto, che la quantità delle teste ammaccate e delle sorbe sugli occhi fu innumerevole. A questo punto eran dunque le cose quando il conte Galeazzo e il Palavicino passarono a caso per di là.
E appena che il conte ebbe udita la storia genuina del fatto, come preso da una repentina inspirazione, rivolto a Manfredo:—Mi pare, disse, che il conte Besozzo potrà benissimo far senza di noi stassera, che in ogni modo domani allo sparo delle artiglierie saremo in castello, la qual cosa è la sola che importi veramente. E intanto non si vuole non tener conto di un momento così prezioso senza entrare nelle sale della marchesa a godervi uno spettacolo che, per lo meno, è novissimo. Una festa da ballo composta di trecconi, di ladri e di ciccantoni che saltano sui tappeti dorati di Bologna e si riflettono negli specchi di Murano, è un fenomeno che non si vedrà la seconda volta. Lascia dunque il Besozzo e vieni con me.
Qui ci furono alcune altre parole tra il Palavicino e il conte, il quale, finalmente lasciando che il Palavicino se ne andasse tutto solo dal Besozzo, entrò nel palazzo della marchesa.
Appena che la cappa di velluto rasato e la collana d'oro del conte Galeazzo comparve nella gran sala dove infuriavano l'orgie, a tutta prima scoppiò un urlo generale che non pareva prometter nulla di buono per lui, e tutti i pantanosi caramogi, come ranocchi sconcertati dall'improvvisa comparsa di un luccio dorato, gracidarono minacciando di farlo in brani; ma il conte avea più di una cosa che militava a suo favore. In prima è da sapersi, ch'egli tutte le mattine, alla porta del proprio palazzo, faceva distribuire duecentocinquanta zuppe per la minutaglia affamata, ora buona parte di coloro che attendevano colà a far salti scomposti al suono di una trentina di tiorbe scordate, avevano appunto assaggiato più d'una volta i brodi della cucina del conte. Ciò per altro non sarebbe bastato a difenderlo dall'ira generale; ma più d'una volta il conte era stato veduto a far la via a zig-zag nel recarsi a casa la notte, e sapevasi da tutti che era il primo bevitore di Milano, e che andava soggetto a degli accessi d'ubbriachezza formidabili. Ora un uomo così amico del buon vino, e che più d'una volta sotto l'influenza di eccessivi vapori, che promovevano in lui gli estri guerreschi, s'era azzuffato coi sargenti della controronda, non poteva che aver destata l'ammirazione di quella parte di pubblico. Ma qui non era tutto ancora. Molte di quelle pudiche creature, che andavano a quarti ballando anfanate su quei ricchi tappeti, avevano più d'una volta avuto campo di ammirar la faccia del duca e dell'imperatore Massimiliano sui piccoli fiorini d'oro del conte, e non s'eran mai potuto far capaci del come un sì grande gentiluomo si degnasse salire per quelle scalette di legno dove era tanto facile fiaccarsi il collo, ciò che per altro non impediva loro di tenere il grandissimo conto l'affabile e liberale signore. Per tutte queste cagioni adunque, appena che egli fu conosciuto, gli urli minacciosi si cambiarono in grida d'applausi, cosa di cui il conte non avea potuto accorgersi, essendo rimaso come estatico appena gli si parò innanzi quel peregrino spettacolo.
Quella sala era un vastissimo quadrilungo, con dodici colonne capitelli dorati; la vôlta, a sesto acuto, dipinta a ricchissimo mosaico con fondo d'oro, le pareti rivestite di specchietti che quadruplicavano la grandezza della sala; il pavimento coperto di tappeti e d'arazzi, storiati in tessuto, di pazientissimo lavoro, i quali è vero bensì che, per incuria della marchesa, eran stati mezzo corrosi dalla polvere di treni'anni, ma spazzati in quella sera dalle danze carnascialesche, facevano tuttavia una splendidissima mostra. Si figuri il lettore che scandalosa antitesi dovesse fare con quelle magnificenze la schifosa moltitudine che stava là dentro. Quelle coppie di lerci danzanti e di oscene danzatrici, i primi colle palandrane sfilacciate, e le brache che cadevano a drappelloni, attraverso le quali si vedevan costole e trippe e gheroni in malissimo essere; le altre ancor più laide sotto a quell'apparenza di lusso inzaccherato di fango. Gonnelle di bucherame sparse di macchie d'unto, coi lembi sfilacciati, creste di canutiglia cariche di nastri di tutti i colori, che adornavano la arruffatte capigliature e quelle faccie quadre e sfrontate sparse di lividumi e di sorbe; e delle impronte dei pugni dei pochi gentili amanti. Nel mentre che le coppie attendevano a danzare, altri luridi gruppi gettati a sdraio sui tappeti attendevano a mangiare dello strutto, che impregnava d'un forte odore l'atmosfera, già abbastanza impuro, di quella sala. E intanto che le tiorbe e le cornette storte ci davan dentro a perdiafiato, alcuni mezzi ubbriachi, saliti in vetta alle colonne, aggrappatisi sugli accanti dei capitelli, cantavano con certe voci acute in chiave di clarinetto e d'ottavino alcune oscene canzonacce, mentre con del carbone facevan turpi aggiunte alle Veneri dipinte a mosaico in campo d'oro. La stranezza di quella scena in somma somigliava più che altro ad uno di quei sogni arruffati che può fare un galantuomo il quale si corichi subito dopo una scorpacciata d'ostriche e d'anguille marinate.
Però il conte Galeazzo, appena ebbe appagata la propria curiosità, non potendo a lungo dilettarsi di quelle sozze stranezze, già pensava d'uscire, quando gli passò innanzi la corpulente figura del Cecco ferraio che gli volse un'occhiata alla sfuggita.
Il conte gli mise allora una mano sulla spalla, e gli disse:
—E così, Cecco, come si metton le cose?
—Ottimamente, illustrissimo; peccato ch'ei sia di paglia quel che abbrucia, e la fiamma debba spegnersi tra poco.
—Non mi par poi che tutto sia paglia, Cecco mio; tu mi comprendi….
—Ci fu qualcosa meglio che paglia in fatti, rispose il ferraio ridendo, questo è verissimo; pure non fu gran cosa. E la contessa, Dio sa dove ha nascosto quello che in tanti anni andò ammassando, perchè quel che a me venne fatto di toccare, è ben poco.
—Pure ti dovresti contentare di ciò che hai trovato, e star pago,
—Non faccio altro infatti; e costoro son contenti abbastanza, ed è per costoro che ho tentata la virtù del grimaldello. Della pesca che ho fatto toccò la sua parte dì pesce a ciascuno, e la porzion mia è pari all'altrui, onde vedete che ho lavorato gratis, e per solo amore del prossimo.
—Questo mi piace; pure non avresti dovuto nemmeno far questo.
—Siete in errore, illustrissimo; e in quanto a me non feci mai cosa, di cui tanto mi compiacessi in vita mia, ed è per lei che spero di ottenere la remissione de' miei peccati. Del resto, considerate bene; o la contessa si ravvede, e va ottimamente o sta caparba nella sua pilaccherìa, e meglio ancora, perchè così la faremo morire di crepacuore. In quanto poi a costoro, un centinaio di ducati per ciascuno è un grande aiuto; non c'è infine cosa più dannosa al mondo dell'oro che stagna in una cassa ferrata, e se la zecca gli fa il conio rotondo, vuol dire che la sua destinazione è quella di girare per le mani di tutti. Dunque vedete che io ho operato benissimo.
—Sei tu convinto di ciò?
—Lo sono.
—Ebbene, or fa ch'io lo sia di quest'altro.
—Dite pure.
—Vorrei che mi provassi, che in fondo tu sei un uomo dabbene.
—Qual caparra volete?
—Giacchè hai compulsata la cassa, lascia in pace la contessa, e fa in modo che nessuno di costoro attenti alla sua vita.
—S'egli è ciò solo che vi preme, siatene certo; lo spegnere l'ultimo fil d'aria che sostiene il suo carcame di vecchia, sarebbe un atto barbaro non solo, ma un atto inutile…. Vedete che ho fior di ingegno, dunque non ci pensiamo. E in quanto a costoro, se due terzi son schiuma di furfanti, pure nessuno farà quel ch'io non voglio; in tutto Milano non v'è braccio pari al mio, e a questo si porta rispetto, però state tranquillo.
—Bravo, così mi piaci, e se a te occorresse qual cosa, quando mai la forza del tuo braccio non ti valesse più che tanto, sai dov'è il mio palazzo. Bada dunque che costoro si ritraggono presto, e lascino in pace la vecchia.
Ciò detto il conte Galeazzo uscì. Quando fu sotto gli atri, s'incontrò in un vecchio servo della contessa, che lo conobbe, e gli disse:
—In che modo ella è qui, illustrissimo signor conte?
—Ci venni, ma me ne vado.
—Se vostra signoria illustrissima si recasse un tratto a confortar la contessa, farebbe opera caritatevole. Ella teme che da un momento all'altro questi furfanti entrano da lei a furia, e trema di spavento.
—Questo non può succedere. Andate a dirlo alla contessa.
—Se ci andaste voi medesimo, illustrissimo, sarebbe assai meglio.
Ella si conforterebbe vedendovi.
—Se ciò è, andiamo.
Il servo allora condusse il conte per molti corritoj, e pervenuto finalmente a una porta, bussò, dandosi a conoscere; una voce acuta, fessa e tremolante domandò che cosa fosse.
—È l'illustrissimo signor conte Mandello che è venuto in palazzo a sedare il tumulto, rispose il servo.
Allora l'uscio fu aperto, e il conte entrando vide una camera assai poveramente addobbata, una vecchia fantesca in piedi, e la contessa seduta. Nella camera non c'era che una tavola, due seggiole, un inginocchiatojo, un Cristo in croce e un grosso libro nero. Il Mandello girato l'occhio intorno:—Mi maraviglio, disse, che voi ve ne stiate in questo sozzo bugigattolo, mentre la canaglia sta contemplando il proprio ceffo ne' vostri specchi e saltando, sfilaccia il velluto delle vostre sale.
—Capirete dunque, ella disse, che se si continua di tal passo, non c'è più che la fine del mondo.
—Questo potrebbe darsi, contessa; pure avrete la bontà di confessare, che il torto, ben più che d'altri, è vostro questa volta,
—È mio? Chi vi può capire?
—Date per amore quel che vi cresce, contessa, che nessuno verrà a prenderselo per forza…
—E che dunque avrei dovuto fare?
—L'opposto di ciò che avete sempre fatto.
—Sentite, conte, se siete venuto qui per farmi ingiuria, potrete anche andarvene.
—Son venuto qui per dirvi, che mettiate da canto ogni paura, che quel ch'è successo è successo, e se alla vostra cassa si cavò il sangue, non sarà cavato a voi; questo voleva dirvi.
—Dunque tutto è perduto?
—In che modo? se tutto è guadagnato invece.
—Che cosa dite? Io non vi comprendo.
—I tempi sono assai scarsi, contessa, e se la povera gente levò stassera la muffa ai vostri ducati, che da quest'ora prenderanno aria e circoleranno a furia, è innegabile che molto siasi guadagnato; ne dovrete convenire anche voi…
—Andate; voi siete più tristo di tutti costoro. Andate, lasciatemi in pace una volta.
—E in pace vi lascerò; soltanto badate a ringraziarmi, e fate che la lezione vi giovi. Io vi auguro la buona notte.
E il conte ghignando, si tolse di là e uscì di palazzo.
Liberatosi che si fu dalla folla, che ancora innondava quella contrada, pensò che poteva ancora recarsi alla casa del conte Besozzo, dove si raccoglievano i patrizi che stavano pel duca, ossia i patrizi ghibellini, e l'un passo dopo l'altro in fatti, attraversando lentamente buona parte della città, per osservare quanto ci si faceva dal popolo in quella straordinaria circostanza, pochi momenti dopo ch'eran cessati i rintocchi della campana grossa de' Mercanti, si trovò sulla piazza di S. Ambrogio, dov'era il palazzo Besozzo. Ma in quella ch'egli stava per entrarvi, ne uscirono appunto in folla quei che vi si erano raccolti, e le parole e le esortazioni e i diverbi e le dispute continuavano ancora nel loro massimo fervore.
Il Palavicino quando s'accorse del conte Galeazzo:—Sei giunto in tempo, gli disse, ma fu peccato che tu non abbia potuto udire le calde parole del vecchio Besozzo.
—Per quanto io abbia stima di questo vecchio onorato, rispose il conte, pur non credo d'aver nulla perduto, che quando uno ha fermo il suo partito, le esortazioni sono inutili, e quand'uno ha in animo di far l'opposto, altro che parole ci vogliono, caro Manfredo. Dunque che cosa avete stabilito?
—Nulla che tu non sappia per verità. Domani all'alba ci raccoglierem tutti in castello.
—E non c'è a far altro?
—Null'altro, io credo, fuorchè a menar le mani da valorosi, quando sarà il momento.
—E questo è ciò che faremo, se non foss'altro, per mantenere l'esercizio.
—Per questo solo?
—Credo bene che basti; il berretto lo portai sempre alla mia foggia, nè a' guelfi nè a' ghibellini è mai riuscito d'iscrivermi nelle loro tabelle; la mia cappa non ha colore… per adesso almeno.
Ciò detto, accompagnatosi con Manfredo, e ripercorsa con lui buona parte della città, come la notte fu innoltrata, e i cittadini anche i più turbolenti, si riducevano alle case loro, e Milano tornava tranquilla e silenziosa, se ne venne al proprio palazzo. Qui strettasi la mano:—A rivederci all'alba! sclamarono i due amici, e si lasciarono.