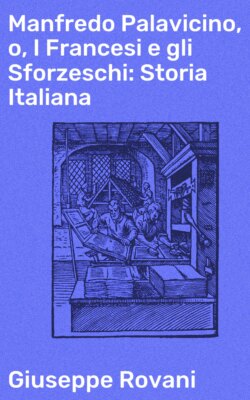Читать книгу Manfredo Palavicino, o, I Francesi e gli Sforzeschi: Storia Italiana - Giuseppe Rovani - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO X.
ОглавлениеIndice
È probabile che il nostro lettore, uscito qualche volta dalla porta Romana, in una di quelle placide mattine di primavera, o d'autunno, così particolari al cielo di Lombardia, siasi recato tutto solo a quattro miglia dalla città, a visitare l'abbazia di Chiaravalle, ed è pure probabile che, entrato in quel breve orto, deserto e lugubre oggidì, che circonda la parte posteriore del tempio, piccolo, ma prezioso saggio dell'architettura portata dalle crociate, siasi fermato a lungo cogli occhi volti in su ad esaminare quella guglia alta, svelta, aerea, a trafori, elegantissima, intorno alla cui vetta, svolando a tondo gli uccelli interrompono dei loro dolci garriti l'universale silenzio; e qui sentendosi portato sulla via delle reminiscenze storiche, abbia ripensata la vita austera ed operosa di s. Bernardo, che fondò l'abbazia, le vicende e la caduta dei Torriani che qui furono seppelliti, il nome della Beatrice d'Este, la quale, venendo sposa a Galezzo Visconti, fu in questo luogo salutata dalla nobiltà milanese che le aveva mosso incontro espressamente, le sorti della Guglielmina Boema, di cui in prima si venerò il sepolcro con triduo festoso, poscia se ne sparsero le ceneri al vento facendosi le cose a proposito, tanto nel primo che nel secondo caso.
Ora nel giorno 15 settembre sul piano praticabile più alto di quella guglia, ad un'ora di giorno si vedevan fermi due uomini. Dell'uno luccicavano al sole gli ori e le gemme sulle ricche vesti, e dell'altro difficilmente si distingueva l'umile sottana di monaco cisterciense. Il silenzio in quell'ora, in quel giorno, non era nè generale, nè profondo come il solito, ma veniva interrotto da frequenti scoppi come di tuono, che percorrendo e agitando le regioni dell'aria veniva a morire in seno dell'abbazia. Intanto che i due dall'alto della guglia parevano immobili a guardare, alcuni conversi del monastero, raccolti in quel brolo, oggi così abbandonato e tetro, se ne stavano inchinati, accostando la testa a terra, come ad ascoltare qualche cosa che venisse di sotto.
Stando in fatti in quella postura, alle improvvise alterazioni del cupo rimbombo, che, quasi percorresse lo spazio sotterraneo, arrivava da sei miglia lontano sino a quel punto, si poteva quasi avere un sentore dei repentini movimenti de' cavalli e delle artiglieria trasportate, delle varie vicende della battaglia che si combatteva tra Marignano e San Donato, e que' buoni conversi da que' suoni così vaghi credevano infatti poter raccogliere qualche notizia. In quanto poi ai due che stavano sull'ultimo piano dell'aerea guglia, non contenti di quello scarso indizio, per la vastità della campagna dirizzavano lo sguardo fin dove poteva mai arrivare, e lo tenevano fisso a un punto dove brulicava uno sciame, quasi poteva dirsi, di lucenti insetti che si agitavano, rischiarati in quel momento da un nitidissimo sole di mattina. Era quello un corpo di riserva che stava sull'ale per accorrere in tempo, quando l'esercito Sforzesco si fosse trovato all'ultime strette.
L'uomo, principalmente, sulle cui vesti si vedevano luccicare le borchie d'oro, fissava lo sguardo a quel punto con quell'inquietudine, con quell'ansia, con quel turbamento, con cui un giuocatore sta aspettando il cadere del dado che gli darà la buona o la mala fortuna.
Ma quando all'orologio dell'abbazia scoccarono quattordici ore, e colui stanco dell'assidua attenzione, distolse un momento lo sguardo da quel luogo, non ebbe neppur tempo di ritornavelo, che quell'amasso lucente era già scomparso e non si vedeva più nulla.
—Reverendo abate, disse allora quel signore con un soprassalto d'alacrità che gli scintillava tra ciglio e ciglio. Gli Svizzeri son certo a mal partito; spero che la vittoria sarà pel re, e con un'affabilità eccessiva che non gli era punto abituale, strinse la mano del reverendo.
Detto e fatto questo, si appoggiò ancora al breve parapetto che interrompeva l'elegante traforo della guglia; e tornò a concentrarsi in sè, volgendo come per un moto macchinale uno sguardo disattento sulla campagna che gli si stendeva d'innanzi. Il suo aspetto a poco a poco era tornato alla grave ed inquieta attitudine di prima; quel primo bollore di speranza si era già raffreddato, i suoi pensieri avevan già cambiata direzione.
Del resto, era colui il magnifico Bentivoglio, lo scaduto signore di
Bologna, il padre della Ginevra.
Era uomo che già aveva varcato i sessant'anni, d'aspetto assai dignitoso e severo, e, più che severo, terribile. Pareva appartenesse a quella rigida stampa dell'epoca romana, con una faccia ampia, di forme grandeggianti, tutta ad angoli, con gran naso e gran mento, e nel complesso, qual potrebbe figurare uno scultore se mai volesse comporre un ideale di testa, adoperando le maschere di Seneca e di Bruto.
Parlava poco, rideva meno, pensava sempre. L'antichità del casato, il dominio della grande e ricca città che aveva perduto, i mezzi di ricuperarlo, erano gli assidui oggetti di quel suo pensare.
Sin dall'estremo scorcio del secolo decimoquinto, era stato per la prima volta assalito da quello spavento che, come epidemia, s'era impadronito di tutta quella folla di tiranni e tirannetti che padroneggiavano la media Italia, allorquando il Borgia aveva minacciato assoggettare a sè la Romagna tutta quanta, e non s'era fermato alle minacce. Sgombrato che fu, per l'improvvisa morte di papa Alessandro, quel tetro nuvolo che aveva oscurato l'orizzonte del suo potere, credè stornato ogni pericolo, e se ne tenne sicuro al tutto. Ma appena venne alla sedia pontificia Giulio Il, che non meno d'Alessandro e del Valentino bramava riconquistare alla Chiesa tutte le terre che già le erano appartenute, i timori gli si accrebbero assai più che prima, e nel 1506 ebbe infatti dal terribile Giulio perentoria intimazione di render Bologna, e minacce di fulmini spirituali e temporali in caso di rifiuto. Sicuro dell'ajuto dei sudditi, e più ancora delle promesse di Luigi XII, aveva risoluto sostenere l'assedio ch'era stato posto alla sua città; ma i sudditi non furono abbastanza valorosi, e il lealissimo Luigi, preso alle reti dal pontefice, col quale convenivagli acconciarsi, fece il suo comodo e lo tradì. Nella notte del 6 giugno di quell'anno, e fu gran ventura, potè fuggire dalla città, e raccolte quante ricchezze potè ammassare in quella dura stretta, ricevuto un salvacondotto da Chaumont, che comandava le truppe francesi, se ne venne a Milano coi due figli Annibale ed Ermete e colla Ginevra che allora poteva avere otto anni, e qui fermò la sua dimora. Non avendo in quel tempo a far nulla, ed essendo i due suoi figli già oltre l'adolescenza, a stornare i duri pensieri ed a fuggir tempo, si diede all'educazione della sua Ginevra. E mostrando la fanciulla tanto ingegno quanto è fuori dell'ordine di una donna, gli die' maestri di lettere, di disegno, di musica. Urceo era stato il primo maestro della fanciulla sin da quando erano a Bologna; in Milano fu affidata alle cure di Giovanni Filoteo, dottissimo uomo e buon poeta. Il Luino le aveva insegnato i principj del disegno, e uno Scandiano Monteverde, maestro nel conservatorio di musica fondato da Lodovico il Moro, e che fu il primo di tutt'Europa, gli apprese il canto e il suono della lira, genere di strumento che allora era in grandissima voga, per esserne stato suonatore insigne il mirabile Leonardo.
Recatosi poscia a Ferrara, dove aveva molti possedimenti, i soli con cui potesse mantenere il decoro principesco della famiglia, aveva ottenuto che Lodovico Ariosto contribuisse pure alla maggior educazione della figlia, la quale seppe rispondere così bene ai desiderj paterni che, non ancora uscita dell'adolescenza, destava la meraviglia in quanti ravvicinavano.
Intorno a quel tempo ricuperò Bologna, ma, come sappiamo, nel 1512, spodestato ancora di quel dominio, e con minori speranze di ricuperarlo, di nuovo ritornò a Milano. Vi ritornò colla sola Ginevra, avendo i due figli Annibale ed Ermete seguito l'esercito francese.
Nella fanciulla, in quel lasso di tempo, colle doti dell'ingegno s'era venuta sviluppando una bellezza di forme straordinaria, alla quale dava assai prezzo una leggiera tinta di quella severa maestà paterna, che ai giovani che la vedevano comandava l'ammirazione, senza far tacere l'amore. Non è a dire con quanta compiacenza lo scaduto signore di Bologna vedesse quella sua figlia, come ringraziasse la fortuna d'averla fatta nascere nella sua casa. Nè già l'amor paterno soltanto generava quella compiacenza, ma un'altra causa assai meno tenera e molto più forte, la grandezza della casa, il desiderio di ricuperare i suoi Stati, Qual signore di Bologna, egli aveva sperato, facendone fondamento sui pregi della figlia, ch'ella potesse venir chiesta in isposa da qualche principe regnante o d'Italia, o di Francia, coll'ajuto dei quali farsi forte, e riavere i propri dominj; quella sua figlia dunque era l'unico oggetto delle sue cure e dell'amor suo; ma in quest'amore v'era qualche cosa di geloso, di tormentoso, di pesante. In tanti anni di dimora in Milano non le avea mai concesso s'abbandonasse in dimestichezza colle fanciulle di altre nobili famiglie; neppure una volta lasciò ch'ella uscisse a piedi di palazzo; temeva quasi che l'atmosfera delle contrade, dove si confondevano le esalazioni plebee, potessero mai recare qualche offesa alla nobiltà della figlia.
Quando Milano era sotto il dominio francese, non aveva mai frequentato che il palazzo e la conversazione del governatore, dove la Ginevra fu più d'una volta l'oggetto dell'ammirazione generale, e quando ritornarono gli Sforza, qualche volta si recava alle feste del duca. Nella propria casa non concedeva accesso che alle più cospicue e antiche famiglie di Milano, con un riserbo però, con un cerimoniale, con un'etichetta, che poteva anche promovere la nausea. Qual signore, benchè scaduto, d'un ampio stato in Italia, egli pensava che in tutta Milano non v'era alcuno che potesse stargli a paro, nè di nulla era più curante che di far spiccare e rispettare codesto primato. Il titolo di magnifico signore, era il solo che lo mettesse di lieto umore, che gli facesse distender le rughe della calva sua fronte. Di null'altro era più tenero che dei propri titoli, di nessun'altra cosa prendeva passatempo che della lettura della storia del proprio casato e della sua Bologna. Dal momento che gli era sfuggito di mano il potere reale, cominciò a vagheggiare con un amore ardente, geloso, permaloso, le immaginarie prerogative della nobiltà. Molte volte avveniva, che trovandosi a far qualche parola con taluno dei signori milanesi che non appartenessero al più squisito patriziato, una loro parola non abbastanza misurata, un atto, un gesto troppo confidenziale, al quale per inavvertenza si lasciassero andare, una stretta di mano datagli senza pensar molto alla diversa inquartatura dello stemma, qualche cosa insomma che gli potesse far sospettare avesse voluto quel tale o porsi al livello di lui, o abbassar lui al livello suo, bastava di tratto a mettergli i dispetti nel sangue, a farlo di improvviso diventar cupo, accigliato, inquietissimo.
E coloro che avessero voluto spiegare quei repentini mali umori, potevano benissimo darne causa o al mal di capo, o al dolor di denti, o ai reumatismi, ma non mai a quel che era veramente, perchè quel signore talvolta faceva poi anche l'affabile e il liberale, nè tutti erano così acuti da tener nota delle occasioni in cui lo faceva, nè sapevano accorgersi che anche allorquando dava cortesi parole a chi era da meno di lui, procurava tuttavia, nel mezzo della folla, di tenersi alto di tutta la testa appoggiato ai trampoli del suo grado.
Chi tiene fra le mani la verga del comando ed è ancor ricco di potenza fisica, vedendo in che e in quanto avvantaggia gli altri, il concetto che può aver di sè stesso non trascende giammai i limiti, perchè la realtà gliene dà la giusta misura. Ma chi, invece, non ha altro al mondo che quel fluido imponderabile, il quale vien detto nobiltà, non potendo sapere quel ch'ella sia precisamente, ajutato dall'imaginazione le attacca quel valore che più gli piace, e col superbo fantasticare va tanto innanzi che gli riescono angusti i più estesi confini.
Chi scrive conosce un tale della costola d'Adamo, uomo del resto di molto ingegno e di miglior coltura, e, come parve a taluno, anche di assai buon senso, il quale tiene per fermo che i patrizi sieno, nella grande catena, d'un bel tratto più presso a Dio che non il resto del genere umano; assunto che si affanna a dimostrare con una convinzione veramente prodigiosa, e, quel che più fa maraviglia, senza che il vino gli abbia dato alla testa.
Ora, tornando al Bentivoglio, era verissimo quanto di lui aveva saputo il Morone da quel tal Marsiglio di Lodi. Verissimo che essendogli giunto a notizia l'arrivo del Baglione (il quale, a gratificarsi i Francesi, avea seco condotto cinquecento lance per aggregarle all'esercito del re, e intanto aveva posto gli alloggiamenti a Lodi) tosto erasi colà recato a visitarlo.
Sebbene egli avesse trovato il Baglione invecchiato ed orrido da far paura, tuttavia avea subito tentato riannodare il filo che, tre anni prima, era stato mal suo grado spezzato. Come il lettore ben sa, era il Baglione tra' più facoltosi e potenti signori della Romagna, e per l'ajuto di Francia, era possibile avesse a salire più alto ancora, e il Bentivoglio, per quanto cogli ambiziosi desiderj girasse lo sguardo fra tutte le teste coronate d'Italia e fuori, non avea però mai trovato un personaggio migliore del Baglione con cui collocare la propria figlia, e collocarla in modo, che potesse esser d'ajuto a lui medesimo. Però, quando Giampaolo era stato improvvisamente assalito da quei mali che in tutti gl'Italiani aveva indotto la speranza, anzi la certezza, fosse per morirne in breve, egli si tenne perduto, vedendosi tolto un così valido mezzo a ricostruire lo scrollato edifizio; per questo è facile immaginarsi il contento di lui, allorchè, fatte quattro parole col Baglione, tosto comprese esser colui ancor pronto a sposare la Ginevra, benchè gli avesse posto una condizione.
—Aspettate si spieghi la fortuna di Francia, aveagli detto il signore di Perugia, aspettate che s'abbia a conoscere in quanti piedi d'acqua siamo noi, e allora la discorreremo. Domani o dopo si verrà ad una decisiva giornata. Domani o dopo quel che avrà a stabilirsi fra noi sarà stabilito. Del resto, io sto qui e non mi muovo, le mie lancie son condotte da Orazio, e se venni qua in persona io stesso, è perchè ho bisogno di tener quattro parole col re. Sto attendendo anch'io con impazienza quel che sarà per uscire da tutto ciò, ma spero bene. Ho una gran sete, caro mio, e mi conviene patire l'arsura finchè non vegga recisi gli unghioni di leone da questo ragazzo di re. Tengo nella stía della mia Perugia ad ingrassare, tre capi di pollame ai quali tireremo il collo quandochesia; un protonotario che ci ha tradito, un vescovino che s'impacciò di battaglie, un cardinale che si balocca colle daghe, le misericordie e gli schioppetti. Se dunque i Francesi si comporteranno bene, il papa farà cantare il miserere per tutt'e tre, e non avrò più un timore al mondo di lui. Allora venite qui, e senz'attender altro, qualche cosa si farà. La vostra figlia mi piace e la sento lodata da tutti, e, in quanto a me, sebbene allorchè spira tramontana mi vengano ancora certe doglie acute, pure qualche bollitura di gioventù me la sento ancora fra le vene.
A queste parole, sentitosi tutto confortare, il Bentivoglio era ritornato a Milano per preparare la figlia a quelle nozze che dovean essere imminenti; e in quel modo che tre anni prima s'era mostrato così insensibile ai pianti disperati della unica sua figliuola, lo fu anche in codesta occasione, e più ancora. Eppure s'ella gli fosse morta allora se ne sarebbe rimasto fortemente addolorato per tanta sventura, e avrebbe sparse lagrime abbondanti e sincere; ma trattandosi di ricuperare Bologna ogni fonte di pietà veniva essiccandosi in lui, e del resto, a spiegare i fenomeni dell'ambizione e' è un assortimento di sentenze l'una più decrepita dell'altra.
Dal dipendere adunque le nozze di sua figlia dall'esito della battaglia, è spiegata la cupa inquietudine del Bentivoglio in questa mattina del 15 settembre. Appena i cinquantamila svizzeri erano usciti di Milano e li seppe arrivati tra S. Donato e Marignano, anche egli tosto uscì della città, e si recò in un suo palazzotto ove si ritraea assai spesso quando, infastidito della fastosa ricchezza dei numerosi patrizj milanesi, che non parevano far di lui quella stima ch'egli pretendeva, aveva bisogno per dimenticare il fastidioso spettacolo della città, della solitudine e del silenzio d'un luogo dove nessuno potesse contrastargli il primato, e a lui fosse lecito di reputarsi quel che meglio gli fosse piaciuto. S'era poi scelto a dimora un luogo vicino all'abbazia di Chiaravalle perchè gli piaceva intertenersi col reverendo abate che già aveva conosciuto sino dal 1504 a Bologna, nella quaresima del qual anno aveva colui predicato in San Petronio con straordinario concorso di tutta la città. Più cose poi aveva stabilito il Bentivoglio dopo l'abboccamento avuto col signore di Perugia, l'una, che il reverendo abate di Chiaravalle fosse colui che benedisse gli sponsali, l'altra che non doveva correre più d'un giorno dopo l'esito della battaglia senza che le nozze fossero già strette, la terza che non sarebbe entrato in Milano prima che ad ogni cosa fosse dato compimento, e gli sposi con gran pompa facessero il loro ingresso in Milano intanto che vi si rimetteva il governo francese. Siccome però di codeste cose, per quanto esso fosse intestato di volerle assolutamente, pure poteva benissimo darsi il caso che non ne avvenisse neppur una, così contrastavano e cozzavano nella sua testa molti pensieri in quel mattino, e le ore che aveva trascorse sulla guglia dell'abbazia furon certo delle più tormentose della sua vita.
Stato adunque per qualche tempo appoggiato al parapetto della guglia, e incessantemente perturbato dalla tormentosa vicenda dei dubbj e delle speranze, al sentire le onde dell'aria sempre più agitate dagli scoppj continuati dei cannoni e delle artiglierie:
—Oh fossi anch'io colà, uscì a dire con impeto. Codesto sole cocente, che da tre ore mi batte sul capo, mi abbrucia più d'un razzo d'artiglieria. E non so nulla di quel che avviene a sì breve distanza da me, e tanto si aveva a rimanere sotto coltre.
—Fra breve ci sarà ben nota ogni cosa, rispondeva l'abate.
—Volesse Iddio che vincesse il re.
—Io l'ho pregato perchè volesse il meglio. E tornarono a tacere, e un'altr'ora misurò la sfera dell'orologio dell'abbazia, senza che essi mai rompessero il cogitabondo silenzio.