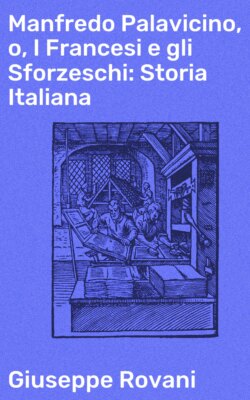Читать книгу Manfredo Palavicino, o, I Francesi e gli Sforzeschi: Storia Italiana - Giuseppe Rovani - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO II
ОглавлениеIndice
È una sala vastissima quella che ci si apre d'innanzi, nella quale l'eccedente sfarzo del lusso asiatico è temperato alcun poco dall'eleganza e della squisita gentilezza del genio italiano. L'ampia soffitta non è nè a vòlta, nè a travi. Una vetriera, divisa in mille scompartimenti di piccoli vetri circolari e a tanti colori quanto ne può dare un'artistica combinazione, l'attraversa e la ricopre tutta, lasciando libero il passaggio agli ultimi raggi del sole. I paramenti che ne vestono le pareti, nelle quali sono aperti sei grandissimi finestroni di stile gotico, son tutti di drappo d'oro riccio sovra riccio con ornamenti di vaghissimo lavoro. Il cornicione che la rigira è tutto messo ad oro ed azzurro oltramarino, sul quale disposti in bell'ordine e in gran numero stanno ampi vasi di varie e preziosissime materie d'oro, d'argento, di pietra alabastrina, di porfido, di serpentino e di mille altre specie. A due terzi della sala, quasi a formarne una divisione, due cortine d'un ampio velone di drappo d'oro tutte chiuse fino a terra, sono fermati per molti anelli ad un arco di ricchissimo ornato che poggia ai capi sul medesimo cornicione, attraversando pel largo la sala. Le scene più molli e voluttuose della favola sono il soggetto dei dipinti che, chiusi in larghe cornici, stanno appesi, in bell'ordine, intorno intorno alle pareti. Qui un Endimione colla sua Diana, e Bacco appoggiato a sdrajo sulle ginocchia d'Arianna, là una Leda coll'indivisibile suo cigno, e una Danae colla pioggia d'oro. Dirimpetto Orfeo ed Euridice, Ero e Leandro, Ercole e Dejanira. Ovunque quadretti d'ogni sorta; danze d'amori, Najadi nuotanti, ninfe ignude, scherzi voluttuosi di mille foggie; e in mezzo a codesto apparato artistico, su d'una tela molto più ampia delle altre, l'inevitabile giudizio di Paride. Da certi sfori praticati nel pavimento si mostrano, quasi a simulare una selva naturale, arbusti d'ogni maniera. Aranci, mirti, palme agitanti ventagli di verdura, roseti incoronati e larghe di candide foglie, aceri, tulipiferi, alcee, gelsomini d'Ischia, giacinti, viole, amaranti, che spandono un miscuglio di profumi. E su quei rami di quelli arboscelli, legati con crini sottili, svolazzano uccelletti d'ogni sorta, rosignuoli, capinere, pettirossi, rigogoli zufolanti, rondinelle gorgheggianti, palumbelle gementi, che diffondono suoni d'una graziosa e melanconica monotonia; se non che, di quando in quando, a coprire quei canti minuti della natura, dal di dietro dell'ampio velone si dilata un'armonia artificiale e più solenne. Le note di un organo da stanza.
A popolare quel luogo incantevole se ne stanno alcune in piedi, altre sedute, altre sdrajate, a due, a tre, a gruppi, tutte in atteggiamenti di una molle eleganza, molte leggiadre fanciulle incoronate di fiori, vestite di bianchi veli; e in mezzo a quelle fanciulle, tutto assorto in fantastiche contemplazioni sta adagiato su larghissimi cuscini di raso, un giovane avvolto in una magnifica roba di stoffa cilestre.
A guardare il suo volto, liscio e levigato come quello d'una fanciulla, si conosce che nessun forte pensiero, nessuna energica azione, nessuna passione profonda non ha mai agitata l'anima sua. Soltanto quel pallore abituale e senz'orma di vermiglio dà a divedere un'esistenza infiacchita dall'abuso dei piaceri e dalle tormentose irresoluzioni dell'anima. Da una tavola di tartaruga a fini ed eleganti intarsi egli prende di tratto in tratto a leggicchiare taluno dei molti libri che vi stanno dischiusi. C'è un Ovidio, un Catullo, alcuni canti del poema dell'Ariosto; e di quando in quando accostandosi alle labbra una conchiglia legata in oro va sorseggiando alcuna goccia d'un liquor forte e spiritoso. La fragranza dei fiori, lo spettacolo della voluttuosa bellezza, i suoni dell'organo gli popolano la mente di mille e svariate idee, di luccicanti fantasie, di trepide gioje, cui la virtù di quel fortissimo liquore, avendo in prima rese più acute, e più ardenti, le va ora agitando in vertiginosa danza, producendovi quell'ebbrezza luminosa che è il paradiso di chi ha infiacchita la fibra e mobilissima l'immaginazione.
Ora, a queste apparenze, chi direbbe che costui è il duca Massimiliano Sforza, il successore dello sventurato Lodovico, morto di crepacuore e d'inedia in Francia negli ultimi anni di Luigi XII; che benchè sieda da tre anni sul retaggio del padre suo, il padrone dello Stato non è lui, e la parte migliore e più forte del popolo non è per lui, che la sua cassa privata è vuota, e non avendo esercito proprio, gli mancano i denari per pagare quel di ventura al quale ha a sborsare ottocentomila ducati d'oro; intantochè Francesco I, re guerriero, ha già invasa la Lombardia con più di ottantamila uomini? e a poca distanza si è già fatta sentire l'artiglieria nemica?
Vi hanno uomini temprati in modo, che riescono al tutto inetti a qualunque occupazione richieda uno sforzo della mente e della volontà. Le dolcezze e gli svagamenti della vita hanno tale attrattiva per costoro, e il dilungarsene un solo momento dà ad essi così incomportabile dolore, che hanno per bisogno indispensabile dell'esistenza, ciò che per altri è semplice sollievo.
Questa morbosa tendenza, (che, non so se debbasi chiamar colpa); essendo al tutto contraria alla destinazione dell'uomo, in qualunque condizione esso si trovi, non può che condurre a rovina; però avviene spesso che coloro i quali dei piaceri s'eran fatti un'assoluta necessità, vengano a trovarsi in così terribili situazioni, e a provare tali miserie quali non toccano al comune degli uomini. Allorchè poi la caduta è imminente, s'attaccano costoro, con uno sforzo che dà la disperazione, ai piaceri che fuggono, procurando di renderne tanto più acuta l'ebbrezza, quanto più si avvicina l'istante dell'affanno.
A questa classe d'uomini per la sua e per l'altrui disgrazia, apparteneva appunto il giovine duca Massimiliano.
Portato dagli eventi a ricuperare il ducato di Milano del quale suo padre era stato spodestato, la natura lo aveva così destituito delle qualità indispensabili a chi è posto a governare uno stato, ch'egli credette fosse per lui occasione di continuo tripudio, quel che invece doveva essere oggetto di una laboriosa ed assidua cura. Più scolorato e più floscio assai di Galeazzo Maria, parve tenesse alcun poco dell'indole di quel tristo. In lui per altro la mollezza invadeva anche la parte che nell'altro era stata occupata dalla crudeltà, e fu solo a tratti e a sbalzi che anch'egli ne mostrò qualche fioco barlume, il quale per fortuna, non ebbe mai un effetto. In conclusione, una leggiera sfumatura di pazzia pareva avvolgesse tutte le qualità intellettuali e morali di questo giovane, per cui piuttosto che maledire le sue colpe, ci rimane a rimpiangere la fatalità che volle affidare ad una mano morbida e tremolante ciò che aveva bisogno di un braccio di ferro.
Del resto non si ha a credere che questo giovane duca, nel momento in cui lo abbiamo sorpreso nella segreta sua sala, ignorasse in che dura condizione egli si trovasse. Il Morone lo teneva assai bene informato di tutto, ma ciò che per altri sarebbe stato causa di uno sgomento continuato, in lui non generava che momentanee tristezze e prostrazioni d'animo talvolta eccessive, ch'egli procurava tosto di rintuzzare e affogare nei gaudii e nell'ebbrezza.
Le sue idee, nel momento in cui stava bevendo quest'ultima goccia di spiritoso liquore, esaltate, mosse rapidamente, intrecciandosi e confondendosi insieme, assumendo mille colori, costituivano un così intricato complesso da non potersi facilmente a parole tradurre.
Tuttavia, a seconda che il pensiero della sua condizione, o il coraggio artefatto che la forza del liquore metteva in lui, o la vista delle cose da cui era circondato generava nella sua mente qualche nuova idea; in quell'istante parlava tra sè, presso a poco, di questa maniera: "…. Oh venga la tetra calamità, se così piace ai duri destini, ma intanto ch'ella più mi si avvicina, più io mi stringerò a voi, soavissime illusioni della vita… Finchè i fervidi estri inonderanno di viva delizia i miei sensi, io non vorrò già atterrirmi nello scroscio dei naufragio… Qui mi hanno condotto i miei destini, senza ch'io pure lo bramassi nemmeno, di qui mi partirò tranquillo quand'essi suoneranno a ritratta…. Le atroci gioje della conquista e della vittoria, non voglio che rallegrino mai nessun giorno della mia vita… Ben sento che ai miei piedi brulica un innumerevole sciame di popolo, e a me si rivolge nella bisogna tremenda… Volgiti altrove, volgiti a te stesso; io non posso nulla per te…. Fintanto che l'onnipotente ricchezza mi cresceva tra le Mani, ognuno potrà dire quant'io ne fossi liberale con tutti; come ad una ad una mi scastonassi le gemme della mia corona, per donarle a coloro che più mi stavano d'appresso… Volgiti altrove, o mio popolo, volgiti a te stesso, volgiti alla provvidenza che tutto può… e ti allontana una volta, che le tue grida fanno strazio del mio cuore e troppo infastidiscono le facoltà mie infervorate di solo amore…
"Oh vi stringete d'intorno a me, soavi fanciulle, ch'io senti più d'appresso le divine armonie della vostra bellezza, e i cari abbracci promovano in me il trepido senso dell'estrema voluttà…. Oh venite e frapponetevi tra me e il mondo, così ch'io non veda e non senta più nulla della sua vorticosa incessante faccenda…."
In simili pensieri, e via rapito da una muta contemplazione, trascorse qualche tempo in mezzo alle sue fanciulle che gli si eran strette intorno. Gli ultimi raggi del sole intanto s'eran del tutto ritratti dalla vetriera che copriva la sala, e la pallida luce crepuscolare, attraversando i vetri, a fatica vestiva di un color cupo e misterioso tutti gli oggetti che stavan d'intorno al duca.
In quelle fanciulle una ve n'era d'una straordinaria bellezza che pareva esser cara al giovane duca più che le altre tutte, e più che le altre essergli ella medesima affezionata. Questa essendosi da qualche tempo avvicinata a lui, con una tristezza eloquente nel medesimo silenzio, pareva attendesse che il duca le volgesse qualche parola.
Questo infatti posò finalmente uno sguardo su lei e:—A che pensi? le disse.
—Penso a voi, mio signore, ed a me stessa, rispose la giovinetta; penso che non sarà mai ch'io mi disgiunga da voi oggi; penso ch'io vi seguirò dovunque sarete per andare, o signore.
—Taci, Gliceria, e non turbarmi l'anima con preghiere che non mi è concesso d'esaudire; finchè rimarrò in castello, a nessuna di voi più non si conviene lo stare con me… l'ho detto, e non può essere altrimenti.
La giovinetta, a tali accenti, chinò il capo e stette per qualche tempo senza parlare… ma poco dopo rialzando lentamente la testa e volgendo un mestissimo sguardo intorno:
—Addio dunque, sclamò con accento particolare pieno d'entusiasmo insieme e di dolore profondo, addio, stanza gradita: noi ti abbiamo a lasciare, il cuore mi dice, per sempre… noi non ci troveremo più qui… il mio signore non mi vuol più con sè, il mio signore mi ha rifiutato, i momenti della nostra gioia sono finiti….
Queste parole, come un soffio di vento gelato, che gli rasciugassero il calido madore della fronte, a poco a poco fermarono l'ebbra vertigine ch'era nella mente del duca; a produrre codesto effetto però avea concorso un'altra causa, senza cui le parole stesse sarebber cadute inavvertite.
È una legge fisica costante, che le bevande, dopo aver generato in chi ne abusa una vivezza, un'alacrità straordinaria di spiriti, producono poi una tale prostrazione di forze, un abbattimento così completo, che l'esistenza, di cui poco prima si avevano le più dolci sensazioni, ci si fa un tratto pesante, odiosa, insopportabile.
E un tale fenomeno, in quel momento, cominciava appunto a prodursi nel giovane duca. Il forte liquore tanto abusato, dopo averlo esaltato al massimo dell'alacrità, cominciava a lasciar in lui come un deposito di amarezza, una melanconia tetra ed inesplicabile, un malessere in tutta la persona che gli vestiva di tristezza tutte le cose che gli stavano intorno.
Se non che in una tale occasione, quel repentino malessere venne accresciuto dalle altre cagioni, le quali ancor più fieramente influirono per essere le stesse sue forze fisiche già tanto infiacchite.
Le parole della fanciulla, l'oscurità successa alla splendida luce del dì, che lo avvisavano ch'era vicina l'ora di ritirarsi in castello e di abbandonare le delizie del palazzo ducale, l'intricata condizione delle cose sue, l'incertezza degli eventi, i pericoli inevitabili… tutte queste cose lo assalirono allora di tanta forza, che assaporò tutto quell'amaro che pur troppo esubera nell'umana vita.
E ad accrescerlo dopo alcuni istanti s'udì lo squillo di una campana, squillo atteso da lui con tremore e sgomento. Era quello il segno con cui veniva chiamato il duca a recarsi nella gran sala di palazzo dove tutto il suo seguito stava raccolto per ritirarsi con lui in castello. Essendo assolutamente vietato di recarsi in quella sua sala, quand'egli si trovava colle sue donne, con quel segnale veniva chiamato ogni qual volta fosse bisogno della sua presenza. E a quello infatti il duca si alzò…. Era diventato più pallido la metà del solito…. Il tremito dei nervi che il liquore medesimo aveva prodotto in lui, in quel momento gli si accrebbe tanto, che parve non gli bastassero le forze di reggersi in piedi, ma a sostenerlo gli si serrarono intorno le sue fanciulle con abbracciamenti e con lagrime…. La commozione in lui, forse per un certo presentimento che l'avvisava che non sarebbe tornato mai più in quel luogo, era giunta al massimo punto, e non udendosi nella sala altro che i pianti di quelle fanciulle, ai quali s'intrecciavano i singulti delle palombelle che svolazzavano sulle palme e sugli aceri, anch'esso fu assalito da un angore insopportabile e da un empito di singhiozzi che finalmente scoppiò; e come se fosse un fanciullo diede in lagrime dirottissime e pianse lungamente….
Davvero che quella vista era indegna, quella mollezza eccessiva, que' propositi, que' pianti vituperosi… tuttavia, allorquando un uomo è infelice ed è alle prese col massimo affanno, egli è sempre degno di pietà e non ci può essere ragione che la vieti, neppure la colpa, se fosse concesso il dirlo….
Stato così qualche tempo, si staccò finalmente dalle sue donne ed uscì.
In un'altra sala del palazzo ducale stavano intanto ad attenderlo coloro che lo avevano ad accompagnare in castello. Tra una folla di paggi, di camarlinghi e di labarde svizzere, passeggiavano molti distinti personaggi. Un uomo di forse quarant'anni, di statura e corporatura mediocri attendeva a discorrere col duca di Bari, fratello di Massimiliano….
Era colui il celebre Gerolamo Morone, il quale avendo deposta su d'una tavola la sua berretta di velluto nero riccio, mostrava una cappellatura bionda-rossigna, un po' crespa che gli scendeva oltre l'orecchio. L'ossatura del viso era notabilmente minuta, e solo la fronte appariva alta ed ampia più di quanto il comportasse una giusta proporzione. Le pupille di un castagno assai chiaro giravano con gran rapidità sotto le palpebre, che abitualmente teneva semichiuse quasi a rendere più acuta la facoltà visiva.
Del resto, chi volesse avere di lui un ritratto più fedele di quello che noi possiamo esibir qui, non avrebbe a far altro che recarsi ad ammirare una tavola del Leonardo posseduta da un'illustre casa milanese, dove il cancellier Morone si presenta a chi lo guarda come se fosse ancor vivo e vero.
Presso al Morone, in abito civile si vedeva il cardinale di Sion, il capitano generale delle guardie svizzere, un uomo assai presso a sessant'anni, e nelle linee risentite del suo volto era chiara l'indole sua, e di fatto, l'odio per la Francia formava in lui come una seconda natura.
Lontano da questo gruppo, in mezzo ai camarlinghi ed alle labarde passeggiava un giovane gentiluomo. Alto di statura da soverchiare tutti i soldati tra cui si trovava, era notabile per la bella regolarità delle sue forme, per una tinta di gravità cogitabonda e soverchia in uom giovane, pel suo schietto e semplice vestire di velluto verde senza altro ornamento che una sottile catena d'oro che pendula gli cascava sul petto. Questo giovane era in quel momento l'oggetto dei sommessi discorsi del Morone e del duca Francesco Sforza.
—Io vi consiglio, diceva il Morone, a non dir nulla al Palavicino dell'arrivo del Baglione tra noi, e delle pratiche che il padre della Bentivoglio ha già inoltrate con colui. Forse adesso non c'è altri che abbia sentor di ciò in Milano, ed è probabile che il giovane non arrivi a saper nulla prima della battaglia. In ogni modo lasciate che le cose camminin da sè, nè gli dite cosa che possa metterlo in apprensione.
—Io non parlerò, ve ne do parola; ma se non lo saprà da me, lo saprà bene da altri, ch'egli è impossibile che non ne sia trapelato nulla in Milano… a quest'ora la figlia stessa del Bentivoglio troverà bene il mezzo di renderlo avvisato di tutto.
—Sapete pure che il Palavicino non ha la pratica della casa del Bentivoglio, nè in altro luogo parlò mai alla Ginevra che in questo palazzo medesimo in occasione di pubbliche feste. Però, essendo probabile che la cosa gli rimanga segreta, attendete voi pure a far quello ch'io vi dico che sarà pel meglio, e il suo coraggio non gli verrà scemato così da questa nuova sciagura.
—La stornassero almeno da lui i suoi santi protettori, come hanno stornato l'attentato di ieri notte!
—Così fosse, lo dico io pure.
—A proposito, messere… non han deposto altro i quattro assalitori?
—Null'altro… ma da quello che mi disse il Palavicino stesso, tengo il colpo sia venuto dal Lautrec.
—Dal Lautrec? il maresciallo di Francia?
—Da lui stesso; fatevi raccontare ogni cosa dal Palavicino stasera, e vedrete anche voi come la mia e la sua congettura non sia in fallo, sebbene di certissimo non ci sia nulla ancora. Sentirete….
In questa si spalancò la porta di prospetto, e il duca in mezzo a due uomini di camera si presentò a coloro che lo aspettavano. Il Morone e il cardinale di Sion gli andarono incontro e lo condussero nel mezzo della sala, presso al duca di Bari, che non si mosse.
I due figli di Lodovico il Moro, il primo ed il secondogenito si trovavano vicini; tutti gli sguardi di quanti si trovavano in quella sala caddero sui due fratelli, e non vi fu chi non pensasse allora, che le sorti sarebbero forse corse più propizie per Milano se Francesco Sforza fosse stato il primogenito invece di Massimiliano.
È una cosa curiosa che di quel miscuglio di grandi virtù e di molti vizi che distinsero la dinastia sforzesca, quando si venne a due figli di Lodovico, che erano destinati a chiuderla per sempre, avvenne, quasi potrebbe dirsi una compiuta secrezione.
Osservate le restrizioni debite, e avuto riguardo ad una quasi degenerazione, per la quale e vizi e virtù, passando di padre in figlio, grado grado si eran venuti dilavando, pare che i destini abbiano diviso in due esatte metà quel retaggio, come a compensazione ai vantaggi della primogenitura abbiano accollato il tristo fardello di tutti i vizi della dinastia, ed alla secondogenitura abbian dato per conforto le virtù, onde la dinastia stessa, al primo comparire sulla scena del mondo, era stata splendida di una luce non moritura. Persin nell'aspetto, quantunque tra due fratelli fosse grandissima la somiglianza, c'era qualche cosa che dinotava questa esatta divisione. A Massimiliano era toccata quella bellezza morbida e fiacca che già abbiamo avuto il tempo di ammirare. A Francesco invece l'ampia fronte, le linee grandiose del primo Sforza, l'acuta e vivace bellezza della Beatrice sua madre, e un po' di quel bruno che aveva dato il secondo battesimo a suo padre Lodovico.
Il Morone, dette in prima alcune parole al duca Massimiliano, il quale senza mai aprir bocca solo si accontentò di mostrare una faccia stravolta e accorata, si volse al cardinale di Sion dicendogli, che non era a porsi altro tempo in mezzo, e tosto desse gli ordini alle labarde di precedere il duca. Così tornò a spalancarsi la gran porta, e tutti quanti stavano assembrati in quella sala, l'uno dopo l'altro uscirono. Il duca in mezzo al Morone ed al cardinale, dietro lui il duca di Bari che si era accompagnato col Palavicino, e in seguito tutti gli altri gentiluomini.
Discesi al piede della gran scala, ventiquattro uomini con torce accese stavano ad aspettare intorno ad una larga botola con aperta cateratta. Tra il palazzo ducale e il castello di Porta Giovia era stata aperta una via sotterranea di comunicazione, la quale veniva praticata ogniqualvolta piacesse al duca recarsi in castello senza mostrarsi al popolo. In questa straordinaria occasione il Morone aveva consigliato il duca ad uscire per di là, e quella botola conduceva appunto alla via sotterranea.
—Attendete a star di buon animo, disse il Morone al duca quando fu per discendere; stasera sarò io medesimo in castello; e si licenziò.
Accompagnato dal cardinale e preceduto da sei torcie, discese dunque pel primo il giovane duca. Dopo lui discese tutto il seguito in mezzo alle altre diciotto torcie. Quando s'udì il rimbombo che fece la cateratta rivestita di ferramenti nel cadere sull'incastro della botola, tutti si misero in via.
Fu un viaggio lugubre quanto mai poteva esserlo, nè il duca aprì mai bocca, nè altri. Solo il duca Francesco, che camminava a paro col Palavicino, gli disse un tratto a voce sommessa e come di fuga:—Il Morone mi ha fatto parola del Lautrec; in castello mi dirai tu il resto.
E tenendo stretta la mano del Manfredo con un'affabilità ed amorevolezza straordinarie non aggiunse altro finchè durò il cammino.
Ma noi, cogliendo questo ritaglio di tempo, terremo qualche parola del Palavicino, per quel tanto che può bastare a mettere in luce alcune condizioni particolari alla vita di lui.
Figlio al marchese Anton Maria Palavicino ed alla contessa Giulia Flisca, che, giovinetta, aveva sposato il marchese già vedovo, già padre di quattro figli e già vecchio, trovò nel seno della propria casa più di quanto poteva bastare per alienarlo da lei e dal ceto patrizio a cui la famiglia apparteneva. Fanciullo, fu affidato alle cure degli uomini che allora più fiorivano in Milano per lode di buoni studi e d'ingegno. Giovinetto, ebbe a maestri il Merula, il Calcondila, il Minuziano; studiò geometria e logica dalle pubbliche cattedre istituite da quel Tomaso Piatti stato in sì gran favore presso Lodovico il Moro. Oltre l'ingegno non comune, aveva dati segni di un'indole al tutto particolare, un misto di procelloso e di tenerissimo, di violento e d'affettuoso, con eccessi di giocondità e di concentrazione profonda. Qui racconteremo succintamente due fatti leggeri in sè stessi, ma che, mentre valgono a dare alcuna idea di codesto suo temperamento, potranno anche far conoscere i primissimi motivi, dai quali in certo modo fu determinata la vocazione dell'intera sua vita.
Trovandosi, quand'era fanciullo di circa otto anni, presente al racconto che Cristoforo Palavicino, fratello di Anton Maria, faceva del modo col quale Lodovico il Moro era stato preso da' Francesi, fu insensibilmente attirato dalle parole dello zio, il quale, a differenza del fratello, essendo piuttosto sforzesco, narrava il fatto con quell'accento di verità e di compassione che si imprime negli animi. Quando si fu al punto dell'imprigionamento dello Sforza, la contessa Giulia, che si teneva in grembo il fanciullo, vide cadere due grosse lagrime sulle guance di lui e tremare di commozione i suoi labbruzzi infantili. Nè questo bastò; ma quello che fece una profonda impressione in tutti gli astanti, quando si parlò dei due figli del Moro, dei pianti disperati del secondogenito Francesco nel momento che fu staccato da suo padre, il fanciullo Manfredo, che lo aveva conosciuto e s'era trovato spesso con lui ne' giardini ducali, diede in un sì dirotto pianto con tanta furia di singhiozzi, che la madre penò molto ad acquetarlo; e fin da quel momento ogni qualvolta in sua presenza parlavasi di Francesi si riscuoteva tutto, e la bella sua faccia si rannuvolava.
Nel 1507 un'altra circostanza accrebbe ancor più quell'avversione che il giovinetto aveva per Francia. Venuto re Luigi in Milano per la seconda volta, il marchese Anton Maria volle invitarlo ad uno splendido banchetto nel proprio palazzo. Godeva quel re intrattenersi famigliarmente con tutti, e dilettandosi a far domande ora all'uno, ora all'altro, s'era pure in quel dì rivolto al giovane Manfredo, il quale o stesse sopra di sè impensierito, o fosse dispettoso di quella domanda, non seppe o non volle rispondere. Il re attribuendo a quel silenzio una causa troppo lontana dal vero: questo giovane dev'essere ben sciocco, disse in francese ad uno de' suoi cortigiani, e si volse altrove. L'indole altiera di Manfredo, che aveva comprese troppo bene quelle parole, rimase così colpita e piagata, come se gli fosse avvenuta qualche sventura, e Luigi gli diventò così odioso, che ad arrovesciargli l'animo non v'era cosa più pronta che nominargli quel re.
Ma l'anno 1512 fu per lui ben più terribilmente memorabile. Le cronache non raccontano con chiarezza il fatto; ma tra il Palavicino e il nipote del governatore Chaumont intervenne una gravissima contesa che finì colla morte del giovane francese ucciso da Manfredo in duello.
Il padre suo Anton Maria, che di questa terribile avventura fu più addolorato assai che il governatore medesimo, a dar prova del suo attaccamento a lui ed alla Francia, la notte medesima del giorno in cui era avvenuto il fatto, appena gli giunse a notizia, cacciò di casa e solennemente diseredò il giovane Manfredo, a nulla giovando le preghiere e i pianti disperati della madre Flisca che, amando svisceratamente l'unico suo figliuolo, da quell'ora non ebbe più un momento di pace.
Da quell'anno in poi il giovane Manfredo stette fuori, nè ritornò in patria se non dopo aver redate le immense ricchezze del fratello della madre sua che, a compensarlo dell'irremovibile e mostruosa severità del padre e dell'odio de' fratelli lasciò lui solo erede d'ogni suo avere. Ma il giovane non stava pago di questi compensi che la fortuna gli volle esibire.
Avendo compreso, che con quel marchio del paterno ripudio era per lui ben più difficile che ad altri l'aprirsi una via tra gli uomini, gli venne un desiderio ardente di operare alcuna cosa di grande e di generoso per mostrare così ch'egli era degno d'una sorte migliore, per meritarsi così la stima e l'amore degli uomini.
Desiderio che fu potente a temperare in lui quell'eccessivo amore di sè che l'istinto mette nell'uomo, e a mettergli innanzi come indeclinabile la legge sublime del sagrifizio.
Non avendo dapprima in che trasfondere quell'esuberanza d'affetto che lo agitava, ributtato dai vani splendori e dalle pingui prosperità, s'egli mai girasse l'occhio per cercare qualcheduno del mondo a cui affidarsi, sempre, per una tendenza invincibile, lo posava dove la sventura avesse infranta o spostata qualche esistenza, dove l'umana dignità fosse stata con eccessivo rigore umiliata, dove l'ingiustizia avesse scagliata la sua sentenza inesorabile. L'amore istesso ch'egli naturalmente portava alla giovane sua madre, gli s'accrebbe a mille doppi quando la seppe così infelice, quando s'accorse ch'ella aveva bisogno che taluno la difendesse contro agli sdegni dei vecchio marito, contro il rancore degli altri figli non suoi.
L'uomo d'ingegno e di cuore sente assai più bisogni in sè, che non il volgo degli uomini; egli s'accorge che nell'esistenza v'ha più d'una sfera d'azione: la famiglia, la vita privata, la pubblica, e che per essere completo, un uomo deve appunto versare in tutte coteste relazioni. Il cuore del giovane Palavicino aveva trovato assai in quella dolce sua madre: il pensiero di lei poteva occupare fortemente gran parte della sua vita; ma tanto non gli bastava. A quella figura dignitosa, venerabile, cui egli doveva inchinarsi come a maggiore, desiderò venisse compagna un'altra figura affettuosa e venerabile del pari, ma più giovane, e a cui egli potesse unirsi come ad eguale. Però le virtù stesse di sua madre avendogli come data la misura per giudicare ogni cuore di fanciulla a cui per caso s'accostasse, è facile a credere come l'affetto suo avesse dovuto lasciar trascorrere gran tempo prima di posarsi in qualcheduna; d'altra parte egli sentiva anche qui il bisogno di asciugare qualche lagrima, di confortare qualche esistenza. Su tutti que' volti giovani, freschi, rosati, levigati, egli non aveva mai scorto un segno che attestasse qualche spina secreta. Non aveva trovato che giocondità ed innocenza infantile, ed egli voleva qualche cosa di più, che finalmente gli fu concesso di trovare. Venne il giorno in cui, passatagli innanzi, quasi un'apparizione repentina, una gentile e mesta creatura, provò i soprassalti improvvisi di una gioia presaga, e senz' altro attendere, l'aggruppò alla soave figura della propria madre. Ma a rendersi più accetto a quella nuova sua donna, a mostrarsele più degno, bisognava che l'esistenza sua si gettasse nella vasta faccenda della vita pubblica, si scegliesse un motivo d'azione, un assunto grande e generoso.
Le prime sue lagrime erano state versate sulla sventura di due creature giovani come lui, deboli come lui, rimasti orfani d'un padre percosso da una eccessiva giustizia.
Quei due fanciulli, in quegli anni che stette fuori, li aveva conosciuti adulti, alla Corte di Massimiliano d'Austria dove, esuli, avevano riparato; li aveva riveduti quando su quelle giovani teste pesava l'ira di un'intera nazione potente e armata a loro danno. Col più giovane dei due fratelli specialmente, essendone mediatrice l'eguaglianza dell'età e la simpatia straordinaria dell'ingegno e del cuore, aveva stretta un'amicizia calda e tenace. Allora il suo impiego, gli obblighi suoi, il suo fine come uomo che ha a vivere al cospetto d'un'intera nazione, come buon cittadino gli venne subito innanzi, e non esitò ad accettarlo, a sceglierlo anzi con un ardore potente al pari di una passione. Da quell'ora l'azione dell'intera sua esistenza fu determinata; aveva una madre da venerare, una donna d'amare, una patria, una causa, una dinastia a cui sagrificarsi. Da quel punto non fu più irresoluto, la via gli era aperta innanzi, non guardò se fosse ingombra e difficile, e i suoi passi si accelerarono.
Ora che codesto giovane fu presentato sotto il punto di vista il più favorevole, non vogliam già dire che sempre ei si rivelasse altrui da questo unico lato; vogliam dire soltanto che da questo lato mostravasi altrui il più delle volte. Del resto troppi requisiti gli mancavano ancora per ottenere un buon ingresso nel calendario de' santi, e v'eran momenti anzi ne' quali correva pericolo di non parer più riconoscibile; come avviene delle linee semplici ed eleganti d'una bella faccia che, scontorcendosi, si tramutano sotto gl'impeti dell'ira, così avveniva di lui se per avventura versasse in circostanze straordinarie, o la passione di soverchio lo agitasse. Soleva allora darsi il caso ch'ei rivelasse debolezze e difetti che uomini di gran lunga men virtuosi di lui chiamerebbero incomportabili. Però potrebbe forse avvenire che codest'uomo sfuggisse talora ad un'esatta analisi. Ma chi è vago di caratteri eternamente costanti e invariabili, rifrughi la tragedia classica, e chi si piace di profili immobili, contempli le teste effigiate sui cammei e sulle monete.
Intanto, percorrendo la via sotterranea, il duca ed il seguito ebbero attraversata tutta la città. Due uomini furono espressamente spediti innanzi ad avvisare il castellano che giungeva l'eccellentissimo duca, e quando questi arrivò al piede dell'altra scala che metteva nel castello, trovò qui gentiluomini e soldati che lo stavano aspettando. Mise il piede finalmente sul selciato del castello, e in mezzo a due stipatissime file di soldati attraversò il gran cortile e salì nelle stanze ducali.
Batteva l'ora di notte all'orologio della torretta, e in quel momento dai quattro lati del castello si udirono i suoni delle trombe che chiamavano a raccolta. E in ogni parte del castello, nel cortile, sotto gli atrii, sotto gli androni, sugli spalti che guardavano la gran fossa, alle feritoie, ai merli era un tumulto, un frastuono, un brulichio d'armati incessante, e in quell'ora quel vasto ricinto rendeva l'immagine come di un grande alveare nel quale confusamente s'agitassero ronzando migliaia e migliaia di armati. Siccome non avevasi a passare che una sola notte colà, tutti gli Svizzeri che si trovavano in Milano sotto gli ordini del Sion, tutte le labarde tedesche le quali costituivano la guardia dei duca, tutti i soldati di ventura stranieri, e quanti vestivan armi in Milano, vi stavan raccolti insieme per esser pronti alla prim'alba del prossimo dì. Nè faccia maraviglia che si potesse dar luogo a tante migliaia di soldati. Quantunque il castello a quel tempo non avesse quella gran cinta di casamenti che lo chiude in mezzo oggidì, avea le fortificazioni che si estendevano per gran tratto all'intorno, e dalla parte poi che spetta a settentrione arrivava coi vasti broli chiusi da cinte fortificate, sin dove oggi si estende il borgo vicino; però su questo gran tratto di terreno, zeppi che furono i luoghi chiusi e coperti, i soldati come meglio poterono s'acconciarono a dormirvi a ciel sereno, buttati a disagio sul nudo terreno.
Il Palavicino intanto e Francesco Sforza, dopo avere accompagnato il duca nelle sue stanze, subito erano stati licenziati.
—Giacchè ci rimane qualche tempo, disse il marchese nell'uscire collo Sforza, andrei un tratto nella camera dell'ammenda alla torre, chè vorrei vedere dappresso costoro, che senza conoscermi, si volevano la mia vita. Così interrogandoli io stesso, tenterei scovar fuori qualche cosa di più.
—Son già condannati nel capo, nè c'è altro a cavarne. Quel che han confessato è ben chiaro.
—So per altro che, tra l'altre circostanze, han deposto che il caporale che li ha pagati era una volta agli stipendi del Lautrec. Questo sarebbe un filo per conoscere se il colpo venga propriamente da costui.
—Potrebb'esserlo.
—Ben è vero che anche senza prove io credo al tutto che sia così la cosa, nè, altrimenti, saprei come acconciare i fatti tra loro.
—Il Morone è del medesimo avviso tuo. Ma lui sa quel che intravvenne tra il Lautrec e te altra volta, ond'ebbe presto il modo di portar giudizio sul fatto. Ma io non so nulla.
—Dopo l'attentato è questa la prima volta che mi trovo con te. Ma pure te ne dovrei aver parlato altra volta.
—Ciò non può essere, se nulla me n'è rimasto in memoria.
—Allora ti dirò tutto in breve. Ma rechiamoci in prima alla camera dell'ammenda.
—Non so se mi convenga venir teco, nè, a dir la verità, vorrei esser riconosciuto potendo venir loro in mente ch'io avessi il diritto di grazia.
—Ciò non avverrà; possiamo andare.
Così, passando in mezzo a cento gruppi di soldati, si recarono nel cortile, detto della Torretta. Una labarda che precedeva il duca salì a far l'imbasciata al custode. Questo tosto discese.
—Si vorrebbe entrar nella camera dell'ammenda, gli disse il duca.
—I condannati per l'attentato contro il marchese Palavicino, se son quelli che volete vedere, ci furono condotti oggi di fatto. Io sono agli ordini di V. E.
—Questo che è con me è il marchese Palavicino appunto. È lui che vuol vederli.
Il custode allora, seguito da essi, risalì la scala e corse in fretta a cingersi la spada. Li fece passare per mille andirivieni e corritoi, ne' quali la tetraggine serrava gli animi. Finalmente il custode, spalancata una grossa imposta di legno di quercia tutta rivestita di ferro:
—Eccoli, disse, sono costoro.
La scena che si offerse a' due riguardanti era truce e curiosa nel medesimo tempo. Su ciascuno dei quattro angoli d'un carcere a volta, ampio e nano, v'eran quattro letti di lucido legno inchiodati a terra. Legato a ciascun letto con una grossa catena che poteva esser lunga forse tre passi un uomo. La foggia dei vestiti, benchè diversi l'uno dall'altro, pure li dava a conoscere per soldati. Accostandosi poi a ciascuno di essi, non si durava fatica a conoscere che non appartenevan tutti ad una nazione medesima. Ed erano infatti due Piccardi, un Valacco, un Italiano. Stando a quanto s'era potuto raccogliere dalle loro deposizioni, all'Italiano, come al più esperto delle vie di Milano, era stato dato carico di far la scorta agli altri tre, i quali non avevan poi a far altro che ferire.