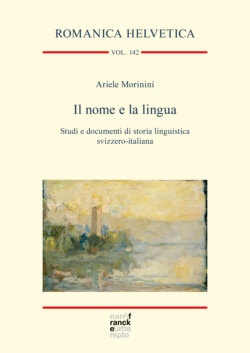Читать книгу Il nome e la lingua - Ariele Morinini - Страница 16
1.2. La collaborazione con Francesco CherubiniCherubiniFrancesco
ОглавлениеIl primo approccio di FransciniFransciniStefano alla riflessione sulla lingua, affrontata da autodidatta e mai realmente approfondita, avvenne probabilmente negli anni milanesi. Il quadriennio di frequentazione al seminario arcivescovile di Milano fu importante per la sua formazione, ma, nella nostra prospettiva, più determinante fu l’incontro e l’amicizia con il lessicografo Francesco CherubiniCherubiniFrancesco. Quest’ultimo era direttore della Scuola Elementare Normale Maggiore di Milano dal 1820, istituto dove, dallo stesso anno, FransciniFransciniStefano esercitò con l’incarico di insegnante provvisorio fino al 1824, quando lasciò la capitale lombarda per rientrare nel Ticino.1 Al tempo, CherubiniCherubiniFrancesco aveva già allestito e dato alle stampe la prima edizione in due volumi del suo Vocabolario milanese-italiano (1814) e attendeva alla seconda edizione ampliata, pubblicata sempre a Milano in quattro volumi (1839-1843), integrati da un libro di sopraggiunte edito postumo nel 1856.2 Inoltre, a lato del ricco cantiere milanese, il lessicografo raccoglieva materiali e si occupava di ricerche linguistiche di varia tipologia, che sarebbero idealmente confluite nella colossale Dialettologia italiana.3
Il primo contributo dialettologico fransciniano è da collegare proprio all’attività di CherubiniCherubiniFrancesco. Nell’anno immediatamente successivo al suo rientro a Bodio dopo l’esperienza di Milano, FransciniFransciniStefano si offrì di schedare e spedire al collega alcune voci dell’area linguistica a lui più familiare, ovvero delle varietà dell’alto Ticino, in particolare della Leventina. Lo documenta una missiva dello statista a CherubiniCherubiniFrancesco, scritta da Bodio il 17 giugno 1824:
Ove credesse, ch’io le potessi dar qualche idea o di fatto o di teorica sui nobilissimi dialetti di qui, abbia la bontà di accennarmelo, che col maggiore piacere del mondo, farò tutto quello che saprò e potrò.4
Gli archivi non serbano traccia della responsiva di CherubiniCherubiniFrancesco, ma possiamo supporre che la proposta fu accolta positivamente sulla base delle parole del ticinese scritte nella lettera successiva, del 12 luglio 1824. In quest’ultima viene infatti data prova e notizia che la collaborazione lessicografica prese avvio. Infatti, in calce alla missiva è incluso un breve elenco di vocaboli in italiano seguiti da un corrispettivo nella varietà della Leventina. Il lemmario, che include unicamente parole in ma- (con l’eccezione di cavamacchie, un composto imperativale basato sul nome macchia) è arricchito da un apparato di osservazioni sul significato, la pronuncia e ulteriori aspetti relativi alle voci censite: un’edizione integrale di questa e della lettera del 5 agosto, parzialmente trascritta sotto, è approntata nell’appendice al volume.5 FransciniFransciniStefano comunica inoltre di aver raccolto alcuni vocaboli della varietà romancia e di quella engadinese (alta e bassa), nonché di aver coinvolto nella documentazione lessicale altre persone rimaste anonime nella corrispondenza, incaricate di descrivere i dialetti della Val di Blenio, della Riviera e del locarnese e valli:
Ma n’ho dispiacere e rabbia vedendo che dopo tanto tempo scorso dalla ricevuta della sua carissima sino ad ora, non posso mandarle altro che i vocaboli di Leventina. Per que’ di Blenio e Riviera ho scritto ad un Medico amico mio, per que’ di Locarno, Verzasca e Valle Maggia ad un Avvocato; ma né l’uno né l’altro mi ha per anche ragguagliato di cosa alcuna, sebbene io sappia da buon canale che se ne occupano ambidue. Ho raccolto de’ vocaboli dell’Engaddina e della lingua romanza de’ Grigioni ma venendomi essi da persona non la più pratica di que’ dialetti, aspetto a consultar fra pochi dì un altro soggetto.6
Poco meno di un mese più tardi, con una lettera del 5 agosto 1824, FransciniFransciniStefano invia al lessicografo anche i materiali ottenuti dagli informatori anonimi, ai quali è attribuito il ritardo nella trasmissione:
Avviene talvolta che altri venga giudicato cattivo pagatore, per colpa in realtà non sua ma de’ suoi propri debitori. Appunto così io le debbo parer cattivo corrispondente. Perocché i miei corrispondenti hanno sino a questi giorni indugiato a riscontrarmi. Ma pure è meglio tardi che mai.7
Come nella precedente, anche nella missiva del 5 agosto le liste di vocaboli sono redatte in calce alla lettera, dove le voci italiane sono affiancate, pur con ingenti lacune, segnalate con i puntini o dei tratti di penna, ai corrispettivi nelle varietà di Blenio e della Leventina, nel ladino dell’Engadina alta e bassa, e in romancio. Inoltre, anche in questo documento i vocaboli censiti sono inizianti con la sequenza ma-, salvo un manipolo di voci eterogenee incluse, separatamente dalle prime, in una tabella distinta seguita da osservazioni analoghe a quelle registrate nella lemmario del 12 luglio. L’anomalo accostamento delle aree linguistiche documentate, che raggruppa e sottintende la familiarità di tre varietà del dialetto Lombardo alpino e tre varietà ladine, si spiega con la classificazione dei dialetti sulla quale si strutturava in quello stesso giro d’anni il progetto del Vocabolario italiano-dialetti di CherubiniCherubiniFrancesco. Come testimonia il Prospetto nominativo dei dialetti italiani pubblicato nel 1824 (sul quale cf. il secondo capitolo § 2.2), il lessicografo assumeva infatti che nelle valli Leventina e Blenio si parlasse il Romanzo o Retico o Rumaunsch.8 Questo equivoco ha lungo corso nelle classificazioni del milanese. Il malinteso, limitato alla Valle di Blenio, si ritrova infatti anche nell’indice più aggiornato della Dialettologia italiana.
A tale riguardo, la miopia del lessicografo ha probabilmente influenzato FransciniFransciniStefano. Ovvero, sembra aver determinato l’inclusione, nel paragrafo sul Linguaggio della Svizzera italiana, di due tabelle che propongono un’analisi contrastiva tra le varietà lombardo alpine e le lingue neolatine confinanti. Nella prima scheda, che raccoglie unicamente tre lemmi, è misurato il rapporto tra i Vocaboli ticinesi comuni col dialetto valdese, welsch o romanzo franzese; nella seconda, più ricca, sono paragonate Frasi nel dialetto Romansch e nel Ticinese della bassa Leventina, ossia nel parlare materno. E proprio in quest’ultima si palesa la scarsa sensibilità linguistica di FransciniFransciniStefano, che riceve acriticamente la geografia dialettale e i rapporti fra le varietà congetturati da CherubiniCherubiniFrancesco. Queste tabelle certificano infatti, al contrario del loro proposito, la sostanziale estraneità dei due linguaggi, che sono ravvicinabili al più sulla base di elementi comuni a buona parte della Romània alpina o prealpina. Le poche tangenze effettive si verificano limitatamente sul piano lessicale, che risulta tuttavia spesso mediato dalla lingua tedesca: lavinas/luin (per ‘lavina’), cuolm/colma (per ‘cima’); come anticipato, benché giunte nelle varietà romanze alpine dal tedesco, entrambe le parole sono di base latina (>LABINA REW 4807 e >CULMEN REW 2377).9
In ogni caso, le voci incluse in questi brevi elenchi e la cronologia delle lettere permettono di ricondurre con sicurezza questa prima indagine lessicale a un progetto al quale CherubiniCherubiniFrancesco aveva lavorato nei mesi precedenti, ovvero il Saggio di vocabolario dei Dialetti italiani, composto da ventotto carte autografe datate gennaio 1824:
Saggio di Vocabolario dei dialetti italiani compilato da Francesco CherubiniCherubiniFrancesco. Consiste nella sola combinazione alfabetica MA del Dizionario italiano coi corrispondenti vocaboli de’ singoli italiani dialetti che tengon dietro a ciascuna voce italiana cominciante per detta combinazione. Gennaio 1824.10
Come anticipato, benché le responsive siano a oggi disperse, sembra lecito ipotizzare che la proposta di FransciniFransciniStefano del 12 luglio 1824 sia stata accolta positivamente dal lessicografo. Il ticinese doveva inoltre essere a conoscenza delle linee generali del progetto sul quale CherubiniCherubiniFrancesco lavorava almeno dal 1823, quando FransciniFransciniStefano era ancora a Milano. E anzi possiamo supporre che il milanese abbia dato seguito alla collaborazione chiedendo proprio delle voci inizianti per Ma-, utili per integrare l’esperimento del vocabolario italiano-dialetti, che nel gennaio di quell’anno risultava ancora in uno stadio di elaborazione molto arretrato, specie per quanto concerne le varietà della Svizzera italiana, indicate genericamente come svizzere. A riprova di ciò, sono numerose le responsive di informatori contattati con lo stesso proposito da CherubiniCherubiniFrancesco che si conservano fra le sue carte, custodite alla Biblioteca Ambrosiana e alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.11
L’interesse di FransciniFransciniStefano per le varietà dialettali della Svizzera italiana non si esaurisce però con la spedizione dei due saggi lessicali del vernacolo materno e delle valli limitrofe. Quasi due anni dopo, in una lettera scritta a CherubiniCherubiniFrancesco da Bodio il 13 aprile 1826, lo statista risponde favorevolmente a una richiesta del lessicografo e gli comunica l’intenzione di raccogliere ulteriori materiali sui dialetti alto-ticinesi; oltre che indirettamente testimoniato nella lettera di FransciniFransciniStefano, l’invito di CherubiniCherubiniFrancesco fu esteso negli stessi giorni anche ad altri potenziali informatori ticinesi: a proposito si veda la corrispondenza con il tipografo Francesco VeladiniVeladiniFrancesco di cui si pubblica la responsiva del 12 marzo 1826 nel paragrafo § 3.2 del terzo capitolo.
Consapevole dei propri limiti nell’ambito linguistico-lessicografico, FransciniFransciniStefano chiede che gli venga consigliata la migliore via da seguire per rendere il più efficace e affidabile possibile la sua indagine:
Rispondo finalmente alla carissima sua del 15 marzo; e le dico ante omnia, che spero di poterle significare qualche cosa un po’ considerevole intorno a’ dialetti di questi paesi. Verrammi fatto di avere un’opera molto opportuna al caso suo, scritta in uno de’ dialetti romani del paese grigione. Inoltre spero di poter presto possedere una bell’opera che versa intorno a tutt’i dialetti svizzeri. In alcune mie noterelle poi troverà qualche cosa riguardo a’ parlari di Riviera, Blenio, Leventina e Valmaggia, ma particolarmente di Leventina. Ma quanto al mio lavoro debbo dirle, che siccome è fatto senza ben ponderato sistema, così corre pericolo di riuscire di poco uso. Se Ella si compiacerà di tracciarmi un piano, mi farà cosa gratissima, ed io non mancherò di fare il meglio che saprò e che potrò.12
La ricerca di FransciniFransciniStefano sembra prendere forma ai primi d’autunno dello stesso anno, quando in una lettera del 29 settembre comunica a CherubiniCherubiniFrancesco l’imminente invio di un saggio di voci dialettali delle Tre Valli (Blenio, Leventina e Riviera) e di altri materiali utili per la compilazione del Vocabolario italiano-dialetti al quale attendeva l’amico lessicografo:
Non vorrei che la mi credesse atto solo a domandare. Anch’io ho preparato per Lei un saggio di voci delle Tre Valli.
Ella lo avrà prima di San Carlo prossimo venturo. E se le piacerà, verrà da me fatto seguitare da altri più copiosi. Insieme con questo riceverà un’opera tedesca sui dialetti svizzero-tedeschi, che nella Svizzera si vede molto rinomata, e che dovrebbe in qualche modo giovare a Lei nella compilazione del suo gran Vocabolario. Forse forse le arriverà pure la Grammatica retica.13
Il 20 del mese successivo è infatti spedita a CherubiniCherubiniFrancesco una lettera con acclusa «1.° l’opera sui dialetti svizzeri ancora slegata quale me l’hanno mandata d’oltramonte; 2.° tre fascicoletti sui dialetti di queste valli che sono le estreme d’Italia; 3.° la prefazione ch’io intendo dare alla mia Grammatica».14 Nella missiva, inoltre, FransciniFransciniStefano avverte il destinatario sulla qualità non ottima dei tre fascicoletti di voci dialettali, non esaustivi e allestiti corrivamente:
I fascicoletti sono stati qui attorno per la casa. Io credevo di poterli ricopiare e migliorare quanto all’esterno e quanto all’interno; ma lavori straordinari avuti in questi mesi non mi lasciarono effettuare quel che bramavo. Dunque glieli spedisco rozzi come si sono. Troverà definizioni né complete né accurate; ma io parlo a chi parlo, non mica al pubblico, e perciò profitto del proverbio che dice A buon intenditor mezza parola. Le torno a dire ch’io sono a’ cenni suoi: mi comandi, ed io ben volentieri farò alla meglio che saprò.15
L’invio di questi materiali tuttavia non riuscì e, tolto il libro dello StalderStalderFranz Joseph, già in possesso del lessicografo, gli stessi furono rispediti due mesi dopo, il 22 dicembre.16
Nei codici compositi e disordinati di CherubiniCherubiniFrancesco, conservati presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, si conserva tuttavia un solo fascicolo della tripletta, ovvero le ventiquattro carte che documentano le voci della Leventina. Il manoscritto, redatto in due colonne su fogli formato protocollo, è rilegato nel codice miscellaneo M 67 suss. con un’intestazione seriore vergata da CherubiniCherubiniFrancesco:
Valligiano svizzero
Vocaboli di Leventina
Datimi e scritti di suo pugno
dal
Ch. Cons.e Stefano Franscini FransciniStefano
Ex libris Francisci CherubiniCherubiniFrancesco Mediolanenses.17
Il documento, di pugno di FransciniFransciniStefano, non è in realtà particolarmente rozzo o mal presentato. Sulla scorta di quanto scritto nella lettera del 20 ottobre 1826, sembra non avventato ipotizzare che le liste di voci di qualità redazionale e contenutistica peggiore fossero quelle allestite dagli informatori anonimi ai quali si rivolse il ticinese, di cui si è detto sopra. Tra le carte di CherubiniCherubiniFrancesco custodite in Ambrosiana non si conserva infatti traccia dei fascicoli dedicati alla Valle di Blenio e alla Riviera, né emergono testimonianze indirette del loro impiego nel cantiere della Dialettologia italiana. A questo proposito sembra condivisibile l’ipotesi avanzata da FarèFarèPaolo A., secondo il quale questi materiali dovevano essere esigui e di scarso interesse, perciò sono stati persi o distrutti dal lessicografo.18 Tale congettura sembra confermata dal mancato riferimento ai due manoscritti nella meticolosa Bibliografia dialettale redatta dallo stesso CherubiniCherubiniFrancesco.19 A questo proposito, nel 1846, recensendo il Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como di Pietro MontiMontiPietro, CherubiniCherubiniFrancesco ricorda, riconoscendo dignità e merito all’indagine, il saggio sul dialetto leventinese ricevuto da FransciniFransciniStefano tra la fine del 1826 e l’inizio del 1827, ma trascura i fascicoli che teoricamente lo accompagnavano:
Nella mia raccolta di stampe e manoscritti vernacoli de’ varii paesi d’Italia posseggo anch’io un Saggio di Dialetto Leventino compilato e donatomi dal ch. scrittore della Statistica della Svizzera, l’egregio FransciniFransciniStefano. In quel Saggio (che novera 23 carte) esistono parecchie voci che potranno arricchire una seconda edizione del presente Vocabolario del MontiMontiPietro; a cagion d’esempio Antru (rampollo), Bascioeù (porco), Bascióra (scrofa), Cusgnà (bussare), e più altre.20
MontiMontiPietro si servì infatti solo di una parte dei Vocaboli di Leventina per il suo Vocabolario, quella raccolta nella opus magnum dello statista, indicata tra le fonti della sua opera: «Stefano FransciniFransciniStefano, nella Svizzera italiana, ci diede alcune voci del Cantone Ticino».21 Benché l’esperimento lessicografico del ticinese non ambisse alla diffusione editoriale o all’esaustività della ricerca, il materiale procurato da FransciniFransciniStefano fu una risorsa di interesse per i lessicografi lombardi. Ma la fortuna di questa snella documentazione fu anche più ampia, lo dimostra il paragrafo Valle Leventina dei Saggi ladini, elaborato da Graziadio Isaia AscoliAscoliGraziadio Isaia sul prezioso mannello di voci allestito da FransciniFransciniStefano:
Qui si schiude alla nostra indagine una fonte abbastanza copiosa. È un vocabolario autografo di Stefano FransciniFransciniStefano, inserito in CH. E.S. III, 24, p. 9 segg. [ora: M 67 suss., cc. 9-32], del quale noi attingeremo a larga mano, ordinando e commentando il nostro spoglio secondo il tipo da noi adottato.22
A quanto risulta, tolte le pagine della Svizzera italiana dedicate al Linguaggio, che si ricollegano più o meno direttamente a questa esperienza, le richieste di CherubiniCherubiniFrancesco hanno costituito le uniche occasioni di studio e riflessione sui dialetti regionali per lo statista. Pur da una diversa angolatura, fa eccezione la traduzione del breve dialogo tra un padrone e il suo servitore voltata da FransciniFransciniStefano in due varietà della regione per il capitolo dedicato alla Svizzera italiana incluso nel supplemento al settimo volume della Corografia dell’Italia di Attilio Zuccagni-OrlandiniZuccagni-OrlandiniAttilio.23