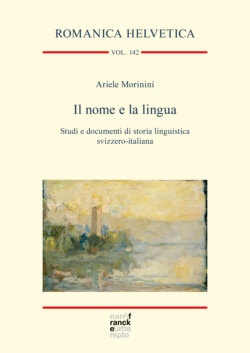Читать книгу Il nome e la lingua - Ariele Morinini - Страница 19
1.5. La lingua di FransciniFransciniStefano
ОглавлениеIl capitolo sulla lingua proposto nella Svizzera italiana, coerente con analoghi approfondimenti nelle opere statistiche che fungono da modello, mette a sistema nella descrizione storico-statistica, in funzione della propria tesi, il materiale ricavato dagli studi linguistici prodotto sostanzialmente negli anni ’20 e fino a quel momento al servizio esclusivo di altri. In questo giro di anni le energie e gli interessi di FransciniFransciniStefano furono mediati o filtrati dall’impegno politico; questo anche per quanto concerne l’educazione, per la quale si impegnò in ambito sociale promuovendo importanti iniziative, a scapito della diretta produzione di sussidi didattici. Lo testimonia FransciniFransciniStefano stesso in una lettera scritta a CherubiniCherubiniFrancesco il 27 settembre del 1836 da Bellinzona, nella quale riconosce che «Ormai gli studi sono poca cosa e [quella] poca ha sempre o consanguineità o ‹ill.› con la politica».1 La sua carriera è ormai saldamente orientata verso quest’ultima, mentre l’interesse linguistico, da sempre marginale, viene meno: valga come esempio il fatto che FransciniFransciniStefano non nutriva alcuna preoccupazione per lo stato attuale della lingua e non partecipò al dibattito sulla questione linguistica che coinvolse gli intellettuali e i letterati contemporanei, tra i quali va ricordato perlomeno Carlo CattaneoCattaneoCarlo, amico dello statista dal periodo milanese e residente per molti anni a Lugano.2
Oltre ad aver riorientato il suo interesse attivo e aver indirizzato i suoi studi verso la storia e l’economia, è ipotizzabile che FransciniFransciniStefano ignorò il dibattito sulla lingua anche perché era in difetto di sicurezza e forse privo dei mezzi necessari per contribuire produttivamente alla querelle.3 Determinanti, a tale proposito, furono la formazione da autodidatta basata sulla modesta istruzione offerta dal seminario di Pollegio e l’isolamento culturale vissuto negli anni leventinesi successivi al periodo di Milano. Le lettere che lo statista indirizza a CherubiniCherubiniFrancesco, punto di riferimento per quanto concerne lo studio della lingua e dell’espressione scritta, documentano questa insicurezza. FransciniFransciniStefano si rivolge al lessicografo per ottenere alcuni testi che l’isolamento ticinese rendeva difficili da reperire attraverso vie ordinarie. Intenzionato a rimediare a questa condizione, nella lettera del 26 aprile 1826 prega CherubiniCherubiniFrancesco di mediare, in occasione di una trasferta della moglie a Milano, l’acquisto di alcuni volumi:
Vorrei si desse la pena di dare in nota a mia moglie qualche opera del Giordani e del P. Cesari, de’ quali non ho nulla e vorrei avere qualche cosa, non però volumi troppo costosi.
Ho pochissime prose antiche, anzi per ispiegarmi meglio, ho solo quelle del BoccaccioBoccaccioGiovanni e del MachiavelliMachiavelliNiccolò e qualche lettera di autori antichi. Di grazia si compiaccia me donner des renseignemens. S’Ella potesse privarsi di quegli opuscoletti del GherardiniGherardiniGiovanni su alcune voci e frasi riputate barbare! Non ne starebbe senza per qualche semestre?4
Oltre a un aiuto per colmare le proprie le lacune linguistico-letterarie, FransciniFransciniStefano chiede in prestito al lessicografo alcuni opuscoletti allestiti da Giovanni GherardiniGherardiniGiovanni. Questi fascicoli, poi confluiti nelle Voci e maniere di dire italiane additate a’ futuri vocabolaristi (1838-40), sono uno strumento utile per il ticinese al fine di verificare ed emendare l’uso di regionalismi o di espressioni improprie nella lingua scritta. Per quanto concerne l’insicurezza ma anche la cura e l’attenzione rivolta da FransciniFransciniStefano agli aspetti linguistici, nella già menzionata lettera del 5 agosto del 1824 lo statista consulta CherubiniCherubiniFrancesco, ritenuto un valido interlocutore. Nella missiva sono sottoposti al giudizio del lessicografo alcuni articoli statistici pubblicati nei mesi precedenti sulla stampa ticinese, che valsero a FransciniFransciniStefano delle critiche in merito alle scelte lessicali e stilistiche impiegate:
Per l’organo del S.r VeladiniVeladiniFrancesco mi sono pervenute alcune critiche ai miei articoli statistici, la sostanza delle quali consiste in ciò che segue: 1° il Clero principalmente prese in sinistra parte la mia espressione educazione del bestiame; 2° lo stile non par troppo coinciso; 3° apparisce poco buon gusto nel mio scrivere […] pure avrei molto caro che Ella si compiacesse di esaminar un po’ que’ miei scritti e darmene suo libero giudizio. In verità spero che da Lei non verrò tacciato di cattivo gusto ché troppo io procuro di correr la via battuta da’ buoni scrittori, schivando a tutta forza di gambe quella degli ampollosi, degli affettati e degli oscuri e confusi dicitori.5
Sono sufficienti questi pochi passi per documentare la scarsa fiducia del ticinese nel proprio mezzo espressivo.6 Una condizione, questa, che lo portava a disporre di una lingua di base arcaica e ancorata ai modelli della tradizione letteraria italiana.7 Tuttavia, questo limite non gli impedì di adeguare la sua scrittura tendenzialmente conservatrice all’ambizione e agli obiettivi della sua opera maggiore. Nella Svizzera italiana FransciniFransciniStefano si serve di un lessico più ampio per esprimere concetti e referenti settoriali, e di conseguenza descrivere in maniera efficace la realtà etnografica, antropologica e culturale della Svizzera italiana – fino all’uso, consapevole e rilevato graficamente, della terminologia dialettale.8 La lingua della Svizzera italiana è in sostanza disponibile a ricevere regionalismi o dialettalismi italianizzati ed è permeabile all’influenza delle lingue confederate, secondo una dinamica coerente con l’ideologia che motiva l’opera stessa. In linea con le sue esigenze in quest’àmbito, per concludere il breve excursus, FransciniFransciniStefano fu uno scrittore chiaro ed elegante nell’esposizione dei contenuti, come testimoniano ad esempio i testi raccolti nella recente edizione degli Scritti giornalistici (1824-1855), che documentano la sua attività di articolista.9