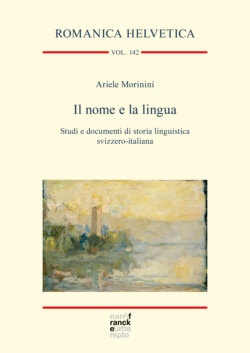Читать книгу Il nome e la lingua - Ariele Morinini - Страница 22
2. 1. Le prime classificazioni: da DanteAlighieriDante a FernowFernowCarl Ludwig
ОглавлениеNel primo libro del De vulgari eloquentia, DanteAlighieriDante divide i volgari italiani in due principali raggruppamenti, separati dalla barriera geologica del crinale appenninico. Nella descrizione dantesca, riferita a una carta geografica nella quale la penisola era orientata all’inverso della consuetudine moderna, il versante «di destra» corrisponde alla dorsale tirrenica mentre quello «di sinistra» indica il fianco adriatico:
Diciamo dunque per prima cosa che l’Italia è divisa in due parti, una di destra e una di sinistra. E se qualcuno chiede qual è la linea divisoria, rispondiamo brevemente che è la giogaia dell’Appennino; la quale, a seconda che il colmo della vena acquifera faccia sgrondare le acque o di qua o di là in rivoli divergenti, così le fa colare, per lunghi canali, ora nell’uno ora nell’altro litorale, come descrive Lucano nel secondo libro: e la parte destra ha come sgrondatoio il Mar Tirreno, la sinistra defluisce nell’Adriatico.1
All’interno di questi due raggruppamenti DanteAlighieriDante individua, determinandole su base prevalentemente geografico-politica e non sull’osservazione ravvicinata dei tratti linguistici, quattordici principali aree dialettali. Ad ovest: una parte dell’Apulia, Roma, il Ducato di Spoleto, la Toscana, la Marca Genovese, la Sicilia e la Sardegna; ad est: la restante Apulia, la Marca Anconetana, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trevigiana con Venezia, il Friuli e l’Istria. Queste, a loro volta, si differenziano internamente in varietà regionali, municipali e rionali:
Dunque la sola Italia si presenta differenziata in almeno quattordici volgari. E tutti questi volgari si differenziano ancora al proprio interno, come ad esempio in Toscana i senesi e gli aretini, in Lombardia i ferraresi e i piacentini; e persino entro la stessa città si coglie una certa variazione, come abbiamo detto più sopra nel capitolo precedente. Pertanto, a voler contare le variazioni primarie e secondarie e subsecondarie del volgare d’Italia, anche solo in questo minimo angolo di mondo si arriverebbe alla millesima diversificazione della lingua, anzi si arriverebbe anche molto più in là.2
La mappatura geografica dei dialetti italiani proposta da DanteAlighieriDante, ignorata o negletta per secoli, fu solo occasionalmente ripresa tra il Trecento e il Novecento. Le osservazioni dantesche sono impiegate, ad esempio, nella La clef de langues del piemontese Carlo DeninaDeninaCarlo (1731-1812), redatta in francese e dedicata a NapoleoneBonaparteNapoleone nel 1804.3 Quella di DeninaDeninaCarlo è una ricerca sulla comune origine delle principali lingue europee, che precorre il metodo comparativo in senso stretto. Al paragrafo intitolato Observations sur les Dialectes, l’autore recupera acriticamente la schematizzazione proposta nel De vulgari eloquentia, sulla base della quale elabora una semplificazione ulteriore:
En Italie, dans le quinzième siécle, on en comptoit quatorze [dialectes] qui auroient encore pu se subdiviser en quarante ou cinquante et beaucoup plus encore, lorsque dans la Romagne, dans la Toscane, et en Lombardie on pouvoit compter plusieurs républiques ou principautés indépendantes. Nous pouvons à présent en distinguer cinq ou six principaux, qui sont le Napolitain, le Romain, le Toscan, le Vénitien, le Bas- et le Haut- Lombard; comprenant sous le nome de Bas-Lombard celui que l’on parle depuis Bologne et Ferrare jusqu’à Milan, et sous le nom de Haut-Lombard le Piémontois.4
Anche lo storico dell’arte pomerano Karl Ludwig FernowFernowCarl Ludwig (1763-1808), nell’opera intitolata Römische Studien, edita l’anno della sua morte, espone una classificazione dei dialetti italiani fondata sul divisorio appenninico, ricollegandosi di fatto alla tradizione dantesca. Tuttavia, FernowFernowCarl Ludwig rinnova la trafila degli studi precedenti proponendo un primo approfondimento sulle singole aree dialettali d’Italia, distinte fra loro mediante l’individuazione di tratti linguistici caratterizzanti, documentati con alcuni saggi di scrittura o con un campionario lessicale e fraseologico a seguito di ogni descrizione. Nel paragrafo relativo alla varietà milanese (Die Mailandische Mundart), incluso nel capitolo sui dialetti italiani (Über die Mundarten der Italienischen Sprache), si legge inoltre la prima, benché sommaria, classificazione delle varietà dialettali parlate nella Svizzera italiana.5 FernowFernowCarl Ludwig sostiene infatti che nelle aree lacustri del Cantone Ticino, nei dintorni del Lago Ceresio e del Maggiore, si parli una varietà alpina del dialetto milanese, contaminata dalla prossimità e dagli scambi cospicui con la Svizzera di lingua tedesca. Le sue osservazioni, fino a questo punto sostanzialmente corrette, assumono in seguito toni eccessivamente assertivi, che deformano il quadro della situazione linguistica reale. L’autore afferma infatti che a causa dell’influsso transalpino le varietà locali risultano difficilmente comprensibili dai parlanti altri dialetti italiani:
Sie hat [il milanese], wie mehrere Mundarten Italiens, einen dialetto urbano und einen dialetto rustico. Jenen spricht das Volk in Mailand; diesen sprechen die Landleute der umliegenden Gegend. Eine Unterabteilung des leztern ist auch die Mundart, welche von den Umwohnern des Luganer- uns Comer-Sees gesprochen wird, deren vielen des leztern nach Deutschland auswandern und Handel treiben. Diese leztere ist sehr unverständlich, und selbst Italiener aus andern Gegenden verstehen sie nur mit Mühe. Die Mundart der Umwohner des lago Maggiore gehört gleichfals hieher; aber an den westlichen Ufern desselben geht sie schon in die piemontesische über.6
Nei primi decenni dell’Ottocento, in anni coevi o immediatamente successivi alle descrizioni scorse nelle pagine precedenti, si assiste nella Lombardia, con centro a Milano, a un rinnovo dell’interesse e a una sensibilizzazione nei riguardi del dialetto.7 In questo clima culturale sono poste le basi di importanti opere dialettologiche, tra cui gli Studii linguistici di Bernardino BiondelliBiondelliBernardino, che sull’impronta della distribuzione geografica delle antiche popolazioni italiche opera una suddivisione dialettale in sei famiglie (gallo-italica, ligure, tosco-latina, veneta, carnica e sannitico-iapigia);8 le importanti raccolte e compilazioni lessicologiche di MontiMontiPietro; e infine, i vocabolari e l’ambizioso progetto della Dialettologia italiana di CherubiniCherubiniFrancesco, teso a procurare una descrizione complessiva delle varietà dialettali italiane, assecondando un proposito già settecentesco, di De Brosses ad esempio, condiviso poi da Muratori e successivamente anche da CesarottiCesarottiMelchiorre, che a proposito scrisse:
È d’uopo far uno studio di tutti i dialetti nazionali, e tesserne dei particolari vocabolari, studio raccomandato a ragione dallo stesso de Brosses e dal sensato Muratori, studio curioso insieme e necessario per posseder pienamente la lingua italiana, per conoscer le vicende e trasformazioni dello stesso vocabolo, e sopra tutto per paragonar tra loro i diversi termini della stessa idea e le varie locuzioni analoghe; valutarne le differenze, rilevar i diversi modi di percepire e sentire dei vari popoli, indi trarre opportunamente partito da queste osservazioni, e supplir talora con un dialetto alle mancanze d’un altro.9