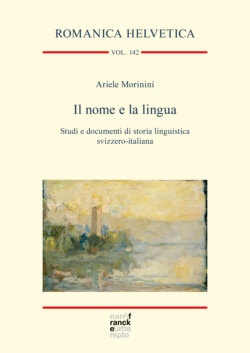Читать книгу Il nome e la lingua - Ariele Morinini - Страница 18
1.4. Il Grigioni e il topos del “cattivo italiano”
ОглавлениеIl mosaico linguistico risulta ancora più complesso se si includono nel quadro complessivo le tre regioni del Grigioni italiano, non contemplate nella riflessione presentata da FransciniFransciniStefano nel capitolo sul Linguaggio. Questa negligenza mostra le difficoltà e i limiti intrinseci al progetto della Svizzera italiana, percepibili nell’organizzazione stessa dell’opera. Infatti, un’ampia trattazione è riservata al Cantone Ticino mentre le considerazioni sul Grigioni italiano sono relegate in una breve appendice in calce al secondo volume.1 In questo complemento, gli abitanti italofoni del Grigioni sono definiti di cultura ancipite: ossia, sono descritti come individui di origine italiana contaminati dalla cultura tedesca. Un’analoga considerazione è avanzata per i valtellinesi da Pietro Angelo LavizariLavizariPietro Angelo nell’opera Memorie storiche della Valtellina, stampata a Coira nel 1716 per i tipi di Andrea Pfeffer: «Il linguaggio è italiano, come anche universalmente i costumi: temperati però dalla candidezza ed ingenuità tedesca»; con due aggettivi, peraltro, insoliti per qualificare il tipo tedesco.2 Il dato linguistico e l’orientamento confessionale risultano fondamentali nella distinzione tra grigioni e ticinesi; questi ultimi costituirebbero la sola comunità «veramente italiana» secondo FransciniFransciniStefano. Infatti, se il popolo ticinese era legato alle diocesi comasca e ambrosiana e sapeva esprimersi nel «bel linguaggio del sì», la situazione differisce notevolmente nelle valli italiane del Grigioni:
La Bregaglia è abitata da una razza che ha dell’italico e del tedesco. La fisonomia, il linguaggio e la vivacità costituiscono un popolo italiano; ma il culto protestante e molte abitudini della vita additano il carattere retico-svizzero. Quanto è al linguaggio, esso consiste in un dialetto che sarebbe ben malagevole a intendersi da’ gentili abitatori dell’Arno.3
Non diverge sostanzialmente la descrizione proposta per gli abitanti della Val Mesolcina e della Calanca, anch’essi, infatti, «per linguaggio, fisionomia e abitudini sono italiani; ma a parecchi tratti si rende manifesta una certa affinità cogli oltramontani tedesco-reti».4 Quello del cattivo italiano, o dell’italiano corrotto, è un motivo che non emerge isolatamente nella trattazione di FransciniFransciniStefano. Ad esempio, nel sedicesimo volume della Nuova Geografia, il poligrafo tedesco Anton-Friedrich Büsching annota che «Nelle Valli Pregalia, e Misacina si parla un cattivo italiano».5 Non diversamente, Giovanni Francesco PivatiPivatiGiovanni Francesco nel Dizionario Scientifico e Curioso Sacro-Profano, pubblicato a Venezia nel 1750, sotto la voce lega, dedica un breve paragrafo alle lingue in uso nel territorio della Lega Grigia:
Gli abitanti della Lega Grigia hanno tre sorte di lingue, parlando alcuni Tedesco, altri Italiano, e il rimanente servendosi di un certo gergo, che appellano Romano, meschiato d’Italiano, o di Latino e della lingua degli antichi Leponzj. Presso le sorgenti del Reno superiore, e nella valle di Domglesch si parla tedesco; nella valle di Sciams, che giace fra le due, adoprasi il linguaggio accennato; nella valle di Masox [valle di Mesocco: la Mesolcina] si parla un cattivo Italiano, e nel Rheinsvald, come pure nelle Giurisdizioni di Tavetsch, d’Oberfax, di Stuffau, di Tenna, di Vals, e di Cepina si parla Grigione.6
Anche CherubiniCherubiniFrancesco negli appunti preparatori della Dialettologia italiana, al secondo titolo, quello relativo al Dialetto valligiano italo svizzero, avanza considerazioni analoghe sulla lingua parlata nelle vallate italofone del Grigioni. Al capitolo ottavo del manoscritto, relativo al Suddialetto mesolcino e calanchetto, il lessicografo annota che gli abitanti di questi territori parlano un vernacolo «consistente in un italiano corrottissimo misto in parte di romanzo dato loro dai passati rapporti politici e dalla tuttora continuante soggezione ecclesiastica al Vescovo di Coira».7 Nella breve postilla per il Suddialetto Poschiavino, CherubiniCherubiniFrancesco appunta inoltre che «il vernacolo è italiano di fondo affine al Valtellinese della prossima Tirano, ma stranamente alterato con il romanzo-ladino proprio dell’Alta Engadina e col Lombardo».8 Infine, anche per quanto concerne il Suddialetto bregaglino il lessicografo rileva l’impiego di «un italiano corrottissimo che sente di Valtellino e di Romanzo».9 Le stesse considerazioni sono schematizzate in un appunto autografo conservato in un codice miscellaneo contenente i materiali relativi al progetto della Dialettologia italiana. Nel breve indice manoscritto, che classifica le varietà del Valligiano-svizzero-italiano (antichi Baliaggi italiani), si legge una sintetica annotazione sulle Valli Mesolcina, Calanca, Bregaglia e Poschiavo (indicate erroneamente come soggette al potere dei Grigioni), che qualifica la loro lingua come un «italiano corrottissimo»; mentre le varietà di Lugano e Mendrisio sono considerate «lombardo milanese corrotto».10
Il topos del cattivo italiano non si limita alle vallate grigioni di lingua italiana ma riguarda allo stesso modo la Lombardia svizzera e in anni più recenti il Cantone Ticino; in opposizione o rovesciando il topos del buon italiano osservato sopra. Lo stesso Busching, ad esempio, nel diciannovesimo volume della Nuova Geografia allarga la portata della sua osservazione alla geografia ticinese, al chiavennasco e alla Valtellina:
Si parla Italiano più, o meno guasto nella valle Misolcina, nella parte Superiore della Lega Grigia, e nelle Giudicature della Valle Livina, o sia Lepontina, di Bollenza, Riviera, Bellenza, Lugano, Locarno, Mendrisio, Maggia, come pure nella Valtellina, nella Chiavenna, e nella provincia di Bormio.11
Non diversamente, l’erudito e parroco zurighese Johann Conrad FäsiFäsiJohann Conrad, nella sua descrizione geografico-istituzionale della Confederazione svizzera intitolata Genaue und vollständige Staats- und Erd-Beschreibung der ganzen Helvetischen Eidgenossschaft, derselben gemeinen Herrschaften und zugewandten Orten (1765-68), nel paragrafo dedicato alla Valle di Blenio, registra un’impressione analoga, poi estesa anche agli altri baliaggi cisalpini: «la lingua locale di questo e degli altri baliaggi è un cattivo italiano», probabilmente riferendosi alla parlata dialettale, aspra e palatalizzata (ad esempio, la semipalatalizzazione delle consonanti occlusive velari /kj/ e /gj/), del lombardo rustico.12 Anche SchinzSchinzHans Rudolf, parallelamente al passo citato sopra, nei Beyträge si esprimeva in termini analoghi sull’italiano diffuso in alcuni baliaggi cisalpini. Per quanto concerne il popolo della Leventina, lo zurighese dichiara che «la loro lingua è un pessimo italiano corrotto, misto di diverse parole tedesche storpiate».13 Ricollegandosi a questa considerazione, SchinzSchinzHans Rudolf indica inoltre che la lingua parlata nel distretto della Riviera «è un italiano corrotto e incomprensibile».14 Come testimoniano parte degli esempi citati, questa caratteristica è rilevata con particolare frequenza nell’alto Ticino, dove le varietà vernacolari si distanziano più nettamente sul piano fonetico dall’italiano standard, prestandosi a equivoci e miopie critiche di vario genere. A questo proposito, nella cronaca del suo viaggio nella Lombardia svizzera del 1776, l’ispettore Jean-Roland Marie de la PlatièrePlatièreJean-Roland Marie de la scrive che da Airolo «si comincia a farfugliar l’italiano» e definisce la lingua parlata dal Gottardo fino a Bellinzona un «Lombardo-tedesco»; una considerazione, questa, dovuta a un fattore impressionistico e non a una reale consapevolezza dell’influsso del tedesco sui dialetti lombardo-alpini.15 A riprova dei frequenti malintesi, il pastore anglicano William CoxeCoxeWilliam nel suo Travels in Switzerland, che raccoglie le cronache redatte durante i viaggi compiuti attraverso la Svizzera sulla rotta del Grand tour, pubblica una lunga lettera Sui baliaggi italiani ricevuta da David PennantPennantDavid, nella quale si trova un’ulteriore testimonianza dell’equivoco linguistico. Nella missiva il vernacolo impiegato nella Lombardia svizzera è addirittura confuso con il tedesco: «La maggior parte degli abitanti capisce l’italiano; la loro lingua, però, è un tedesco corrotto».16
D’altronde anche la varietà più prestigiosa del gruppo lombardo occidentale, il volgare milanese, è tradizionalmente percepita in modo negativo, come una parlata rozza. Lo documenta, ad esempio, il testo IX compreso nella Prima parte delle Novelle di Matteo BandelloBandelloMatteo, nel quale l’autore sostiene che alle giovani donne milanesi, generalmente piacenti e gentili, non manchi nulla se non una lingua all’altezza delle loro qualità:
In queste adunque delicatezze, in queste pompe e in tanti piaceri e domestichezze essendo le donne di Milano avvezze, sono ordinariamente domestiche, umane, piacevoli e naturalmente inclinate ad amare e ad essere amate e star di continovo su l’amorosa vita. E a me, per dirne ciò ch’io ne sento, pare che niente manchi loro a farle del tutto compite, se non che la natura le ha negato uno idioma conveniente a la beltà, ai costumi e a le gentilezze loro. Ché in effetto il parlar milanese ha una certa pronunzia che mirabilmente gli orecchi degli stranieri offende. Tuttavia elle non mancano con l’industria al natural difetto supplire, perciò che poche ce ne sono che non si sforzino con la lezione dei buon libri volgari e con il praticare con buoni parlatori farsi dotte, e limando la lingua apparare uno accomodato e piacevole linguaggio, il che molto più amabili le rende a chi pratica con loro.17
Nella novella XXXI della Seconda parte, composta tra il 1522 e il 1525, la varietà cittadina è ritenuta inferiore anche alle parlate più decentrate, genericamente lombarde, e perfino del bergamasco, tipicamente sfruttato nella Commedia dell’arte come blasone o macchietta vernacolare per la sua peculiare asprezza, qui usato come paragone “forte”, senza reali intenzioni di giudizio linguistico:
E se io domando loro per qual cagione non vogliono che io dica bene de la patria mia, altro insomma non mi sanno che rispondere, se non che il parlar milanese è troppo più goffo che parlar che s’usi in Lombardia, e quasi che non si vergognano a chiamarlo più brutto che il bergamasco.18