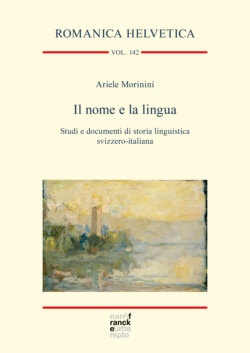Читать книгу Il nome e la lingua - Ariele Morinini - Страница 6
Introduzione
ОглавлениеContinuo a pensare che la lingua costituisca il più articolato complesso di indizi sulle situazioni socio-culturali del passato.
C. SegreSegreCesare, Lingua, stile e società, 1974.
Nel secolo VII, in piena fase di delatinizzazione, l’arcivescovo Isidoro di SivigliaIsidoro di Siviglia nelle sue Etymologiae sosteneva che «sono le lingue che fanno i popoli, non i popoli che fanno le lingue».1 Accogliendo una visione per certi versi affine, nei primi decenni del Novecento, in risposta all’affermarsi dei nazionalismi, Fernando PessoaPessoaFernando nel Livro do Desassossego scriveva: «La mia patria è la lingua portoghese».2 La frase, pronunciata per bocca del suo pseudo-eteronimo Bernardo Soares, afferma un sentimento implicitamente condiviso, ovvero che l’identità è un fatto sostanzialmente linguistico. In relazione all’idea sulla quale si fondano queste affermazioni, la configurazione della Svizzera, uno dei pochi stati nell’Europa ottocentesca a conformarsi come Willensnation, senza incardinare il processo di costruzione nazionale sul concetto romantico di corrispondenza tra lingua e patria, presenta alcuni aspetti singolari. Questa atipicità favorisce l’attenzione per le dinamiche identitarie e linguistiche, suscitando un interesse marcato sul rapporto tra lingua, cultura e territorio in tutte le regioni della Confederazione e a maggior ragione nell’area italofona, di estensione limitata e in condizione di netta minoranza demografica nel contesto socio-politico elvetico.
La ricerca muove da una domanda essenziale a tale proposito, relativa agli etnici e ai glottonomi impiegati prima dell’epoca moderna, ovvero: come si chiamavano e venivano chiamati, nel corso della storia, gli abitanti e le terre dell’attuale Svizzera italiana?3 Le denominazioni Svizzera italiana e svizzeri italiani, che oggi designano la parte della Confederazione elvetica in cui la lingua maggioritaria è l’italiano e i cittadini svizzeri di lingua italiana, corrispondono a espressioni analoghe presenti nelle altre lingue federali e nei rispettivi dialetti locali, e si accostano a un cospicuo numero di locuzioni equivalenti o semanticamente connesse. Questi lessemi sono di norma percepiti come univoci e non connotati, ossia non marcati semanticamente. Tale assetto si è tuttavia determinato in un’epoca piuttosto recente ed è stato preceduto da una lunga fase di costruzione, negoziazione e riconoscimento dell’identità culturale e linguistica delle aree interessate, ovvero dell’attuale Canton Ticino e del Grigioni italiano. Uno sviluppo, questo, reso più complesso dalla peculiare conformazione geo-culturale del territorio, chiuso al nord dalla frontiera geologica della dorsale alpina, che separa la regione italofona dalla sua patria politica, e limitato al sud dal confine nazionale, che interrompe la naturale continuità geografica, linguistica e culturale della Svizzera italiana con la Lombardia e il Piemonte.
Il processo storico di formazione e consolidamento dell’identità locale ha determinato nei secoli una sensibile variazione delle denominazioni. Ripercorrendo l’evoluzione semantica dei geonimi e degli etnici che hanno designato, nel suo complesso e nelle singole parti, quella che oggi chiamiamo Svizzera italiana, è dunque possibile rilevare almeno tendenzialmente i processi di trasformazione della percezione identitaria degli abitanti, dal Medioevo all’istituzione della moderna Confederazione. Lo sviluppo semantico delle denominazioni non si è tuttavia concluso con il superamento dell’ancien régime. Infatti, se da una parte in epoca moderna la locuzione “Svizzera italiana” si è diffusa, dall’altra ha acquisito sfumature di significato diverse a seconda degli usi e dei contesti, che si è tentato di riassumere in una tavola sinottica consultabile in appendice.
Il proposito iniziale di scrivere una storia linguistica della locuzione “Svizzera italiana” è stato arricchito in itinere. Alla ricognizione attorno alla denominazione si è affiancato un percorso più ampio, che segue da un’angolatura linguistica e letteraria il progressivo formarsi e il consolidarsi dell’identità regionale. L’indagine si è così sviluppata seguendo ramificazioni da principio impensate e impreviste, che hanno tuttavia assunto un rilievo nella lettura d’insieme, anche in relazione ai presupposti originali. Gli approfondimenti presentati nei singoli capitoli allargano così l’orizzonte più stretto della riflessione sul rapporto tra lingua e identità. Nel suo complesso, la ricerca si concentra sugli snodi, sugli argomenti di pertinenza linguistica individuati nei periodi di massima tensione identitaria: essa trova il proprio baricentro nell’Ottocento e nel primo cinquantennio del Novecento. Ovvero, quando i nazionalismi condizionarono diffusamente il modo di pensare e di guardare alla lingua di un paese.
In epoca romantica, l’affermazione del concetto di nazione, con la conseguente definizione delle individualità nazionali e la costruzione della storia patriottica e dei miti, promosse con forme e tempi diversi la necessità di legittimare la propria singolarità sulla base di criteri sociali e culturali: il fattore linguistico fu il più solido e riconoscibile elemento di identificazione, che rese (e di fatto rende) difficile la definizione identitaria della Svizzera. Dall’istituzione della Repubblica elvetica (1798-1803) l’italiano è, con il tedesco e il francese, tra le lingue ufficiali e paritarie nello statuto nazionale. L’ufficializzazione, giunta con la Costituzione Federale del 1848, sancisce un quadro in cui le lingue romanze rimangono una minoranza in favore di una solida maggioranza germanofona, che caratterizza la complessa compagine linguistica elvetica. Il contatto con le lingue transalpine e alpine, già di per sé favorito dalla collocazione geografica del territorio, posto in un importante crocevia del transito tra il nord e il sud delle Alpi, è dunque intensificato con l’affermarsi del nuovo assetto amministrativo e politico. D’altro canto, nello stesso giro d’anni la formazione delle unità nazionali in Europa suscita, in Italia come altrove, decisive riflessioni sulla lingua, che portano alla descrizione e alla disamina delle varietà dialettali, comprese quelle parlate nella Svizzera italiana. Nei tre secoli della Lombardia svizzera – ovvero l’epoca balivale secondo una denominazione usata da Sandro BianconiBianconiSandro4 – e segnatamente dopo la creazione della moderna Confederazione al dialetto spetta un «ruolo primario» nella coscienza di una comune identità linguistica lombarda, orientata in direzione del principale centro d’irradiazione culturale della città di Milano.5 Come notava DanteAlighieriDante IsellaIsellaDante, il dialetto è l’elemento sul quale si sono fondate le più importanti collaborazioni culturali tra il Ticino e la Lombardia, che hanno irrobustito la consapevolezza di una tradizione comune, profondamente radicata nella storia e resistente alle moderne frontiere politiche.6 Dal vernacolo facchinesco delle valli prealpine e dell’alto Lago Maggiore praticato dai poeti milanesi nei secoli XVI e XVIII, all’edizione clandestina delle poesie di PortaPortaCarlo apparsa a Lugano per i tipi di Vanelli nel 1826, fino alla cospicua collaborazione del poeta dialettale Delio TessaTessaDelio con la Radio e Televisione della Svizzera italiana nel ventennio fascista, il dialetto ha rappresentato un elemento condiviso, un patrimonio comune che ha rinsaldato il rapporto della provincia con il suo centro di riferimento culturale, e viceversa.
Si è perciò scelto, isolando l’aspetto meno noto delle relazioni indicate sopra, di ripercorrere gli episodi salienti della reciproca collaborazione che ha portato in epoca prescientifica allo studio e alla descrizione delle varietà dialettali della Svizzera italiana. Questo filone di ricerca testimonia una protratta riflessione – anche dialettica – sulla geografia linguistica e implicitamente sull’identità dei territori implicati, che prese forma con le classificazioni dei vernacoli italiani prodotte nella prima metà del secolo da studiosi e filologi. Non furono però unicamente gli specialisti a occuparsi delle varietà regionali e della loro descrizione. Lo stesso FransciniFransciniStefano, comunemente considerato l’ideatore del concetto moderno di “Svizzera italiana”, fu pienamente consapevole della continuità linguistica lombarda. Con curiosità intellettuale libera da condizionamenti patriottici, lo statista collaborò alle ricerche sui dialetti lombardi, che certificano e sanciscono l’identità culturale tra il Ticino e la Lombardia. Tale acquisizione, che potrebbe apparire come un elemento sfavorevole all’autonomia della Svizzera italiana, specie con gli attuali criteri difensivi di chiusura, era al contrario ritenuta da FransciniFransciniStefano un argomento fondamentale per il solido inserimento dell’italofonia svizzera nell’assetto politico confederale.
Seguendo le tracce di questa precoce collaborazione, avviata verso la metà degli anni Venti, è possibile ricostruire alcune tappe di una proficua relazione transfrontaliera che coinvolse nella riflessione sui dialetti lombardi studiosi italiani e svizzero-italiani, in un clima di apertura e di vivace scambio. Nell’Ottocento l’area dialettale lombardo-occidentale, come fu definita da BiondelliBiondelliBernardino, era percepita come un elemento aggregante.7 Si è perciò deciso di dare spazio nella presente ricerca a un’importante testimonianza a tale proposito, ovvero al Dizionariuccio Ticinese-luganese-italiano di Francesco CherubiniCherubiniFrancesco: un repertorio compilato dal maggiore lessicografo lombardo del tempo, del quale si presenta in appendice una nuova edizione accompagnata da alcuni materiali preparatori.
Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del secolo XX, con il progressivo consolidamento dell’identità ticinese e poi svizzero-italiana, sorge fra gli intellettuali della regione il problema di definirsi e quindi di riconoscersi culturalmente. Una necessità resa più stringente dall’intensificarsi nei primi decenni del Novecento delle teorie di nazionalismo etnico e linguistico, che aumentavano la pressione degli Stati confinati sulla regione, posta nella condizione di minoranza linguistica nel quadro confederale, e sollecitavano lo spirito difensivo e coesivo del governo centrale. Motivate e legittimate da questo contesto storico, nei primi decenni del secolo nel Ticino si verificano due reazioni contrarie: da un lato è espressa la rivendicazione dell’italianità linguistico-culturale del territorio, suscitata dall’instabilità della regione e dalla minaccia dell’invasione alloglotta; dall’altro prendono piede opposte manifestazioni filoelvetiche, tese a legittimare la “naturale” appartenenza dell’area italofona alla Confederazione in risposta alle potenziali pretese annessionistiche dell’Italia, irrobustite in particolare nel corso del Ventennio.
In questo scenario fu fondamentale la posizione dei due maggiori intellettuali ticinesi del tempo, Carlo SalvioniSalvioniCarlo e Francesco ChiesaChiesaFrancesco, che si collocarono nel dibattito politico-culturale con idee forti, sostenute anche mediante la loro attività linguistica e letteraria. Alle soglie del Novecento, SalvioniSalvioniCarlo disattese i presupposti per un dialogo transalpino stabiliti da FransciniFransciniStefano e limitò al necessario le relazioni con la Svizzera d’oltralpe in omaggio a una fervente italofilia, che lo portò ad assumere anche posizioni oltranzistiche e controverse, in alcuni casi al limite della germanofobia. La posizione radicale assunta dal glottologo, che si attenuò parzialmente nel tempo, emerge in filigrana anche nell’attività scientifica, nelle sue corrispondenze private e segnatamente nelle numerose recensioni da lui pubblicate sul periodico di cultura ticinese «L’Àdula». In queste pagine, sempre fondate su solide basi scientifiche e mai pretestuose, trova maggiore agio e vigore un aspetto meno noto dello studioso, seppur strettamente connesso alla sua attività di ricerca. Ovvero la sua militanza nell’àmbito della politica culturale Svizzero-italiana, condotta, lateralmente alle vie ordinarie, in favore dell’italianità del Cantone Ticino. Nel solco della posizione difesa da SalvioniSalvioniCarlo si orientò anche ChiesaChiesaFrancesco, sostenitore del radicalismo italofilo prima di un’ambigua adesione all’elvetismo, espresso e appoggiato in una forma personale e a tratti controversa. Lo scrittore promosse l’italianità del Cantone mediante l’attività didattica, dentro e fuori la scuola, nonché proponendosi come modello artistico e linguistico. Nel quadro delle espressioni letterarie del patriottismo elvetico, maturato in àmbito francofono sotto l’egida di Gonzague de ReynoldReynoldGonzague de, si è progressivamente modificata la personalità di ChiesaChiesaFrancesco, che da un canto ha segnato e condizionato per decenni il gusto artistico e la percezione culturale del Cantone Ticino, con risvolti non sempre positivi; dall’altro, senza rinunciare all’individualità etnico-linguistica locale, ha di fatto sancito l’inserimento della Svizzera italiana nel dibattito culturale elvetico. Le posizioni di ChiesaChiesaFrancesco e SalvioniSalvioniCarlo, da loro discusse, rinegoziate e modificate nel tempo, restituiscono un’immagine fedele del complesso contesto identitario-culturale della Svizzera italiana a cavallo tra i secoli XIX e XX.
La situazione sembra assestarsi progressivamente nel secondo Novecento, con la pacifica accettazione dell’italianità linguistico-culturale del territorio e dell’appartenenza politica alla Confederazione; o nel peggiore dei casi con il rifiuto dell’una e dell’altra, nel segno di un’ottusa, improduttiva e illusoria autarchia, che ha generato una vasta gamma di blasoni e calunnie etniche, sedimentate nel corso dei secoli nel linguaggio popolare di queste comunità. Come naturale conseguenza delle riflessioni di ChiesaChiesaFrancesco e degli elvetisti, la consapevolezza di appartenere culturalmente allo spazio italiano è invece maturata precocemente e univocamente sul piano artistico e segnatamente letterario, suscitando dibattiti e riflessioni sull’esistenza di una letteratura della Svizzera, e “in piccolo” della Svizzera italiana, lungo tutto il Novecento. Come documentano il dibattito prodotto attorno a queste definizioni e le riflessioni a tale proposito di critici, studiosi e scrittori che si occuparono della vicenda, entrambe le definizioni furono fermamente rifiutate in favore del pieno inserimento degli autori locali nella letteratura italiana tout court, o rispettivamente, per le altre aree linguistiche della Confederazione, in quella francese e tedesca.
Questo percorso tratteggia un disegno globale scostante e complesso, che vaglia e segue con sguardo critico l’articolato sistema di spinte e controspinte che hanno portato al quadro identitario e culturale d’oggi: una situazione nella quale è innegabile l’esistenza di un sentimento cantonalista o regionale, non fondato su un carattere precipuo o singolare ma sul costante rapporto dialettico, di inclusione-esclusione, con la Lombardia e la Svizzera transalpina. Insomma, nel contesto odierno si profila un’identità di frontiera, per sua natura mobile e problematica, che per essere compresa e messa a frutto necessita di uno sguardo consapevole delle ragioni profonde e delle contingenze storiche che hanno portato nel corso dei secoli alla situazione attuale. Con questo obiettivo, pur coscienti dell’inevitabile parzialità di fronte a tale ambizione, si è atteso a uno studio che intreccia e pone in dialogo due aspetti rilevanti e fondativi dell’identità svizzero-italiana: la riflessione sulla lingua e sulla sua manifestazione artistica più diretta, la letteratura.
Nel licenziare queste pagine ringrazio i maestri e i colleghi che mi hanno accompagnato nella loro preparazione e stesura. In particolare, la ricerca deve molto alla generosità di Lorenzo TomasinTomasinLorenzo, al quale esprimo la mia affettuosa riconoscenza. Altrettanto preziosi sono stati i consigli e le osservazioni di Sandro BianconiBianconiSandro, Lorenzo FilipponioFilipponioLorenzo, Bruno MorettiMorettiBruno e Stefano VassereVassereStefano: a loro va il mio ringraziamento. Sono inoltre grato a Rita FranceschiniFranceschiniRita e al Curatorium di Vox Romanica per aver accolto il mio testo nella collana Romanica Helvetica, e al FNS per aver finanziato la ricerca e la sua pubblicazione. Dedico questo libro agli amici della Section d’italien dell’Università di Losanna, con i quali ho condiviso momenti indimenticabili dentro e fuori le aule.