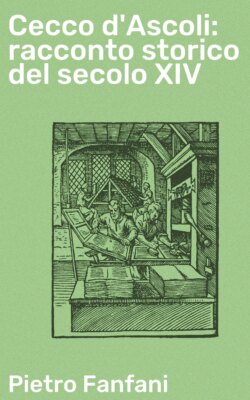Читать книгу Cecco d'Ascoli: racconto storico del secolo XIV - Fanfani Pietro - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO VIII. LA QUARTA CERCHIA E I CONTORNI DI FIRENZE.
ОглавлениеIndice
La quarta cerchia di Firenze (che è quella atterrata ora per far la quinta), già incominciata nel 1284, ed interrotta più volte, era quasi compiuta nel tempo che qui si descrive; e il duca, messosi a pensar di proposito alla guerra contro Castruccio, volle andare a visitarne le parti principali, a fine di appostare i luoghi e i modi più opportuni alla difesa della città in caso di bisogno: il perchè ordinò a questo effetto una nobile cavalcata col proposito di stendersi anche a diporto per le ridenti colline che circondano Firenze. Vi furono col duca e con la duchessa tutti i più segnalati cavalieri e savj di guerra della sua corte; e maestro Cecco d'Ascoli ancora, che di rado mancava colà dove il duca comparisse in pubblico.
Usciti la mattina a terza dalla porta Guelfa, la più vicina al Palagio, e passato l'Arno da S. Niccolò, e ripassatolo poi dalla porta a Verzaja, ora detta di S. Frediano, fecero la intera cerchia; e tutti non si saziavano di ammirare quella stupenda muraglia tutta di pietra, così grossa e così vaga a vedersi, con quei merli guelfi; e più che altra cosa maravigliarono i signori stranieri le grandi moli che si vedevano alle porte, ciascuna delle quali aveva un gran torrione larghissimo, e alto più di sessanta braccia, simili a quello che tuttora è in essere alla porta S. Niccolò; ciascuno dei quali era abile a contenere armi ed armati, da poter ribattere qualunque assalto nemico.
In ciascuno di questi torrioni, dalla parte della campagna, erano quattro scudi di pietra, in uno dei quali lo stemma del comune di Firenze, nell'altro quello della parte guelfa, donata alla repubblica da papa Clemente IV, e questo è un drago verde in campo bianco, a cui poi aggiunsero un giglietto rosso sul capo dell'Aquila[18]; sugli altri due vi era scolpita l'arme del popolo, una croce rossa in campo bianco; e nell'ultimo lo stemma del re Roberto. Nè questi soli torrioni si vedevano nella cerchia; ma altre torri vi erano di tratto in tratto; forti e merlate, tra le quali era maravigliosa una tra porta a Pinti e porta alla Croce, che era detta la Torre del Massajo, celebrata anche da Giovanni Villani. Compiuta che fu dalla nobile cavalcata tutta quanta la cerchia; volle il Duca salire un poco sopra le colline dalla parte di Fiesole; ma fu supplicato di accettare prima una colazione fattagli preparare da messer lo gonfaloniere e dai signori alla Badía fiesolana, a che il duca benignamente assentì. Il convito fu degno di chi lo dava e di chi l'accettava; e tutti quei signori francesi rimasero ben edificati non meno della cortesia fiorentina che delle maraviglie di quel monastero, il quale fu già l'antica cattedrale di Fiesole, e che è insigne per tanti santi da cui fu governata, e per tanti monumenti dell'arte.
Preso commiato da quei monaci, il Duca lasciò loro, partendo, un magnifico donativo; e poi con tutta la compagnia salirono su in alto del colle, da dove si scorge tutta quanta la città; nè può descriversi lo stupore di tutti al vedere quella selva sterminata di palagj e di torri; e mentre tutti erano silenziosi, Cecco fatidicamente esclamò:
« — Firenze, sei bella e grande; e bene, parlando di te, cantò maestro Dante là dove disse che il tuo Uccellatojo aveva vinto Montemario; e bene profetizzò, che, sì come è stato vinto nel montar su, così sarà vinto nel calo; dacchè per molto e molto tempo sarai lacerata dalle maledette parti; sarai poi soggiogata alla tirannía: sarai conculcata e vilipesa dagli stranieri, e ne perderai molto del tuo splendore; sarai invidiata e derisa da altri snaturati figliuoli d'Italia; e questo ti verrà in pena del tuo fallire, e dell'odio che hai già mostrato, e che mostrerai ancor più contro i propugnatori della scienza, e della verità, per saziare la feroce rabbia dei falsi sacerdoti.[19] Ma veggo nel corso dei secoli che tu ripiglierai la presente e molto maggiore grandezza, quando la scienza avrà vinto la superstizione, quando la verità avrà illuminato il mondo, e tu avrai fatto ammenda di ogni tuo fallo, accogliendo e propagando prima fra le città italiche queste due faci dell'umana perfezione.»
Di questa apostrofe improvvisa di Cecco rimasero tutti meravigliati, e molti gli furono attorno, domandando con molta instanza che gli chiarisse di alcune parti di questa sua predizione. Ma egli, che era stato fino allora come assorto in estasi, e che ai prieghi e alle istanze di quei signori erasi come desto dal sonno, mostravasi smemorato, e in tutto nuovo alle parole che gli dicevano, accertandogli che non sapeva di che profezia parlassero, e che non ricordava di avere detto nulla a proposito di Firenze. Essi un poco il credettero, e un poco pensarono che Cecco volesse farsi beffe di loro: e si diedero ad ammirare le circostanti colline, nè si saziavano di celebrarne l'amenità e la vaghezza; dopo di che la nobile comitiva s'avviò verso Firenze, tutti, e forse più di tutti il duca e la duchessa, satisfattissimi di questa lieta giornata. Non creda ora il lettore che quello che io ho detto di Firenze e dei suoi contorni sia un abbellimento oratorio, come la profezia di Cecco. Le memorie antiche ci rappresentano Firenze quale io la descrivo, e la stessa apostrofe di Dante:
Non era vinto ancor Montemalo
Dal vostro Uccellatojo....
mostra aperto quale dovea esser Firenze in quanto a palagj e a monumenti, se, veduta dall'Uccellatojo, che è il punto dove prima scorge Firenze chi viene da Bologna, faceva più bella mostra che Roma veduta da Montemario. E che i contorni siano stati sempre amenissimi, e popolati di case e di nobili edifizj, ce lo attesta il Villani là dove dice: «Intorno alla città sei miglia avea più di abitúri ricchi e nobili, che riunendoli insieme, due Firenze avrien fatte»; ribadito dall'Ariosto due secoli dopo con questi versi:
Se dentro a un mur, sotto un medesmo nome
Fosser raccolte tue bellezze sparte,
Non ti sarian ad agguagliar due Rome.
Qual poi fosse la ricchezza e l'industria di Firenze circa que' tempi si raccoglie da un documento di pochi anni posteriore, registrato dal Pagnini nella Decima, dove si legge che vi erano 280 botteghe di arte di lana dentro la città, 83 botteghe d'arte di seta, magnifiche e di gran pregio, che facevano drappi di seta, e broccati d'oro e d'argento, e dammaschi e velluti e rasi; e queste botteghe aveano la seta dalle galeazze medesime fiorentine, senza aver bisogno di capitare alle mani de' veneziani e de' genovesi; aveva 33 banchi grossi che cambiavano e facevano mercanzia per levante, per ponente, per Bruggia, per Londra, per tutto il mondo.[20]
Ma io mi accorgo, e non vorrei che il lettore avesse a dire: te ne sei accorto un po' tardi, che l'affezione alla mia città mi porta un poco lontano dal proposito; e senza indugio ripiglio il filo del racconto.