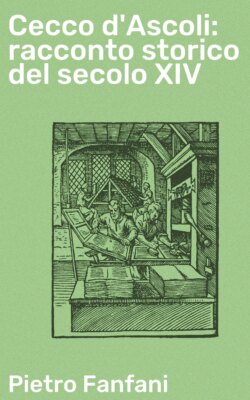Читать книгу Cecco d'Ascoli: racconto storico del secolo XIV - Fanfani Pietro - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO V. GUGLIELMO E DINO DEL GARBO.
ОглавлениеIndice
Ma per procedere con ordine nel mio racconto, sarà bene informare il lettore, chi fosse quel Guglielmo che si incontrò con la Bice Cavalcanti dinanzi alla duchessa, e perchè i due giovani, vedendosi a quel mo' all'improvviso, rimasero così sopraffatti. Guglielmo d'Artese, gentilissimo cavaliere provenzale, era stato a Firenze nel tempo della prima signoría di Roberto re di Napoli, la quale terminò nel 1322. Giovanissimo allora, ricco, e di alta progenie, bello e di bella maniera quanto altro giovane ci fosse al suo tempo, era cercato e accarezzato da tutti; e quella fanciulla che avesse potuto gloriarsi del suo amore, sarebbe stata dalle compagne reputata felicissima di tutto il mondo. Altero e disdegnoso per natura; e forse spregiatore in cuor suo di quei Fiorentini, buoni solo a mercanteggiare, e che la libertà loro appigionavano ora a questo ora a quell'altro signore, poco curavasi più d'una dimostrazione che di un'altra, ed agognava solo allo splendore ed agli onori della corte angioina; e forse aveva lasciato a quella corte la donna del cuor suo, ed a lei sola pensava.
Occorse caso per altro che egli una volta accettò di far parte di una splendida cavalcata che alcuni grandi avevano ordinato, per andare poi a sontuoso convito in una villa de' Cavalcanti a poche miglia dalla città: in questa occasione vide la Bice; e preso da subito amore a quella maravigliosa bellezza, ed avutane corrispondenza, pose ogni cura a piacerle, e ben tosto fu diventato un altro uomo, nè più qua o più là pensava di lei, che riamollo di puro, ma di ardentissimo amore. Se non che bisognava farlo celatamente, perchè il padre di lei era avversissimo a tale amore, e fremeva al solo pensiero che la sua Bice dovesse ire sposa ad un cavaliere straniero.
Cessata nel 22 la signoría del re Roberto, Guglielmo fu obbligato di ritornare alla corte; nè si può dire quanto fosse dolorosa a' due amanti questa separazione. Promise l'uno all'altro fede inviolabile ed amore costante: promise Guglielmo che le avrebbe fatto pervenire novelle di sè ogni volta che il destro se ne porgeva; ma, qual se ne fosse la cagione, dopo il primo anno la Bice non seppe più nulla di Guglielmo; della qual cosa la povera fanciulla se ne accorò tanto, che non fu più mai lieta. Sicchè può facilmente indovinare il lettore qual debba essere stato il cuore di ambedue, ritrovandosi inaspettatamente, dopo cinque anni, l'uno sì presso all'altro; e può con pari facilità immaginarsi qual tempesta di pensieri dovesse tormentare il cuore di essi, tornati che furono alla quiete delle loro case. La povera Bice ne rimase smemorata per parecchie ore, ed a fatica potè celare il suo turbamento a Geri suo padre, uomo assai risentito, e che sarebbe montato su tutte le furie, benchè alla figliuola volesse un bene dell'anima, se avesse saputo il fatto. Il trovarsi per altro così vicino il suo diletto, che erale paruto sempre più bello; quello sguardo suo così amoroso; il modo di quella sua esclamazione, gli rimisero la quiete e le speranza nel cuore; e dove fino allora aveva tenuto quel giovane per infedele e dimentico di lei, ora a tutt'altra cagione si studiava di recare il suo lungo silenzio, e solamente stava dubbiosa e timida del come poterlo vedere d'allora innanzi e parlargli.
Guglielmo dall'altra parte non istava punto meglio della Bice: l'aveva creduta infedele, perchè mai, se non una volta sola, avevagli scritto. Ito negli ultimi due anni a corte di papa in Avignone, ed in altre nobili ambasceríe, sempre portava seco il rammarico del perduto amore, nè poteva consolarsene; e come giunse in Firenze, tremavagli il cuore o di trovarla maritata, o forse anco morta, come qualche volta eragli balenato alla mente. Ed anch'egli, quando fu tornato in sè dallo smarrimento che lo colse a piè della duchessa, si riconfortò del vederla, non pur viva, ma tuttora fanciulla (sapendo che tutte fanciulle dovevano essere le presentatrici dei fiori); e gli parve altresì di poter indovinare che sempre l'amava, tanto teneri furono i pochi sguardi ch'ella potè dargli, e tanto abbondanti le lacrime che poi versava; le quali non potevano essere di chi avesselo tradito, perchè i traditori non piangono.
Ma perchè la duchessa andò stizzosamente nelle sue stanze? Ecco un'altra curiosità del lettore; ed eccomi a tosto levargliela. La duchessa si accorse subito che i due giovani dovevano amarsi fin da quando Guglielmo era stato l'ultima volta a Firenze: egli era bello, gentile e prode in arme: non lo avrebbe detto neanco a se stessa, nè gliene avrebbe fatto segno veruno, a costo della vita, perchè mai avrebbe mancato di fede al duca; ma essa lo amava in cuor suo; e in quel punto sentì fiera gelosía, e sdegno ad un tempo, che sì nobile e gentil cavaliere avesse posto il suo cuore in sì basso luogo, come, secondo lei, era la figliuola d'uno di questi mercanti fiorentini: e pensò fin d'allora di attraversare con tutte le sue forze tal cosa. Il giovane, da talune parole tronche, e da qualche atto involontario, non che avesse conosciuto, ma eragli parso d'intravedere come la duchessa nol vedea di mal'occhio; ma bene era lunge dal darsene per inteso, leale come egli era verso il suo signore: anzi, anche per ciò non gli rincrebbe che fosse avvenuto dinanzi a lei quanto avvenne con la Bice, sperando che il saperlo amante di un'altra le caverebbe dal cuore ogni pensiero di amore se pur ce l'avesse avuto; e non pensò ad altro, se non a trovar modo di poter vedere la sua donna.
La prima cosa aveva cercato d'informarsi che cosa fosse avvenuto di una fida cameriera, consapevole del loro amore mentre egli stette in Firenze; ma seppe esser morta: poche, anzi niuna conoscenza familiare aveva in città, nè sapeva qual via tenere per giungere agli intenti suoi; quando gli corse alla mente Dino del Garbo, che, per averlo curato anni addietro, avea con lui molta dimestichezza, ed era parimenti tutto di casa Cavalcanti. Non mise tempo in mezzo; ed in meno che non si dice fu a casa Dino, il quale, vedutolo, gli fece meravigliosa festa. Ma Guglielmo senza altre parole:
— Maestro, sono alla mercè vostra; mi salvaste altra volta, salvatemi adesso.
— Cosa ch'io possa, bel cavaliere; che vi piace?
— Non cerco ajuto dall'arte vostra; ma dal vostro affetto e dal vostro consiglio.
— E l'una cosa e l'altra son tutte vostre: parlate.
— Sono innamorato, e vengo da voi per soccorso.
— Qui, figliuolo, nè l'arte mia, nè l'affetto, nè il consiglio ci possono nulla; e dall'altra parte io spero che non vorrete farmi Prenze Galeotto, soggiunse ridendo maestro Dino.
— Oh, maestro, è troppa la riverenza in che vi tengo, e il grato animo che mi vi lega, da formare così vile pensiero di voi... Ma voi siete famigliare ed amico dei Cavalcanti...
— Intendo, cavaliere, dove volete riuscire. Fin da quando vi curai del vostro malore mi accorsi del vostro amore per la Bice de' Cavalcanti; e dopo che foste partito, ne presi certezza dal modo che essa teneva, dalla grave mestizia che la occupò, e da certe parole tronche di M. Geri, il quale per altro non me ne disse mai nulla direttamente.
— Come! la Bice si accorò del mio partire, e ne fu sempre dolente?
— Non ebbe mai più bene di sè; ed era la maraviglia e il rammarico di tutti il vedere colei che era stata il fiore e la letizia delle donzelle fiorentine, ridotta una cosa tanto scura e tanto mesta.
— Maestro, se Dio vi ajuti, non mi abbandonate. Io vivo solo per la Bice: l'amo, dopo Dio, sopra ogni cosa umana; fate che io le parli: sono cinque interi anni che mi consumo di lei: cinque interi anni che nulla ne ho più saputo: l'ho creduta infedele; l'ho creduta sposa di un altro: l'ho creduta perfin morta. E ora l'ho riveduta sempre più bella, sempre più angelica, sempre amante... Maestro, ajutatemi, consigliatemi.
E qui non potè fare che allo scongiuro non tenesse dietro uno scoppio di pianto.
— Figliuolo — disse maestro Dino — che io vi procuri il modo di parlare alla Bice non è onesto nè a me nè a lei. Posso bene parlarne con M. Geri suo padre, ed esortarlo efficacissimamente che secondi gli onesti vostri desiderj.
— Suo padre! è inutile, maestro: fu avverso al nostro amore fin da principio.
— Io non so altra via che sia buona.
— Oh Dio, voi mi uccidete: io son diserto... da chi troverò consiglio?... Ah!... maestro Cecco! esclamò Guglielmo, a modo di chi si mostra lieto di aver trovato un sicuro ripiego.
Al nome di maestro Cecco, Dino si fece in volto come di bragia, e con atto di strana maraviglia dimandò:
— Maestro Cecco! Intendereste forse di Cecco d'Ascoli?
— Sì, rispose Guglielmo, esso è uomo di tanta sapienza, che...
— Di tanta sapienza? — interruppe Dino, — esso è un eretico scomunicato; è nimico del nome fiorentino; e i due più illustri figliuoli di questa patria ha scherniti e vituperati, dico Dante e Guido Cavalcanti, zio appunto del padre di quella Bice che voi amate. E voi ora vorreste che, siccome egli vituperò il zio, ora vituperasse il nipote, facendo da mezzano agli amori della sua figliuola...
— Maestro Dino, io sono leale cavaliere...
— I Fiorentini, messere, si chiamano ciechi, ma non sono: e i grandi di questa terra sono e leali e generosi e valenti in arme quanto cavaliere o francese o provenzale; nè loro si fa vergogna che non si paghi col sangue, o con lacrime amare.
— Maestro Dino! — riprese da capo Guglielmo — se voi non foste quell'uomo che siete, e se non aveste codesti capelli bianchi, non so s'io comporterei sì fatte parole.
— Nè io, così canuto, ho paura di voi e de' pari vostri. Maestro Cecco!... E il Duca stesso, che sapeva l'avversione di lui a Firenze, e come egli abbia cercato di offuscare le glorie maggiori nostre, chi sa che non lo abbia condotto qua seco per ischerno e per oltraggio di noi e della nostra terra. Ma, se questa è ora oppressa dalla sventura, e i suoi cittadini ora dormono, potrebbero un giorno destarsi, e far pagar caro a' superbi stranieri, ed ai truci tiranni lo scherno e l'oltraggio.
Tali parole diceva Dino tutto infiammato nel volto, e vinto assolutamente dall'ira. Tanto era l'odio che aveva per Cecco, che il solo nominarlo, ed il sentire che godeva fama di sapienza, gli aveva tolto il lume degli occhi; e chi sa fino a qual punto sarebbe arrivata la cieca furia di lui, se Guglielmo, tra per la riverenza in che lo teneva, per il rispetto alla sua canizie, e per non sentirsi tirato pe' capelli ad oltraggiare quel vecchio in sua casa, pensò bene di partirsene, dicendogli sole queste parole: «Maestro, io non sono troppo letterato; ma ricordomi bene di aver letto che un antico savio latino disse questa sentenza: Ira est initium insaniae.»