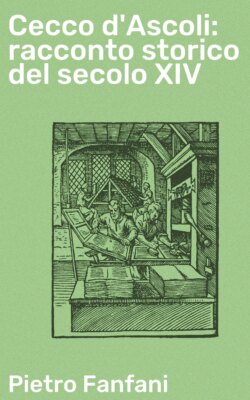Читать книгу Cecco d'Ascoli: racconto storico del secolo XIV - Fanfani Pietro - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ORIGINE E PROPOSITO DI QUESTO LIBRO.
ОглавлениеIndice
Una mattina, là sullo spirare del 1868, venne da me un compitissimo giovine e di bella maniera, il quale, dopo le cerimonie di uso, garbatamente mi disse:
— Vorrei un favore da lei.
— Due, potendo.
— Io son uno dei Direttori del Diritto; e vorrei che la ci scrivesse un romanzo.
— Un romanzo io? ma le pare? Io che non leggo mai romanzi; che non ho mai tentato nulla di simil genere; come vuole che possa fare un romanzo? Mi rincresce; ma questo appunto è uno di quei favori che non posso farle.
— Badi: il compenso che il Diritto le darebbe, non dovrebbe essere indegno nè di lei nè delle Lettere.
— Mio caro signor Mussi (era appunto il signor Mussi que' che parlava meco), la quistione non è codesta: è che io romanzi non ne so fare, e non ne vo' fare.
— Ma ci pensi..... provi..... O almeno ci illustri un periodo di storia a modo suo. Insomma, vogliamo qualche lavoro di lei per l'appendice del Diritto.
— Ci penserò; ma non le prometto.
— A rivederla.
— A rivederla.
Io non aveva voglia per niente di pensare a questa faccenda; ma, capitatomi a mano in questo mezzo tempo un codice, dove era la sentenza di Cecco d'Ascoli; mi balenò in mente che nel fatto di questo illustre sventurato ci fosse materia da farci qualcosa: ripensai tutto quel periodo di storia, che è bellissimo: almanaccai per immaginare accessorj; e passando di un pensiero in un altro, mi trovai scritto nella mente un disegno, che mi parve da potersi colorire con qualche buon effetto. Allora mi venne voglia di provarmi; e scrissi al signor Mussi, che passasse da me, come fece senza indugio.
— Ho pensato a quell'affare: il soggetto sarebbe Cecco d'Ascoli: le piace?
— Mi piace; e poi, basta che piaccia a Lei.
— Le condizioni?
— Le dissi che non sarebbero indegne nè di lei nè delle Lettere. Le scriveremo una lettera, ed ella spero risponderà che accetta.
— Badi: ella compra gatta in sacco: per me questi sono lavori nuovi; e potrei far cosa che non piacesse; tanto più che io non potrò mai indurmi a scrivere le esagerazioni di molti fra gli odierni romanzieri, perchè le credo artifizio e non arte, e poi perchè ciò ripugna alla mia natura.
— Faccia come le pare; chè noi saremo sempre contenti.
Il giorno appresso mi venne la promessa lettera dalla Direzione del Diritto: le condizioni erano quali il signor Mussi le aveva promesse: le accettai senza esitare: furono mantenute scrupolosamente da ambe le parti; e il racconto del Cecco d'Ascoli si pubblicò tutto intero dal marzo al giugno dell'anno passato.
Così nacque il presente racconto. Adesso il lettore di questa ristampa è bene che sappia con qual proposito lo dettai; e glielo dirò, riportando la lettera che io, nella soggetta materia, scrissi già al signor Ugo Bassani di Venezia, e che in questi giorni si è veduta stampata in varj giornali.
«Firenze, 12 Giugno 1870.
«Mio caro Ugo,
«Quel mio racconto del Cecco d'Ascoli, di cui leggesti i primi capitoli, quando testè fui a Venezia, e del quale mi chiedi adesso ragguaglio, non è un romanzo nel proprio significato che ora suol darsi a tal voce. Io ho voluto solamente fare un racconto, che desse qualche diletto non senza istruzione. Narrando il compassionevole caso di Cecco d'Ascoli, ho avuto per proposito di render familiare tra il popolo quel periodo di storia fiorentina, di metter in veduta, come suol dirsi, la vita intima dei Fiorentini, le usanze e i costumi di quel tempo, ed anche di descrivere in parte com'era allora Firenze. Il racconto è molto variato di avventure, di guerre, di piacevolezze e di amori; ma ho fuggito a disegno ciò ch'è pascolo più ghiotto ai volgari lettori di romanzi, dico le esagerazioni di ogni maniera, passioni violente, lascivie ed oscenità, orribili colpe e delitti, tutto quell'apparecchio insomma dell'arsenale de' romanzieri, per mezzo del quale si turba e si sconvolge l'animo e la mente dei lettori; tenendomi invece alla temperanza in ogni cosa, e ingegnandomi di toccare il cuore per altra via, acciocchè il mio libro possa lasciarsi leggere, anche alle fanciulle più gelosamente guardate, senza un pericolo al mondo, ed il lettore se ne senta placidamente commosso, e provocato al bene, anzi che al mal fare. Mi sono studiato pure di scriverlo con quella maggior diligenza della quale son capace; e se, avendo alle mani personaggi del trecento, ho dovuto fargli parlare al modo del loro tempo, mi conforto che tutto insieme il dettato del mio libro debba sembrare anche ai più schizzinosi, sciolto e non punto affettato: e perchè nulla rimanga oscuro, anche ai lettori meno esperti, alcune voci e modi oramai fuor d'uso, o usati in altro significato, che necessariamente debbono usare i miei personaggi, si troveranno registrati e spiegati in fine del racconto. Insomma io mi sono ingegnato di fare quel meglio che ho potuto, acciocchè l'opera non riesca uggiosa, o dannosa; la qual sarà anche più accetta al pubblico, se il nostro valentissimo Tessarin metterà in musica, come mi fa sperare, le serventese che fo cantare ad un menestrello al convito del Duca di Calabria, e che farò stampare in fine volume.
«Ecco quel ch'io posso dirti sommariamente del mio Cecco d'Ascoli, il quale uscirà fuori nel prossimo mese di luglio, e per il quale non ti nego d'avere qualche affetto, e di starne colla tremarella per il dubbio che possa trovare poco amorevole accoglienza.
«Basta, speriamo. Intanto io lavoro di forza. Addio, e voglimi bene».
Al Lettore parrà strano questo star con la tremarella per la pubblicazione, dopo che il mio racconto ha già sperimentato il giudizio del pubblico, e dopo aver'io detto che spero non abbia in tutto a dispiacere. Ma pensi il Lettore che altra cosa è il pubblicare un lavoro spezzatamente per appendice a un giornale politico, dove i lettori leggono a intervalli[9] e non sempre attentamente; ed altro il veder raccolto ogni cosa in un libro, dove ad una occhiata si vede se tutto è al suo posto, se l'una cosa risponde all'altra, se il disegno è corretto, se il colorito è quale lo richiede il soggetto. Pensi che, se io spero di non dispiacere a que' pochi, i quali ne posson giudicare secondo i precetti dell'arte, manca a questo racconto tutto ciò che è più ghiottamente richiesto dai lettori volgari: amori lascivi, atroci delitti, maledizioni e improperj scandalosi di frati e di preti: furibonde declamazioni politiche; tutte quelle pazzie insomma, che piacciono al volgo cieco, il quale va in brodo di succiole leggendole, ed urla bravo e batte furiosamente le mani, se le vede rappresentate, o se le ode briacamente declamate da qualche Cetègo Prefetto o da qualche Bruto Commendatore. Ma del giudizio del volgo, mi dirà qualcuno, non è da curarsi. È vero; ed io non dicevo che me ne importasse nulla: solo volevo dire che temo di fallire al fine a cui miro, di avvezzare il popolo a letture, che lo educhino alla virtù piuttosto che al vizio.
Odo farmi un'altra domanda: Il tuo libro potrà essere un libro popolare?
Io non prenderò per denaro contante quello che del mio Cecco d'Ascoli scrisse il signor Zaccaria nel suo opuscolo intitolato De' Romanzieri e del signor Pietro Fanfani; anzi quell'encomio, non mosso certo da affetto speciale, perchè il signor Zaccaria me non conosceva nè io lui, lo reputo effetto di particolari impressioni, e disposizione di animo: ricorderò solo quello che ne scrisse la Rivista Bolognese, la quale appunto toccò l'argomento della popolarità. A pag. 417 dell'anno 1.º si legge: «Il romanzo del Fanfani, per quanto deliziosamente scritto (grazie: è troppo), non otterrà vanto di popolare. Mettere dinanzi gli occhi del popolo costumanze e avvenimenti di secoli addietro, parmi non saggio consiglio. Il vero popolo quello, che lavora, e suda, e patisce, ed è tutto immerso nelle dure realtà del presente, non li comprende e non li gusta; egli non trova là dentro la propria immagine, non si muovono là que' sentimenti, quelle passioni che riscaldano oggi il suo cuore». Mi perdoni il valente autore di quello scritto: a me sembra che la popolarità delle scritture si debba ripetere da altri principj; ma come questa sarebbe discussione lunghissima, nè qui può aver luogo, dirò solo che, se popolarità è quella che egli dice, io non ho certo avuto una intenzione al mondo di fare un libro popolare. Per altro gli domanderò: sono popolari in Inghilterra i Romanzi di Walter Scott? Bene: o non sono appunto di quelli che mettono dinanzi agli occhi costumanze e avvenimenti di secoli addietro? non hanno mirabilmente servito a render popolare in Inghilterra l'antica storia, e le antiche costumanze inglesi? E non è questo servizio utilissimo e popolarissimo? Mi dica piuttosto che il popolo inglese è troppo diverso dall'italiano, ed allor dirà bene. Poi aggiungo io, sorga fra noi un Walter Scott, e allora anche i romanzi che mettono dinanzi agli occhi avvenimenti, e costumanze de' secoli addietro, diventeran popolari, cioè efficacemente utili alla educazione del popolo. Ma già, che parlo io di Walter Scott? o i Promessi Sposi, o l'Assedio di Firenze, o la Battaglia di Benevento, Niccolò de' Lapi, la Margherita Pusterla ec. ec. non sono essi popolari, benchè la loro materia sia di secoli addietro? Quanto al presente libro ed a me, sarò contento che mi sia valutata la buona intenzione.
Ora due sole parole circa la tela del mio racconto. L'orditura è scrupulosamente storica, e storici sono i fatti principali: è storico tutto ciò che riguarda le azioni pubbliche del personaggio principale, e del duca di Calabria: la Bice, la Badessa, Guglielmo, frate Marco, il prete di Settimello con la Simona sua serva, gli amori, e ogni altro fatto privato di essi, ogni cosa è trovato della fantasía. Dino del Garbo è disegnato secondo gli accenni che ne lasciò il Villani, storico contemporaneo; e così il vescovo d'Aversa cancelliere del duca.
Le descrizioni di feste, di conviti, di cerimonie sacre; le ordinanze militari, la forma dei giudizj e delle sentenze, tutto è ritratto secondo le usanze di quel tempo, e quasi copiato da documenti autentici.
Della lingua che dirò? Dirò che ci ho speso attorno ogni più amorosa cura; studiandomi di essere italiano, senza abuso di toscanità. Dovendo far parlare personaggi del trecento, sono stato un pezzo infra due, se dovessi far loro usare voci e modi speciali del loro tempo, o farli parlar tutti al modo odierno. Pensando però essere una ridicolezza il sentir dire a un trecentista colazione e non asciolvere; far le barricate e non asserragliare; capitolo di una chiesa, e non chericía; projettili e non saettamento e simili; ed essendo stretto mio dovere il nominare col loro nome proprio gli ufficii, e le dignità, e i titoli del cerimoniale, o come direbbero i nostri, della etichetta di allora, presi partito, tanto più che la lingua italiana ha poco cambiato da sei secoli in qua, di far parlare i miei personaggi nella lingua del loro tempo; ma ingegnandomi di scegliere solo da essa quella maggior parte che è tuttora viva; salvochè, dovendo significare cose speciali, modi di salutare, titoli, nomi di uffici ec., ho usato i modi di allora, diversi dai presenti, dandone la dichiarazione in un glossarietto in fine del volume, per comodo di que' pochi lettori che non ne sapessero il vero significato. Mi sono ingegnato insomma di scrivere in modo che coloro i quali conoscono l'arte, veggano esser questa la lingua non dell'avvenire, ma la italiana secondo l'uso buono degli scrittori e del popolo; e gl'indòtti non ci trovino nulla di affettato e d'insolito, fuor che quelle voci e modi detti di sopra, da me postici per necessità.
P. Fanfani.