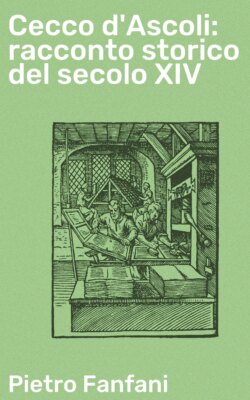Читать книгу Cecco d'Ascoli: racconto storico del secolo XIV - Fanfani Pietro - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO XII. IL CONVITO.
ОглавлениеIndice
Quel giorno vi era proprio festa in palagio, e tale ne era la cagione. Le donne fiorentine usavano già, per dirlo con le parole del Villani «un loro speciale e disonesto ornamento di trecce grosse di seta gialla e bianca, le quali portavano in luogo di trecce di capelli dinanzi al viso; il quale ornamento, che spiaceva a' fiorentini, perchè era disonesto e contrario a natura, avevano tolto alle donne, e fatti capitoli intorno a ciò, e altri disordinati ornamenti.» Ora esse donne fiorentine mossero preghiera alla duchessa, la quale faceva loro spesso conviti splendidi e gran feste in compagnía di quei signori francesi, che quell'ornamento delle trecce si rendesse loro, e il duca ai prieghi di lei lo concedè; il perchè la duchessa, per festeggiare quel giorno, volle far gran convito, dove tutte dovevano comparire con quelle trecce sopradette, ed ella altresì. Doveva esservi ancora il fiore de' cavalieri provenzali e francesi del regno, venuti qua col duca di Calabria, e sino dalla mattina ciascuno di essi era tutto occupato del come porgersi più leggiadro e più adorno, per avere il pregio della cortesía in quella giornata, che la regina della festa soleva dare, e consisteva in una sciarpia di seta coi colori angioíni, vagamente trapunta dalle mani stesse della duchessa.
Il convito fu veramente suntuoso; e porta il pregio che ne facciamo una minuta descrizione per saggio della magnificenza e delle usanze di quei tempi.
In capo della sala, e dai due lati, le mura furono coperte di finissimi drappi d'oro o di seta dal tetto infino al solajo; nel mezzo, di dietro alla sedia dove doveva stare il duca, fu una ricchissima pezza di sciámito vermiglio, che teneva dal solajo al colmo del tetto, e poi rivoltata sopra la sedia, più d'una canna; che fu nobilissima cosa e del più fine colore che mai si vide. Tutto il rimanente della sala era coperta di finissimi e grandi capoletti, o come or si direbbe arazzi, con nuove e diverse storie; e così pancali, e tappeti sotto i piedi. Le tavole furono coperte di finissime tovaglie, con ricchi vasellamenti d'oro e d'argento. Vi furono nove vivande triplicate, che furono ventisette, di tante diversità, che a descriverle sarebbe lunga opera; basta che vi fu ogni cosa che si può pensare fosse cara e preziosa: e servirono a tavola ventiquattro scudieri, ciascuno vestito della divisa angioína, di panno cupo partito vermiglio.
In sul dar l'acqua alle mani, eccoti entrar nella sala maestro Cecco, al qual fu fatta meravigliosa festa; e la duchessa, tutta lieta in volto, gli disse:
— Maestro, che novelle del tuo Florone?
— Buone, madama: egli è oggi tutto mio. Ma innanzi tratto vorrei che messer lo duca comandasse a qualcuno de' suoi prodi cavalieri che venga in mio soccorso contro i suoi e miei nemici.
E il duca, a' prieghi della duchessa, comandò a quattro nobili cavalieri che andassero con maestro Cecco, il quale gli condusse seco: e parve loro di andare sulla piazza di S. Croce; e il popolo fiorentino esservi tutto in arme gridando muoja muoja contro Cecco, e contro la signoría del duca: fanti e cavalli venire sotto il comando dei quattro cavalieri, e la battaglia tosto cominciare e il popolo fiorentino dopo lunga tenzone essere sconfitto, ed i cavalieri correr la terra in nome del duca; e il giorno appresso pigliare essi la signoría, e crear nuovo gonfaloniere e nuovi priori, riformando la terra a loro senno. E quando la impresa fu compiuta, disse Cecco a' quattro cavalieri:
— Signori, fia buono tornare al palagio, dove il duca e la duchessa ci aspettano al convito delle donne fiorentine.
— Maestro, disse l'uno de' cavalieri, voi vi gabbate di noi. Il convito fu bene l'altrieri, e noi rimanemmo a denti asciutti, per obbedire al comando del duca, e venire a combattere. Ora resta solo che sia ragguagliato il duca della nostra impresa.
E tra questi ed altri ragionamenti erano già ritornati nella sala, dove trovarono tutti i cavalieri e tutte le dame, che si davano l'acqua alle mani, appunto come gli avevano lasciati. E tutto ciò era stato per arte magica.[23]
I quattro cavalieri trasognarono, nè potevan rinvenire dalla maraviglia: il duca e le dame gli fecero più volte raccontare la novella, e ne fu fatta maravigliosa allegrezza, e lietamente si assettarono a tavola. Dopo le tre vivande, delle nove sopraddette, venne per inframezzo un castello molto grande, dove furono selvaggine, solamente di bestie, un gran cervo che pareva vivo ed era cotto, un cinghiale, capriuoli, lepri, che tutti parean vivi, ed eran cotti. Fu recato e guidato dagli scudieri, ed accompagnato da cavalieri con istrumenti di diverse maniere, e il rumore degli strumenti, e il rallegrarsi della gente ne andavano al cielo. Alla quarta vivanda entrarono nella sala valletti del comune di Firenze, e l'uno dei cavalieri disse al duca: «Messere, egli è giù un destriere bianco, bellissimo e nobilissimo, ed ecco due anella e un nappo coperchiato col suo piede. Messer lo gonfaloniere di Firenze e i priori, vi supplicano che vi piaccia di prendere queste cose».
E il duca prese l'anello, che fu un grosso zaffiro e un grosso topazio, e miseselo in dito; e prese il nappo; e comandò che fosse preso il destriero. Venne appresso la quinta vivanda, e dopo questa fu recata da quattro uomini una fontana, che nel mezzo avea una torricella, sopra cui era una colonna che gettava da cinque parti vino, vernaccia, greco, vino renese[24], ed altri vini finissimi. Sulla sponda della fontana eranvi pavoni cotti che parevan vivi, con la coda a padiglione; fagiani, pernici, e altre selvaggine. E anche questo accompagnato da canti e da suoni. Dopo la sesta e settima vivanda vennero nella sala sei grandi destrieri, a uno a uno, montati da sei cavalieri armati; il primo, armato leggermente aveva in mano una bandiera con l'arme del popolo fiorentino, e come furono nella sala, tutti cominciarono a ferire un torneamento, ed ebbe il pregio un cavaliere che aveva un'insegna coll'aquila del re Roberto. Questi cavalli erano congegnati in questo modo: sei uomini portavano una macchina leggerissima con forma di cavallo, ed erano covertati fino a terra, che non si vedea che fossero uomini; e sopra a que' cavalli erano vere selle, e veri uomini armati di tutte armi. Compiuta l'ottava vivanda vennero sei schermidori, vestiti ad una assisa; e dinanzi al duca e alla duchessa cominciarono una fiera ed aspra zuffa, che a' suoni dei diversi e spessi colpi pareano più di trenta uomini che combattessero. Per inframezzo della nona vivanda fu udito un cantare di uomini e di donne, ma non veduti, con voci di soavissima dolcezza, che rendevano muta tutta quanta la sala, venuta quasi fuori di sè per la soave melodía.
Qui entrò nella sala un bellissimo giovane, biondo e di aspetto gentile, vestito alla foggia dei menestrelli, che, fatte alcune ricercate sopra il liuto, inchinatosi al duca ed alla duchessa, e salutate cortesemente le dame e i cavalieri, con lieta e chiara voce incominciò a cantare:
»Prodezza e cortesía
»Non perdon mai balía,
Tu sei, mia dolce terra,
Stretta da cruda guerra;
Ma un prode cavaliero
Cinge spada e brocchiero,
E te, Fiorenza mia,
Ritorna in signoría.
Il fiero capitano
Ti corse il colle e il piano;
Ma vinto fia da lui
Egli e' seguaci sui.
Prodezza e cortesía,
Non perdon mai balía.
Di lui ne andranno alteri
Le donne e i cavalieri:
Per lui la Chiesa santa
Fiorisce, e osanna canta;
E tu, Fiorenza mia,
Riprendi signoría.
Castruccio e i Ghibellini
Dentro da' lor confini
Con onta e con dispetto
Cercheranno ricetto.
Prodezza e cortesía
Non perdon mai balía.
Carlo, glorioso sire,
Darà lor gran martire,
Finchè gli abbia distrutti,
Ed al niente condutti,
E te, Fiorenza mia,
Rimessa in signoría,
Or voi, donne e signori,
Ciascun l'ami e l'onori;
Salute è di Fiorenza;
Chè, certa è la sentenza:
»Prodezza e cortesía
»Non perdon mai balía.
Finito il canto, la sala risonò tutta di lieti evviva al signore ed alla duchessa, e di lodi al gentile cantore, a cui fu donata da Carlo ricchissima veste.
Levata finalmente la nona vivanda, vennero frutte di diverse maniere; ed in sulla tavola del duca e della duchessa furono portati due alberi, l'uno che pareva tutto d'argento, con mele, pere, fichi, pesche, e uve d'oro; l'altro tutto verde a modo d'alloro con altri frutti d'ogni colore: e quei frutti erano tutti finissimi confetti. Stando le frutte ancor sulla tavola, venne il maestro cuoco del duca con una brigata di suoi compagni cogli strumenti innanzi, con moccoletti artificiali, e con sonagli, ed entrarono danzando allegrissimamente per la sala; e così, intorniate le tavole tre o quattro volte, si partirono; e ciascuno si levò da sedere.
Non vi fu dama o cavaliere che non rimanesse stupefatto da tanto splendida magnificenza; e tutti si apparecchiavano ad andarsene; quando maestro Cecco, fatti suoi incantamenti, la sala tramutò in vaghissimo giardino con fontane, pergolati, e fiori vivi di ogni maniera; e non solo ciascuno dei comitati presentò di un mazzo odorosissimo; ma, fattosi alla finestra, alla plebe affollata dinanzi al palagio gittò e fiori e confetti abbondantissimamente, per la qual cosa le risa, le grida e gli applausi empivano mezza Firenze. Il pregio della cortesía fu dato quel giorno a messer Guglielmo d'Artese, a cui la duchessa di propria mano volle cinger la ciarpa.
Ma i lettori penseranno dentro di sè: «O che questo scrittore ci ha preso per isbalorditi affatto, dandoci per vere sì strane cose, e vuol farsi beffe di noi; o che egli è un gran semplicione egli stesso.» Nè l'una cosa nè l'altra, o lettrici e lettori miei. Nella descrizione del convito non ci ha nulla di esagerato nè d'inventato: se ne trovano in quel secolo delle descrizioni anche più maravigliose di questa; e ciascuno le può vedere. Circa alle magíe di Cecco, io ne ho recata qualcuna, perchè, siano strane quanto si vogliono, mostrano intorno ad esso il tradizionale e comun concetto della magía.
È tradizione popolare che Cecco da giovane andasse in Calabria, e che in una ostería alcuni pastori lo invitassero a cercar di un tesoro; che, arrivati a una profonda cisterna e secca, ve lo calarono, ed egli vi trovò un bigonciuolo d'oro: i pastori, tirato su l'oro, vi lasciarono Cecco, il quale, rimasto solo, vedendo un libro ai suoi piedi, lo ricolse, l'aprì, e ad un tratto un diluvio di spiriti gli furono attorno con queste parole: COMANDA, COMANDA. Volle tornare all'ostería, e vi fu in un attimo; poi viaggiò mezzo mondo, e per tutto faceva meraviglie. Queste magíe recate da me, ed altre che ne recherò, mostrano solo che nella credenza del popolo era che Cecco fosse mago; anzi è tuttavía creduto appresso il volgo fiorentino; ed uno dei tanti codici laurenziani, assicurati nei banchi con catene, si dice che fosse incatenato così per essere appunto quel libro diabolico di Cecco Diascolo, che il popolo chiama libro del comando. E laggiù sui confini dell'Abruzzo da Teramo vi è un ponte, che si dice costruito da Cecco, e chiamasi il ponte del Diavolo, perchè si tenea fatto in una notte: il quale non molti anni addietro fu murato per impedire il passaggio dei viandanti, dacchè fra il volgo era comune credenza, che ogni anno il diavolo voleva per sè un'anima tra coloro che quel ponte valicavano. A mia scusa maggiore dirò altresì che molte cose veggiamo fare ai nostri giorni dai prestigiatori, anche di più meraviglia che alcune di quelle operate da Cecco, il quale, scienziato come era, poteva bene aver l'arte che questi hanno: la moltiplicazione dei fiori, per esempio, che già abbiamo veduto; e il mostrar la propria testa recisa dal busto, come vedremo più qua, son cose, le quali si veggono alla giornata, nè più ci fanno veruna maraviglia. Queste poche parole credo che bastino a mia giustificazione; e come la digressione è stata già assai lunga, così ritorno senz'altro al filo del racconto.