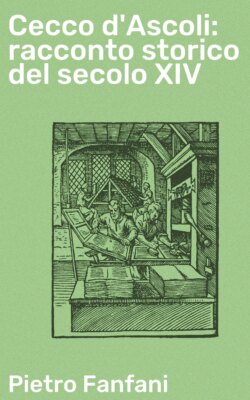Читать книгу Cecco d'Ascoli: racconto storico del secolo XIV - Fanfani Pietro - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO II. UN POCO DI STORIA. — CECCO D'ASCOLI, MAESTRO DINO DEL GARBO, E L'INQUISITORE.
ОглавлениеIndice
La città di Firenze reggevasi a popolo, e godeva della sua libertà, dicono i vagheggiatori dei governi popolari, ricordando le cose fiorentine, specialmente del secolo XIV. Ma di che sapore era ella questa libertà, e quali erano i frutti che dava? Fino dal principio del secolo Firenze, come dice Dante, rinnovava genti e modi; e più che mai la straziavano le maledette parti de' Bianchi e de' Neri, trapiantatevi da Pistoja; e diventava un Marcello, per usare la mirabil frase di Dante medesimo, ogni villano che venía parteggiando. Tutta la gloria e tutto il desío di quegli sciagurati consisteva nel sopraffare, anzi nel disfare la parte contraria, ardendo case, dichiarando ribelli, e confiscando i beni dei vinti. Non si trattava più di Guelfi e di Ghibellini, perchè questi ultimi non si erano più rifatti dopo la rotta di Benevento e il crudele supplizio di Corradino, e solo i Guelfi signoreggiavano, come quegli che avevano il favore del papa e de' reali di Napoli, tenendo gli altri sotto gravi pesi, per modo che non ardivano di alzar la fronte; tanto più che i loro capi erano dichiarati ribelli. Ma i Guelfi stessi erano discordi tra loro, e si erano partiti, come diceva, in Bianchi e Neri, riscaldata l'una parte e l'altra dall'ambizione de' grandi e specialmente de' Cerchi e de' Donati; onde la città stessa era non di rado campo di battaglia; i palazzi si munivano e si assaltavano come fortezze; le vie si asserragliavano; esempj di crudeltà e di ferocia erano frequenti; un continuo mutar di leggi e di ufficj: e Firenze poteva bene agguagliarsi, come appunto l'agguagliò Dante, a un'inferma, che non trova riposo sopra un letto di piume, e fa schermo al dolore dando volta di continuo.
Quando le cose riducevansi agli estremi, che proprio non si poteva andar più avanti, allora si cercavano rimedj. Prima il papa mandò il cardinale di Acquasparta, che, giunto a Firenze, chiese balía di riformare la terra, di rappacificare le parti e accumunare gli uffizj: ma i Cerchi se ne risero, ed egli partì lasciando la città interdetta. Poi vi mandò Carlo di Valois, detto Senzaterra: fu gran disputa se dovesse riceversi; ricevuto, gli si diè balía di riformare la città con pace e senza disordine; ed egli, dopo averlo giurato, con la gente francese che aveva seco corse la terra per sua; e nacque uno dei più terribili tumulti che mai si udissero, per cui seguirono morti ed esilj, tra' quali quello di Dante.[14] Durissima prova di questa verità: che quando un popolo ha bisogno di ricorrere a protezione e ajuto di stranieri, questi gliela concedono solo per aver predominio e per avvantaggiarsene, a scapito della dignità e della libertà di chi li chiama o gli accetta: durissima prova, che Firenze fece tante e poi tante volte senza impararne mai nulla.
Dopo la partenza di Carlo Senzaterra si provò ad eleggere con piena balía un ufficiale forestiero col titolo di Bargello; e chiamato a ciò M. Fulcieri da Calvoli, uomo feroce e crudele, questi manomise spietatamente la vita e le facoltà dei più nobili cittadini, e disertò la città per modo che Dante, nel XIV del Purgatorio, là dove Guido del Duca profetizza a M. Ranieri da Calvoli, zio di questo Fulcieri, gli fa dire:
Io veggo tuo nipote, che diventa
Cacciator di quei lupi in sulla riva
Del fiero fiume, e tutti gli sgomenta.
Vende la carne loro essendo viva;
Poscia gli ancide come antica belva;
Molti di vita, e sè di pregio priva.
Sanguinoso esce della trista selva:
Lasciala tal, che di qui a mill'anni,
Nello stato primajo non si rinselva;
dove i lupi s'intende per i Fiorentini, e il fiero fiume per l'Arno.
E veramente Firenze non si riebbe per molto tempo, e sempre mutava ordini e modi; sempre travagliata di dentro dalle discordie, seguite da uccisioni e da arsioni; e di fuori da' fuorusciti e dai signori capi dei Ghibellini; prima da Uguccione della Faggiuola, e poi più terribilmente da Castruccio; talchè doveva sempre stare a discrezione del papa o dei reali di Napoli, che la dissanguavano per mezzo dei loro vicarj.
Solo nel 1322 poterono i Fiorentini liberarsi dalla signoría del re Roberto, durata molti anni; ma tanti furono i travagli che ebbe poscia la repubblica, massimamente per le armi di Castruccio, il quale corse e ricorse più volte il loro contado, ardendo castella, disfacendo ponti e strade, e devastando e mettendo a saccomanno ogni cosa, rafforzato ancora dalle armi del vescovo De' Tarlati di Arezzo; e a tale estremo venne per la rotta di Altopascio, la quale condusse Castruccio fin presso Firenze, attorno alle cui mura fece correre un palio a scherno dei Fiorentini; che questi non ebbero altro scampo da tanta furia, se non ricorrere da capo al re Roberto, il quale gli mandò per signore di Firenze Carlo duca di Calabria suo figliuolo, la cui entrata abbiamo veduto sul principio di questo racconto.
Resta ora che io faccia far conoscenza al lettore coi tre personaggi nominati in sul fine del precedente capitolo.
Il vecchietto vestito di nero, osservato da quei due che stavano a veder l'entrata del duca sulla porta di Badía, era di fatto Cecco d'Ascoli, famoso scienziato e astrologo, e in voce di mago e di negromante, come erano tenuti in simile concetto a quei tempi tutti coloro che coltivavano la filosofía e le scienze. Il suo vero nome fu Francesco, figliuolo di maestro Simone Stabili da Ascoli, nato nel 1257, o in quel torno: si diè nella primissima età a coltivare con ardore le lettere, le matematiche e tutte le arti, come allor si diceva, del trivio e del quadrivio, tantochè di bonissima ora acquistò fama di solenne scienziato, e fu chiamato a insegnare astrología nello studio di Bologna, dove stette molti anni, esercitando il suo nobile ufficio con gran lode e riputazione. Il gesuita Appiani d'Ascoli, apologista di questo sventurato, sparge sul conto di lui varie favole, come quella che si fosse profferto di condurre il mare Adriatico sotto le mura di Ascoli; che fosse medico di papa Giovanni XXII, e che perciò si trattenesse parecchio tempo alla corte d'Avignone; che avesse per suo nemico personale in Firenze Guido Cavalcanti; e che, tornato d'Avignone, facesse amicizia con Dante: cose tutte chiarite false dai fatti e dalla cronologia. Molti parlano di Cecco d'Ascoli come di uomo vano e presuntuoso, ma privo di vera scienza; altri invece lo rappresentano per uomo di gran sapere, e che a forza di studio e di osservazione, fosse giunto a scoprire de' nuovi fatti nella scienza astronomica e nella meteorología, i quali poi furono accettati dalla scienza per verità irrepugnabili; e tra questi il Libri nella sua Storia delle Scienze matematiche conchiude parlando di lui: «sarebbe tempo che gli Italiani ristorassero la memoria d'un uomo, che ha ben altri pregj che quello d'essere una vittima illustre della Inquisizione.»
Compose nella sua gioventù[15] un poema in lingua italiana da esso intitolato l'Acerba, quasi che fosse come un acervo, e indigesta raccolta di cose scientifiche; o che volesse accennare con quel modesto titolo la imperfezione del suo lavoro, chiamando tal opera del suo ingegno, non matura e dolce, ma imperfetta ed acerba[16]; ed infatti quest'opera trovasi in alcuni testi a penna col titolo: Liber acerbae aetatis. L'Acerba è divisa in cinque libri, che in alcune edizioni sono ridotti a quattro: è in terza rima, con le rime concatenate in modo diverso dalla terza rima di Dante; ed è assai rozza e strana nella forma, benchè qua e là bellezze vere rifulgano. Frequenti sono le riprensioni che Cecco ivi fa alle dottrine di Dante; e contro Dante inveisce fieramente verso il fine del suo lavoro; comecchè non paja improbabile che Cecco avesse commercio di lettere con lui, secondo che può argomentarsi da un luogo dell'Acerba stessa, il quale dice: «Ma qui mi scrisse dubitando Dante ec.». Ad un altro celebre fiorentino si mostrò avverso fieramente Cecco d'Ascoli, dico a Guido Cavalcanti, amico di Dante, sommo filosofo allora, e nobile poeta, scrivendo un lungo commento alla canzone di lui:
Donna mi prega, perch'io voglia dire,
D'un accidente, che sovente è fero,
e combattendo virilmente le sue dottrine filosofiche; contro al qual commento di Cecco, fece altro commento maestro Dino del Garbo, pigliando risolutamente a difendere quelle dottrine che Cecco aveva combattute.
Mentre questi era nello studio di Bologna, vi lesse negli ultimi anni la Sfera del Sacrobosco con un commento fattovi da lui, e fioritissima era la sua scuola: tal commento parve all'Inquisizione che peccasse contro la dottrina cattolica del libero arbitrio, e fu comandato a Cecco che cessasse di spiegarlo; ma, non rimanendosene, fu accusato, processato, e condannato a gravissima sentenza; e dovè giurare che mai più avrebbe insegnato tali dottrine. Ciò avvenne nel 1324;[17] e da quel tempo, non trovandosi più a suo agio in Bologna, vagò per diverse città, e all'ultimo se ne venne a Firenze, per astrologo forse, e forse anche per medico, alla corte del duca di Calabria.
I due personaggi di sulla porta di Badía, l'uno era frate Accorso da Firenze, inquisitore dell'eretica pravità nella provincia di Toscana; e l'altro era maestro Dino del Garbo. Questi fu medico eccellentissimo del suo tempo. Datosi a studiare in Bologna, valse tanto nelle arti liberali, nella filosofía e nella dottrina di medicina che, di volontà di tutto lo studio, fu promosso alla cattedra, dove insegnò molto tempo con fama grandissima. La invidia per altro fece ben presto sue arti verso di lui; nè poco gli si adoprò contro Cecco d'Ascoli, che leggeva allora appunto a Bologna; il perchè Dino fu costretto partirsene, e andò a leggere a Siena; nè a Bologna più volle tornare, con tutto che i Bolognesi solennemente lo richiamassero.
Fece parecchie opere di gran lode, che lo resero famoso in tutta l'Italia e fuori: tra le altre vuolsi notare più specialmente il commento latino sopra la famosa canzone di Guido Cavalcanti, la quale dei movimenti, cagioni, costumi e natura di amore, con ragioni, dice Filippo Villani, filosofiche e morali sì cautamente e mirabilmente dimostra; contro la qual canzone aveva, come dissi poco fa, scritto acerbamente Cecco d'Ascoli.
Dino, già vecchio, era tornato da qualche anno a Firenze, per finirvi quel tanto di vita che poteva tuttora restargli.
Adesso continuiamo il racconto: che oramai n'è il tempo.