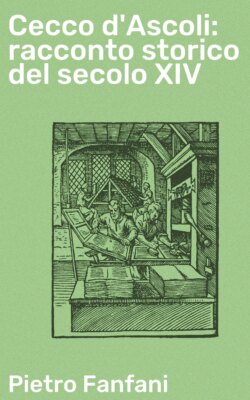Читать книгу Cecco d'Ascoli: racconto storico del secolo XIV - Fanfani Pietro - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO I. L'ENTRATA DEL DUCA DI CALABRIA IN FIRENZE.
ОглавлениеIndice
Il dì 26 di luglio del 1326[10] tutta Firenze era in festa: le torri e le logge de' grandi, le residenze delle arti maggiori e minori, i sestieri e i nobili palagj, sventolavano di pennoni, di gonfaloni e di bandiere; le vie erano gremíte di popolo, che si accalcava specialmente intorno al palagio del podestà; e molta gente avviavasi verso porta S. Gallo, la cui torre era stata edificata di fresco con disegno di Arnolfo di Cambio, ed era tutta adorna delle bandiere di parte guelfa, del popolo fiorentino, della repubblica, del papa e del re Roberto di Napoli. Doveva entrare solennemente in città Carlo duca di Calabria, figliuolo di esso re Roberto. A costui Firenze aveva data la signoría per dieci anni, con provvisione di 200,000 fiorini d'oro l'anno; ed egli già fino dal maggio precedente vi aveva mandato in suo nome, con 400 cavalli, quel Gualtieri di Brienne duca d'Atene, che in questo medesimo giorno 26 di luglio, diciassette anni dopo, fu cacciato a furia di popolo da Firenze, di cui si era fatto con male arti signore. Il gonfaloniere di giustizia, che era Geri Soderini, con tutti i priori; il vescovo, il podestà ed i capitani del popolo, erano iti ad aspettarlo fuori di porta, sotto un nobile padiglione di sciámito rosso seminato di gigli. Messi andavano e venivano, per vedere se nulla si scoprisse o si udisse: ogni picciol romore che veniva da quella parte, facea volgere in là tutti i volti, e tosto udivasi da mille bocche: il duca, il duca. Finalmente, in sul mezzogiorno, un lontano squillar di trombe annunziò che il duca arrivava davvero. Tre fumate di sulla torre della porta ne diedero avviso alla città, e tutte le campane cominciarono a sonare a distesa: il popolo si versava a torrenti per le vie dove il signore doveva passare, mal contenuto dai provvigionati del duca d'Atene, e dai fanti del podestà: ed era un continuo ondeggiare di turba affollatissima; l'uno con le mani sulle spalle all'altro, rizzarsi in punta di piedi ansiosi di vedere se spuntava nulla a capo delle vie; bambini levati in alto dai babbi e dalle mamme; spinte, gomitate, strida, motteggi e scroscj di risa da varie parti, che alquanto scemavano la noja dell'aspettare. Intanto, arrivato il duca alla porta, il vescovo prima di tutti fece riverenza a lui ed al legato del papa che cavalcavagli a destra: poi andarono il gonfaloniere e i priori, presentandogli le chiavi della città su un bacile d'argento, le quali furono da lui rifiutate con atto urbanissimo; ma non restò per questo che non entrasse in Firenze armato di tutte armi, e con la lancia in pugno, con quel piglio ed atti che sogliono i conquistatori e padroni.
Firenze non aveva mai veduto sì ricca, e sì nobile cavalcata. Dinanzi a tutti andavano il duca e il legato del papa: il duca aveva sopransegne reali, e rispondeva con lievi cenni del capo, e con sorriso lievissimo, agli evviva e alla letizia del popolo. Seguitava appresso al duca Maria di Valois, sua moglie, con sei damigelle, l'una più vaga dell'altra, ricchissimamente vestite; e poscia il gonfaloniere di giustizia con tutti i priori, i collegj, i capitani di parte guelfa; e dopo essi tutti i principi e baroni di sua compagnía, tra i quali eran principali M. Giovanni fratello del re Roberto, il Prenze della Morea, M. Guglielmo Lostendardo, monsig. Giuffrè di Gioinville, il Despoto di Romania, ed altri infiniti signori e cavalieri francesi, provenzali, catalani e napoletani, che furono da millecinquecento, cento dei quali erano cavalieri a spron d'oro: bella e fioritissima gente, le cui armi ed arnesi, racconta Giovanni Villani che furon ben millecinquecento some di muli a campanelli: cosa di gran maraviglia e stupore.
E quel luccicar d'armi e di gioje; quello splendore di vestimenti e di arredi; il grazioso salutare della duchessa e delle sue damigelle; quel vedere tanti segnalati signori e cavalieri raccolti insieme, avevano per modo inebbriato i Fiorentini, che in mille guise significavano la loro letizia, e non restavano di applaudire. Come il duca fu giunto sulla piazza di San Giovanni, entrò nel tempio, splendidamente addobbato, dove era a riceverlo la chericía della cattedrale in abiti solenni. Fatta breve preghiera ed assai ricca offerta, uscì di chiesa per la porta di mezzo, e volle fermarsi un poco ad ammirare la nuova fabbrica di Santa Reparata[11], che già era molto innanzi: guardò con molta compiacenza la graziosa loggia del Guardamorto[12]; e parve fargli mirabile effetto il corso degli Adimari[13] con tutti quei palagj, e torri, e logge, adorne di festoni, di ghirlande e di bandiere.
Doveva egli risedere nel palagio del Podestà da Badía: e quivi la gente era accalcata su per le logge, per le scalee, sui tetti, per tutto; e non si può dire a parole il clamore di voci e il batter palma a palma che fu fatto quando il signore sboccò sulla piazza.
— Viva il duca e la duchessa.
— Viva la chiesa e parte guelfa.
— Muoja Castruccio e i ghibellini.
— Viva il re Roberto.
— Viva il popolo, vivano i ghibellini, gridò una voce.
E più di mille voci: No, viva il signore; e furono addosso al mal capitato gridator ghibellino, che ne andò mezzo pesto ed infranto.
In sulla porta di Badía stavano a mirar lo spettacolo un frate Minore ed un vecchio di alta statura, che all'abito si conosceva per medico; niuno dei due pareva compreso da quella gioja di cui il popolo dava tanti segni; e udendo tante grida, e vedendo il caso del povero ghibellino, disse il vecchio con sorriso di scherno:
— Come ben disse il nostro Dante che il volgo grida spesso: Viva la sua morte e muoja la sua vita! Avete sentito? Viva il signore! E questa città si regge a popolo! Viva il signore!... Si vede che questi sciagurati non lo sanno che cosa sono i signori: eppure son sempre aperte le piaghe che lasciò sulla povera Firenze Carlo Senzaterra. Oh! benedetto il mio Dante, che sì potentemente lo folgorò.
— Eh, maestro, pur troppo dite vero; e Dio voglia che questo signore qui, non faccia anche peggio di quell'altro a Firenze, tanto sinistro aspetto mi par ch'egli abbia!
In questo mezzo il duca e la duchessa erano già montati in palagio, e già i cavalieri si avviavano verso le case loro assegnate, quando il frate Minore:
— Oimè! maestro, guardate, se Dio vi ajuti, quel vecchietto tutto vestito di nero su quel cavallo leardo. E' mi par tutto Cecco d'Ascoli, processato già per eretico e per negromante a Bologna.
— Come! Il detrattore del nostro divino Dante, e di messer Guido Cavalcanti? Colui che presume di esser fisico, filosofo, astrologo, poeta, ogni cosa? Ed ha fronte tanto sicura che osi di venire a Firenze? Non è possibile, frate Accorso: guardate meglio, accertatevene; io sono di vista troppo inferma.
Ma intanto i cavalieri si erano già allontanati: e però i due personaggi, affine di accertarsene, la diedero per un chiassuolo, e riuscirono appunto alle case dei Macci là da Orsammichele, dove tutti dovevano far capo; nè prima si furono un poco appressati, che il frate riconobbe Cecco, e non potè tenersi che non dicesse ad alta voce:
— Ah pateríno dannato! è lui daverro: è il negromante! E il duca viene accompagnato da certa gente? Maestro, lo dicevo che di questo duca ne speravo poco bene?
— Ed anche mi pare che sia un oltraggio a Firenze il venirci accompagnato da un eretico, che ha, per di più, vituperato i due più illustri figliuoli di questa patria.
— Maestro — disse un popolano accostandosi — che dite voi di scomunicato e di negromante?
— Nol vedi — soggiunse il frate — quel vecchietto nero che smonta or da cavallo? È un eretico, è un negromante.
E intanto la gente faceva capannello accosto ai due che parlavano.
— Sarebbe da cacciargli a furore di popolo.
— È Cecco Diascolo — (il popolo chiamava così Cecco) ripigliò il maestro; — il beffeggiatore di Firenze e di Dante; non si vorrebbe comportare che la nostra città fosse contaminata da gente sì obbrobriosa.
— Cecco diascolo? muora, muora, — cominciarono tutti a gridare: e gli avrebbero messo le mani addosso, se Cecco, veduta la mala parata, non si fosse rifugiato tosto in casa, la quale era guardata dai provvigionati del duca di Atene.
Smontati che furono tutti, la gente cominciò a dileguarsi; ed a poco a poco la città aveva ripreso il suo aspetto grave, e la sua quiete. — Ma perchè si faceva tanta festa da un popolo libero alla venuta di un novello signore? E chi erano quel frate e quel maestro, i quali aizzavano il popolo a levar rumore contro Cecco d'Ascoli? Il lettore mi segua, e lo saprà in quest'altro capitolo.