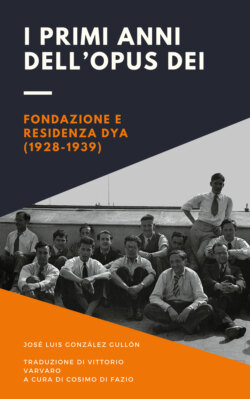Читать книгу I primi anni dell'Opus Dei - José Luis González Gullón - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una sede improvvisata
ОглавлениеNel primo semestre del 1933 l’apertura dell’accademia fu preceduta da alcuni episodi. Infatti si incorporarono all’Opera José María González Barredo, Jenaro Lázaro, Manuel Sainz de los Terreros e, nel semestre successivo, Ricardo Fernández Vallespín. I primi tre erano giovani professionisti, su cui don José María contava perché collaborassero alle attività di direzione o di gestione dell’accademia. Inoltre, l’appartamento degli Escrivá Albás, in calle Martínez Campos, si respirava un ambiente gradevole, familiare, che favorì la formazione degli universitari che si avvicinavano all’Opera.
José María González Barredo aveva conosciuto don José María sei anni prima[241]. A quell’epoca assisteva ogni giorno alla Messa nella cappella del Patronato de Enfermos, prima delle lezioni nella Facoltà di Scienze Chimiche della Centrale. Nel marzo del 1931 il cappellano gli aveva chiesto di pregare per una intenzione particolare. Come annotò Escrivá, «la mia intenzione era che lui, così devoto, fosse scelto da Dio come apostolo nella sua Opera. Già altre volte, vedendolo dal mio confessionale, avevo chiesto la stessa cosa al suo Angelo custode»[242]. Poi però le vicende avevano preso un’altra piega, in quanto Escrivá si era trasferito al Patronato di Santa Isabel e González Barredo aveva ottenuto una cattedra alla Scuola Secondaria di Linares, vicino Jaén.
Nel 1932 il giovane laureato in Chimica si fermava durante le vacanze a Madrid per redigere la tesi dottorale nell’Istituto di Fisica e Chimica. Disponeva di un finanziamento della Fondazione Rockefeller. Inoltre, riusciva a conciliare questo lavoro con l’apprendimento del tedesco nell’ “Hogar Santa María”, in calle Martín de los Heros[243]. Un giorno attorno al Natale di quell’anno don José María lo incontrò per strada. Il sacerdote propose al dottorando un appuntamento per quello stesso pomeriggio. Finito il suo lavoro in laboratorio, González Barredo vi si recò. Dopo i preamboli di saluti, Escrivá gli parlò del messaggio di santità nella professione, proprio dell’Opera, mettendo l’accento sul suo carattere soprannaturale. José María, che da anni si domandava che strada doveva intraprendere nella sua vita —l’apertural’unica cosa chiara che aveva era la sua vocazione scientifica—, ricordava la sua risposta: «Fu tale l’impressione che mi produsse il Padre, e nello stesso tempo la tranquillità e la pace, che mi decisi a chiedere l’ammissione all’Opera immediatamente e senza alcun tipo di dubbio»[244]. Don José María gli raccomandò di concedersi un po’ di tempo per meditare davanti a Dio questa decisione e per consultare il suo direttore spirituale. Poche settimane dopo, l’11 febbraio 1933, González Barredo disse a Escrivá che aveva deciso. Poi ritornò a Linares. Da lì mantenne un contatto epistolare con il fondatore e qualche volta Isidoro Zorzano gli fece visita[245].
Abbiamo visto che Jenaro Lázaro aveva conosciuto don José María nelle corsie dell’Ospedale Generale alla fine del 1931. Lavorava come dipendente delle ferrovie, ma allo stesso tempo si dedicava alla scultura religiosa, disponendo di un piccolo laboratorio personale. Un po’ per volta le sue opere incontrarono apprezzamenti. Man mano che riceveva altre commesse si appassionava, pensando alla possibilità di dedicarsi professionalmente all’arte. Aveva trentun anni quando, il 10 febbraio 1933, chiese l’ammissione all’Opera.
Pepe Romeo, assente per malattia dall’estate dell’anno precedente, ritornò a Madrid nel marzo del 1933 e s’iscrisse come studente esterno di Architettura. Per recuperare parte del tempo perduto, seguì delle lezioni private insieme a un amico, Manuel Ambrós, «di due materie del terzo e quarto anno —Resistenza dei materiali e Calcolo delle strutture— particolarmente impegnative»[246]. Le lezioni, che si tenevano in casa di Romeo, erano impartite da Ricardo Fernández Vallespín, uno dei migliori studenti del penultimo anno di Architettura[247]; queste lezioni gli consentivano di collaborare al sostegno della sua famiglia. Il pomeriggio del 14 maggio —ricordava Fernández Vallespín—, «mentre io stavo svolgendo su una piccola lavagna il tema della lezione, si aprì la porta ed entrò il Padre»[248]. Si presentarono, e il sacerdote invitò il professore a incontrarlo un giorno a casa sua; poi Escrivá si congedò perché non voleva disturbare la lezione.
Il 29 maggio Ricardo andò a casa di don José María in calle Martínez Campos. Dialogarono a lungo sulla vita cristiana. «Prima di congedarmi il Padre si alzò, andò davanti a una libreria, prese un libro che aveva usato e nella prima pagina scrisse, come dedica, queste tre frasi che poi inserì con un commento nel suo libro Consideraciones Espirituales, che io poi spero di aver adempiuto: + Madrid −29−V−33. Cerca Cristo. Trova Cristo. Ama Cristo»[249]. Il libro era la Historia de la Sagrada Pasión, del gesuita Luis de la Palma. Ricardo annotò in un diario personale l’impressione che gli provocò: «una nuova conoscenza che può influire non poco nella mia vita; ho fatto amicizia con il Padre José María, un giovane Apostolo entusiasta»[250].
Durante l’estate Fernández Vallespín andò in vacanza a Ávila con degli amici. Al ritorno, ebbe alcuni colloqui sporadici con Escrivá fino al 2 novembre, giorno in cui la conversazione in calle Martínez Campos fu più lunga. Ricorda Ricardo: «capii chiaramente che l’Opera che Dio Nostro Signore voleva che si realizzasse sulla terra non mirava a risolvere il problema della Spagna in quel tempo di persecuzioni; che la voleva per tutto il mondo e per sempre; che un gruppo di cristiani, decisi a farsi inchiodare sulla croce con Cristo, potevano ricristianizzare il mondo, portando l’amore di Dio a tutte le creature nell’esercizio delle loro attività in mezzo al mondo»[251]. Escrivá non lo invitò immediatamente a propagare questo ideale. Però Fernández Vallespín disse: «“Io voglio far parte di questo”. Scrisse così perché neppure sapeva come si chiamava “questo”, cioè l’Opera di Dio. Il Padre mi guardò e mi disse di andare per tre giorni a fare la comunione, chiedendo allo Spirito Santo di vedere con chiarezza se ero realmente deciso. Io ero felice, non pensavo a ciò che avrei dovuto lasciare, ma al fatto che avevo trovato un tesoro. E così sono andato, per la prima volta in vita mia, a fare la comunione per tre giorni di seguito; poi sono andato a confermare la mia richiesta, senza dubitare che era Dio a chiedermelo e io ero molto contento che me lo chiedesse»[252].
Attraverso Pepe Romeo, José María Escrivá conobbe anche Manuel Sainz de los Terreros[253]. Manolo, come lo chiamavano gli amici, aveva terminato gli studi di Ingegneria civile nel gennaio di quell’anno 1933. Mentre cercava un posto di lavoro, dedicò il tempo disponibile ad attività di volontariato, assistendo alcune famiglie povere. Un giorno del mese di maggio andò a servire il pranzo ad alcuni poveri di Tetuán de las Victorias, insieme a suo fratello Luis e a due amici, Pedro Antonio Alarcón e Pepe Romeo. Il pasto era stato pagato con una colletta fra tutti. Alla fine, mentre ritornavano in metropolitana, «Romeo mi parlò di... una cosa vaga, di un’Accademia, e mi invitò a parlare con D. José Mª Escrivá»[254]. Qualche giorno dopo, il 14 giugno, «attorno alle 7½ sono andato molto tranquillo in calle Martínez Campos 4, a vedere “questo Sr. Presbitero che voleva parlarmi dell’Accademia”»[255]. Durante il colloquio, Manolo spalancò il suo cuore al sacerdote. Notando che era inquieto per una eventuale chiamata di Dio, José María Escrivá gli propose di fare un triduo allo Spirito Santo. Quando lo finì ritornò in calle Martínez Campos e chiese al sacerdote di far parte dell’Opera.
La casa presa in affitto dagli Escrivá in calle Martínez Campos ebbe un ruolo fondamentale come luogo di incontri per i membri dell’Opera e gli amici. A quanto pare, la prima riunione in quell’appartamento si tenne il 19 marzo, giorno dell’onomastico di don José María. Fecero una merenda con dei pasticcini regalati dalla madre di don Norberto[256]. Da quel giorno in poi alcuni universitari, di pomeriggio, andavano a conversare, a ricevere formazione cristiana e anche a fare merenda. Santiago Escrivá, che aveva quattordici anni, vide sfilare «molti ragazzi trattati da José María. Io andavo a cercare biscotti e frittelle per le tazze di cioccolata che preparava Carmen. Anche mia madre collaborava con piacere. I ragazzi impazzivano per la cioccolata»[257]. Qualche volta Santiago si lamentava perché era rimasto senza merenda e diceva: «I ragazzi di José María si sono mangiato tutto»[258].
Gli incontri erano informali riunioni di amici. Ricorda González Barredo: «parlavamo di qualsiasi cosa e cantavamo. Il Padre aveva sempre qualcosa da darci; portava caramelle o altro per fare merenda»[259]. Lo scopo di queste riunioni era chiaro: creare un clima piacevole in un rapporto di amicizia. Per Jiménez Vargas, «qualcuno avrebbe potuto pensare che era semplicemente un momento di conversazione, ma ben presto si sarebbe accorto che il Padre lo considerava una necessità, perché era un modo per farci comprendere che cos’è la vita di famiglia»[260]. La maggior parte di loro erano universitari. Ma c’erano anche professionisti di varia provenienza, come lo scultore Jenaro Lázaro, il maestro Ramón Franquelo, il giornalista Julián Cortés−Cavanillas o un medico di trentatré anni, Rafael Roldán, che lavorava a Madrid con Jiménez Díaz.
Nel marzo del 1933 José María Escrivá spiegò ai membri dell’Opera un piano o programma di pratiche o norme di pietà cristiana, perché ognuno lo praticasse quotidianamente[261]. Il “piano di vita”, come lo chiamavano diversi autori di spiritualità[262], li avrebbe aiutati nel loro impegno personale per fondere, «in unità di vita, l’ascetica propria del cristiano con l’esercizio della professione»[263]. Questo piano includeva alcune pratiche di vita spirituale radicate nella tradizione cristiana[264]: offerta delle azioni appena alzati, un momento di orazione mentale, Messa e Comunione, visita al Santissimo, lettura di un brano del Vangelo e di un libro spirituale, recita del Rosario, dell’Angelus e delle preci dell’Opera[265], ed esami di coscienza[266]. Il piano di vita doveva essere completato nella giornata, tenendo conto degli obblighi professionali o sociali di ciascuno. Per questo richiedeva agli universitari e ai giovani professionisti un ordine nell’orario, in modo che fosse compatibile con il loro lavoro[267].
Anche alcune donne andavano a trovarlo per uno scambio di idee sulla vita cristiana. Un giorno del mese di maggio, per consiglio della sorella María Ignacia, Benilde García si presentò senza preavviso in calle Martínez Campos. Escrivá la ricevette e «centrò subito il tema, che fu esclusivamente spirituale. Più o meno mi disse che potevo far parte dell’Opera e che María Ignacia gli aveva già spiegato la situazione nella quale mi trovavo. Mi disse anche che potevo già alimentare una vita spirituale più intensa, indicandomi il modo. Ricordo un particolare che mi sembrò assai significativo: che portassi le mie figlie, con tutta libertà, se a loro faceva piacere, a fare la Visita al Santissimo tutti i pomeriggi»[268]. Qualcosa di simile accadde con l’altra sorella, Braulia, che andò a casa di don José María per insistenza di María Ignacia[269].
Invece gli incontri del lunedì con i sacerdoti proseguirono in casa di Norberto Rodríguez. A Martínez Campos andavano soltanto quelli più conosciuti da José María, Come Norberto o Lino[270]. Nel mese di giugno un altro sacerdote parlò a José María Escrivá del suo desiderio di formarsi nello spirito dell’Opera. Si chiamava Blas Romero ed era il cappellano della parrocchia di Santa Bárbara[271].
Alla fine del mese, Escrivá avviò a casa sua un’attività spirituale che poi diventò consuetudine quotidiana. Prima che i ragazzi ritornassero alle loro case, prendeva un messale grande, da altare, e commentava il passo del Vangelo che era stato letto nella Messa di quel giorno. Nel mese di luglio mise per iscritto questa consuetudine: «Da qualche giorno tutti i pomeriggi alle otto e mezzo leggo il santo Vangelo della Messa e lo commento brevemente davanti a chi è presente in casa, dell’Opera o no»[272].
Inoltre consegnò agli altri le sue annotazioni, sia quelle già pubblicate al ciclostile —Santo Rosario e Consideraciones espirituales—, sia altri fogli che faceva stampare, distribuendole fra le persone che conosceva. Il suo amico Pedro Cantero, che frequentava l’appartamento di calle Martínez Campos, ricordava: «certe volte, dopo una conversazione, per aiutare la mia orazione personale, leggevo alcuni pensieri scritti in piccoli fogli. Dovevano essere sintesi di conversazioni tenute ai ragazzi o punti di meditazione»[273].
Alla fine di giugno José María Escrivá decise di preparare un secondo fascicolo di Consideraciones espirituales. Mise insieme 87 testi, tratti dalle sue annotazioni negli Apuntes íntimos e li stampò col ciclostile. Uniti ai 246 della prima edizione di Consideraciones, sommavano in tutto 333 massime spirituali —era un numero simbolico scelto in onore della Trinità di Dio— che le persone dirette spiritualmente potevano meditare[274]. Il 22 luglio lo avevano già ricevuto alcuni membri dell’Opera, affinché ne facessero buon uso durante il periodo estivo[275].
Torna all'indice
Prossimo capitolo
[1] Cfr. Shlomo Ben−Ami, La dictadura de Primo de Rivera. 1923−1930, Planeta, Barcelona 1983; e Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria, 1923−1930, Alianza Editorial, Madrid 2005.
[2] Cfr. Genoveva García Queipo de Llano, Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Alianza Editorial, Madrid 1988, pp. 534−555.
[3] Cfr. Anuario Estadístico de España. Año XXVI. 1951, “Principales actividades de la vida española en la primera mitad del siglo XX. Síntesis estadística”, Madrid, 1952, p. 10; Censo de la población de España según el empadronamiento, tomo I, Talleres del Instituto Geográfico y Catastral, Madrid 1932, pp. LXXII−LXXIII. Per età lavorativa s’intende quella delle persone che hanno un’età compresa tra i 15 e i 69 anni.
[4] Cfr. Madrid. Información sobre la ciudad, Municipio di Madrid, Madrid 1929, p. 28. Lo sviluppo e la trasformazione di Madrid, contemporanee alla crisi economica, aiutano a capire il complesso mondo del lavoro e del sindacalismo operaio di quegli anni (cfr. Santos Juliá Díaz, Madrid, 1931−1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo XXI, Madrid 1984).
[5] Concretamente, 32.607 sacerdoti secolari e 16.447 religiosi. Le religiose erano 59.966 (cfr. Ministerio de Trabajo, Censo de población de 1930, tomo II, “Resúmenes generales de la población”, Madrid 1930, pp. 8−9).
[6] Cfr. José Luis González Gullón, “El clero de Madrid. Demografía y distribución “, in Santiago Aurell — Pablo Pérez López (eds.), Católicos entre dos guerras. La historia religiosa en España en los años 20 y 30, Biblioteca Nueva, Madrid 2006, pp. 255−282.
[7] L’Università Centrale era l’erede dell’Università Complutense, fondata dal cardinal Cisneros alla fine del XV secolo ad Alcalá de Henares. A metà del XVIII secolo la Complutense si smembrò a causa della diminuzione degli introiti e alla perdita di ideali. Nel 1836 si trasferì a Madrid. Due decenni dopo ricevette il titolo di Università Centrale. Nel 1970 assunse il nome di Università Complutense di Madrid. In seguito, nel 1977, fu creata l’attuale Università di Alcalá, che ha sede ad Alcalá de Henares. Cfr. Joaquín de Entrambasaguas, Grandeza y decadencia de la Universidad Complutense, Editorial Complutense, Madrid 1996.
[8] La legge fu redatta dal ministro di Fomento, Claudio Moyano Samaniego, e ratificata dalla regina Isabella II il 9 settembre 1857. Rimase in vigore per quasi un secolo, fino al 1943. I programmi di studio e i modi di accesso all’Università furono parzialmente modificati durante la Seconda Repubblica (cfr. Universidad de Madrid. Libro del estudiante. 1934−1935, Madrid 1934, p. 143).
[9] La Sezione di Pedagogia della Facoltà di Filosofia e Lettere fu creata nel gennaio del 1932, sostituendo in tal modo la Scuola Superiore di Magistero. Nel gennaio del 1933 la Facoltà di Filosofia e Lettere si traferì in un nuovo edificio appositamente costruito nella Città Universitaria, ad ovest di Madrid.
[10] Cfr. Pablo Campos Calvo−Sotelo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid. Memoria viva de un campus trascendental, Editorial Complutense, Madrid 2004, p. 14.
[11] Benché varie facoltà avessero la loro nuova sede in avanzato stato di costruzione, prima della guerra civile nella Città Universitaria si poté inaugurare solo la sede della Facoltà di Filosofia e Lettere. Nel campus erano aperte anche la “Fundación del Amo”, la Casa de Velázquez e alcuni impianti sportivi. Cfr. Pilar Chías Navarro, La Ciudad universitaria de Madrid. Génesis y realización, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid 1986, p. 143.
[12] Cfr. Universidad de Madrid. Libro del estudiante. 1934−1935, Madrid 1934, p. 35.
[13] Ringrazio il Prof. Álvaro Ferrary dell’Università di Navarra per i suggerimenti da lui fatti su questo paragrafo.
[14] Cfr. Vicente Cacho Viu, Los intelectuales y la política. Perfil público de Ortega y Gasset, Biblioteca Nueva, Madrid 2000, p. 47.
[15] Cfr. Prólogo de Vicente Palacio Atard a Mª Dolores Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea, CSIC, Madrid 1981, p. XXV. Sanz del Río morì nel 1869 e Giner de los Ríos nel 1915.
[16] L’inizio e il primo sviluppo della ILE si trovano in Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria (1860−1881), Rialp, Madrid 1962. Il libro è stato rieditato da Octavio Ruiz−Manjón in Fundación Albéniz — Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid 2010.
[17] Cfr. Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, o.c., p. 453.
[18] L’influenza della JAE sull’Università spagnola fu enorme. Nel caso di Madrid, «dei 125 professori ordinari della Università Centrale in attività nel 1935, il 75,2 per cento (94) avevano in qualche modo un vincolo con la JAE, o per aver goduto di una borsa di studio all’estero o per aver fatto parte degli istituti e dei laboratori finanziati dalla JAE.»(Luis Enrique Otero Carvajal, “La Junta para Ampliación de Estudios y la Universidad Central”, in Eduardo González Calleja — Álvaro Ribagorda (eds.), La Universidad Central durante la Segunda República. Las Ciencias Humanas y Sociales y la vida universitaria, Dykinson, Madrid 2013, p. 47).
[19] Cfr. Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes. Los residentes, CSIC−Sodiedad Estatal de Acción Social — Amigos de la Residencia de Estudiantes, Madrid 2011, pp. 165−216.
[20] Cfr. Encarnación Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto−Escuela, Sección Retiro de Madrid, Biblioteca Nueva, Madrid 2009, p. 239.
[21] Cfr. Gonzalo Redondo, “El 2 de octubre de 1928 en el contexto de la historia cultural contemporánea”, Anuario de Historia de la Iglesia XI (2002) 727.
[22] Le tre “generazioni” sono strettamente connesse per le idee di nazionalismo e di modernità. Cfr. José Carlos Mainer, Historia de la Literatura Española, vol. 6, “Modernidad y nazionalismo (1900−1939)”, Crítica, Barcelona 2010.
[23] Cfr. Vicente Cacho Viu, Los intelectuales y la política. Perfil público de Ortega y Gasset, Biblioteca Nueva, Madrid 2000, p. 53; e Gonzalo Redondo, Las empresas políticas de José Ortega y Gasset, “El Sol”, “Crisol”, “Luz” (1917−1934), 2 voll., Rialp, Madrid 1970.
[24] Cfr. Joaquín Azpiazu, Jóvenes y juventudes, Razón y Fe, Madrid 19342, p. 118. Ci riferiremo ai propagandisti più avanti, quando parleremo delle associazioni studentesche.
[25] Cfr. Álvaro Ferrary, El franquismo: minorías políticas y conflictos ideológicos. 1936−1956, EUNSA, Pamplona 1993, p. 27. Cfr. anche Enrique Sánchez Costa, El resurgimiento católico en la literatura europea moderna (1890−1945), Encuentro, Madrid 2014.
[26] Intervista a José María González Barredo, Pamplona, 14−IX−1986, in AGP, serie A.5, 216−3−11.
[27] Aurora Medina, «Un recuerdo para la historia», in AA.VV., Pedro Poveda. Volumen−homenaje. Cinquentenario. 1936−1986, Narcea, Madrid 1988, p. 36.
[28] Probabilmente arrivò un giorno prima, il 19 aprile, perché quello fu il giorno in cui partì da Saragozza diretto nella capitale spagnola (cfr. Benito Badrinas Amat, “Josemaría Escrivá de Balaguer. Sacerdote de la diócesis de Madrid”, Anuario de Historia de la Iglesia VIII [1999] 607). Il sacerdote aveva ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’arcivescovo di Saragozza per risiedere fuori dalla diocesi (cfr. Registro de Decretos, 1929−33, fol. 120, n. 1813 e fol. 121, n. 1820, in ADZ, 205−B).
[29] Le tappe preliminari della biografia di José María Escrivá si possono leggere in Carlo Pioppi, “Infanzia e prima adolescenza di Josemaría Escrivá: Barbastro 1902−1915. Contesti, eventi biografici, stato delle ricerche e prospettive di approfondimento”, Studia et Documenta 8 (2014) 149−189; Jaime Toldrà Parés, Josemaría Escrivá en Logroño (1915−1925), Rialp, Madrid 2007; e Ramón Herrando Prat de la Riba, Los años de seminario de Josemaría Escrivá en Zaragoza (1920−1925): El seminario de San Francisco de Paula, Madrid, Rialp, 2002.
[30] Per gli studi del dottorato in Diritto, cfr. Pedro Rodríguez, “El doctorado de san Josemaría en la Universidad de Madrid”, Studia et Documenta 2 (2008) 13−103. Sul trasferimento da Saragozza a Madrid, che risentì di alcune difficoltà familiari, cfr. John F. Coverdale, La fundación del Opus Dei, o. c., pp. 38−44.
[31] La chiesa era sotto la giurisdizione della Nunziatura a Madrid ed era retta dai padri Redentoristi. Nel 1930 ricevette il titolo di Basilica minore.
[32] La Congregazione aveva ricevuto la prima approvazione nel 1924. Fu eretta canonicamente da Mons. Eijo Garay, vescovo di Alcalá−Madrid, il 24 giugno 1927. A Madrid la Casa centrale si trovava nel Patronato de Enfermos —calle Santa Engracia— e dal 1929 vi era un noviziato al Paseo de La Habana (Chamartín de la Rosa). Le Dame Apostoliche ricevettero l’approvazione dalla Santa Sede il 29 maggio 1943. Cfr. Emilio Itúrbide, Doña Luz. Madre de los pobres, Gómez, Pamplona 1963.
[33] Condivise con loro le vicende del momento e le aspirazioni apostoliche. Per esempio, Gómez Colomo ricordava che un giorno stavano camminando «commentando una cosa che era accaduta ma che ora non ricordo, quando [Escrivá] mi parlò della necessità di fare apostolato anche con gli intellettuali perché, aggiungeva, sono come le vette innevate: quando la neve si scioglie, l’acqua scende giù e le valli fruttificano» (Ricordo di Fidel Gómez Colomo, Madrid, 15−X−1975, in AGP, serie A.5, 216−1−8).
[34] Luz Rodríguez−Casanova era nata ad Avila il 28 agosto 1873. Iniziò la sua attività apostolica nel 1902. Frequentò José María Escrivá tra il 1927 e il 1931, gli anni in cui il sacerdote fu cappellano del Patronato de Enfermos. Morì a Madrid l’8 gennaio 1949. Cfr. Francisco Martín Hernández, Luz Casanova. Una vida consagrada a los pobres, Congregación de Damas Apostólicas, Madrid 1991.
[35] Norberto Rodríguez García era nato ad Astorga (León) il 26 aprile 1880. Ricevette l’ordinazione sacerdotale il 29 settembre 1905 restando incardinato nella diocesi di Astorga. Si trasferì a Madrid nel 1910. Dal 1924 al 1932 fu il secondo cappellano delle Dame Apostoliche. Fra il 1932 e il 1936 occupò, sempre a Madrid, il posto di secondo cappellano delle Schiave del Sacro Cuore. Strinse un rapporto stretto con José María Escrivá fino alla guerra civile. Dopo la guerra fu cappellano delle Carmelitane scalze di calle Aranaz a Madrid. Morì l’8 maggio 1968. Cfr. Jaume Aurell – José Luis González Gullón, “Josemaría Escrivá en los años treinta: los sacerdotes amigos”, Studia et Documenta 3 (2009) 47−51.
[36] Cfr. Ricordo di Asunción Muñoz González, Daimiel, 25−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 230−4−4.
[37] Sulla collaborazione data da Escrivá al Patronato de Enfermos, si può leggere un reportage dell’epoca in Enrique Luño Peña, «Pan y Catecismo», La Acción Social 13 (I−1928) 6−9.
[38] Cfr. Julio González−Simancas y Lacasa, “San Josemaría entre los infermos de Madrid (1927−1931)”, Studia et Documenta 2 (2008) 147−203.
[39] Cfr. annotazione di José María Escrivá, in AVM, Padrón 1930, tomo 85, foglio n. 26476; e Lettera di José María Escrivá a José Pou de Foxá, Madrid, 13−V−1931, in AGP, serie A.3.4, 253−1, 300513−1.
[40] Cfr. José Luis González Gullón, El clero en la Segunda República. Madrid, 1931−1936, Monte Carmelo, Burgos 2011, p. 114.
[41] José Cicuéndez Aparicio era un sacerdote della diocesi di Toledo. Oltre a dirigere l’Accademia, era primo cappellano del Patronato di Santa Isabel di Madrid.
[42] Opuscolo Extracto de Reglamento. Academia Cicuéndez. Especial de Derecho, p. 2, in AGP, serie A.1, 5−2−6. L’Accademia era ospitata in un piccolo convitto e aveva otto posti.
[43] Ricordo di Pedro Rocamora Valls, Madrid, 12−XI−1977, in AGP, serie A.5, 241−1−5.
[44] Insegnò almeno fino all’estate del 1932. Si conserva una richiesta del proprietario dell’Accademia perché continuasse a dare lezioni di Diritto Romano nell’anno accademico 1932−1933, ma non risulta che la richiesta sia stata accolta. Cfr. Lettera di Florián Ruiz Egea a José María Escrivá, Madrid, 2−X−1932, in AGP, serie A.6, 372−2; e Constantino Ánchel, “Actividad docente de san Josemaría: el Instituto Amado y la Academia Cicuéndez”, Studia et Documenta 3 (2009) 330.
[45] Cfr. Ricordo di Santiago Escrivá de Balaguer, Madrid, 10−II−1979, in AGP, serie A.5, 210−1−5. Carmen, che aveva studiato nella Escuela Normal de Maestras di Logroño, impartì alcune lezioni private. In ogni caso, dedicò quasi tutte le sue energie ai lavori domestici, perché sua madre aveva bisogno di aiuto per motivi di salute.
[46] Apuntes íntimos, n. 306 (2−X−1931; la prima frase è una nota marginale degli anni sessanta), citato in Pedro Rodríguez, Opus Dei. Struttura & Missione. Un profilo ecclesiologico, Edizioni Ares, Milano 2013, p. 58. Il corsivo è nell’originale.
[47] Cfr. ibidem, pp. 64−65. Uno studio teologico su questo momento fondamentale si può trovare in José Luis Illanes Maestre, “Datos para la comprensión histórico−espiritual de una fecha”, Anuario de Historia de la Iglesia XI (2002) 655−697. Cfr. anche Pedro Rodríguez — Fernando Ocáriz — José Luis Illanes, El Opus Dei en la Iglesia. Introducción eclesiológica a la vida y al apostolato del Opus Dei, Rialp, Madrid 2014, pp. 201−205, dove si spiega che la luce fondazionale includeva tanto un messaggio quanto una istituzione che lo diffondesse.
[48] Nel 1931 il fondatore condensò in tre giaculatorie quali erano i fini di quest’Opera divina: Deo omnis gloria (“Per Dio tutta la gloria”), cercare di realizzare ogni cosa per e a gloria di Dio; Regnare Christum volumus (“Vogliamo che Cristo regni”), rendere effettivo il regno di Cristo nella società; e Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam (“Tutti con Pietro a Gesù attraverso Maria”), impegnandosi per la santità propria e altrui (cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., pp. 225−228).
[49] Cfr. Apuntes íntimos, n. 179 (22−III−1931), commentato in Antonio Aranda, “El bullir de la Sangre de Cristo”. Estudio sobre el cristocentrismo del beato Josemaría Escrivá, Rialp, Madrid 2000, pp. 97 e 99.
[50] Si conservano più di quaranta ritagli di giornale, pubblicati tra il 1920 e il 1933, su diverse istituzioni cattoliche —come pie unioni, ordini terziari, associazioni—, e anche scuole, convegni e case editrici cattoliche di Spagna, Stati Uniti, Francia, Olanda, Ungheria, Italia e Polonia. Furono raccolti da José María Escrivá, aiutato da José Romeo (cfr. AGP, serie A.1, 6−4−1, serie A.3, 179−1−5, e serie A.3, 179−1−6).
[51] Apuntes íntimos, n. 1869 (14−VI−1948), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 334. La frase è tra virgolette già nell’originale. Come si vedrà subito, sedici mesi più tardi capì che nell’Opera dovevano esserci anche le donne. Sul cardinale Carlo Andrea Ferrari (1850−1921), arcivescovo di Milano, beatificato da Giovanni Paolo II nel 1987, apparve allora una biografia nell’Anuario Eclesiástico, nella quale si menzionavano le tre sezioni della Compagnia di San Paolo, tra le quali quella femminile (cfr. Pedro Voltas, «El cardenal Ferrari. Su obra. La Compañía de San Pablo», in Anuario Eclesiástico, Eugenio Subirana, Barcelona 1928, pp. 105−128).
[52] José Romeo Rivera era nato a Saragozza il 2 marzo 1911. Lì conobbe José María Escrivá nel 1926. José aveva allora 14 anni e studiava nel Colegio del Salvador dei gesuiti. Suo fratello maggiore, Manuel (Colo), fu compagno di studi di Escrivá nella Facoltà di Giurisprudenza di Saragozza. José si formò nello spirito dell’Opus Dei fino al marzo del 1935, quando se ne separò. Dopo la guerra civile spagnola, lavorò come architetto. Morì, dopo una lunga malattia, il 7 luglio 1985. Cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., p. 20, nt. 13.
[53] Cfr. Racconto autobiografico di José Romeo Rivera (inizi del 1935), in AGP, serie A.2, 34−3−10.
[54] Cfr. Intervista a Guillermo Escribano Ucelay, Madrid, 17−IX−1975, in AGP, serie A.5, 343−2−3.
[55] Pedro Rocamora Valls era nato a Madrid il 9 dicembre 1910. Frequentò la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Madrid tra il 1926 e il 1931. Fu avvocato e giornalista. Don José María Escrivá benedisse il suo matrimonio. Morì a Madrid il 31 dicembre 1993 (cfr. AGUCM, Dossier degli studenti della Facoltà di Diritto, DE−831).
[56] Cfr. “Confesores de san Josemaría a Madrid”, in AGP, serie A.1, 5−2−3.
[57] Apuntes íntimos, n. 354 (26−X−1931), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 479. Questo suggerimento di Norberto Rodríguez avvenne dopo il 14 febbraio 1930.
[58] «Non posso dire che vidi, ma sì che intellettualmente, nei particolari (poi ho aggiunto altre cose sviluppando la visione intellettuale), ho colto ciò che doveva essere la Sezione femminile dell’Opus Dei» (Apuntes íntimos, n. 1871 [14−VI−1948], in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 335). Su questa vicenda, cfr. Francisca R. Quiroga, “14 de febrero de 1930: la transmisión de un acontecimiento y un mensaje”, Studia et Documenta 1 (2007) 163−189; e Gloria Toranzo, “Los comienzos del apostolato del Opus Dei entre mujeres (1930−1939)”, Studia et Documenta 7 (2013) 20−25.
[59] Apuntes íntimos, n. 1872 (14−VI−1948), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 335.
[60] Isidoro Zorzano Ledesma era nato a Buenos Aires il 13 settembre 1902 da genitori spagnoli. Tre anni dopo la famiglia ritornò in Spagna e si stabilì a Logroño. Isidoro si laureò nel 1927 in ingegneria industriale a Madrid. Dal dicembre del 1928 al giugno del 1936 lavorò nella Compagnia delle Ferrovie Andaluse a Malaga. Dopo la guerra civile continuò a lavorare nelle ferrovie, ma a Madrid, collaborando con il fondatore all’espansione dell’Opus Dei. Morì il 15 luglio 1943 a causa di un tumore. Il 21 dicembre 2016 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto sull’eroicità delle sue virtù.
[61] Cfr. José Miguel Pero−Sanz Elorz, Isidoro Zorzano Ledesma: ingeniero industrial (Buenos Aires, 1902 — Madrid, 1943), Palabra, Madrid 1996, pp. 115−119.
[62] Cfr. AGP, serie A.1, 6−41, serie A.3, 179−1−5, e serie A.3, 179−1−6; note di Juan Jiménez Vargas, serie A.2, 9−5−3.
[63] Sappiamo che nel febbraio del 1930 José María Escrivá confessò alcuni operai nel loro centro di riunione. Un mese dopo predicò e confessò ancora degli operai nella Cappella del Vescovo, accanto alla parrocchia di Sant’Andrea, in una missione o predicazione organizzata dal Patronato de Enfermos (cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 359).
[64] Cfr. Ricordo di Santiago Escrivá de Balaguer, Madrid, 10−II−1979, in AGP, serie A.5, 210−1−5.
[65] Questa abitazione, invece, costituì un sollievo per le modeste finanze della famiglia. Essendo l’abitazione ufficiale del cappellano del Patronato de Enfermos, José María Escrivá non doveva pagare l’affitto. Cfr. AVM, Padrón 1930, tomo 185, foglio n. 26476.
[66] Ricordo di Pedro Rocamora Valls, Madrid, 12−XI−1977, in AGP, serie A.5, 241−1−5.
[67] Julián Cortés−Cavanillas era nato a Madrid il 9 marzo 1909. Nel 1928 conciliava gli studi nella Scuola di Giornalismo de El Debate con quelli di Giurisprudenza, nella cui Facoltà si era immatricolato come studente esterno. Da giornalista, fu corrispondente da Roma del giornale ABC per ventuno anni. Morì a Madrid il 15 ottobre 1991 (cfr. ABC, 20−III−2009, p. 59).
[68] Ricordo di Pedro Rocamora Valls, Madrid, 12−XI−1977, in AGP, serie A.5, 241−1−5.
[69] Cfr. Pedro Rodríguez, “El doctorado de san Josemaría en la Universidad de Madrid”, o.c., p. 45; e Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., pp. 277−282.
[70] In quegli anni scrisse: «Per ora il lavoro è personale: ci riuniamo solo per fare l’orazione» (Apuntes íntimos, n. 128 [10−XII−1930], in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 391).
[71] Apuntes íntimos n. 207 (15−VII−1931), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 395).
[72] Cfr. John F. Coverdale, La fundación del Opus Dei, o. c., pp. 79−80.
[73] In una lettera inviata a Isidoro in maggio gli scrive quale dev’essere il suo atteggiamento nei confronti della Repubblica: «Notizie: il cambiamento politico non ti deve fare né freddo né caldo: ti deve importare soltanto che non offendano Dio. Ripara...» (Lettera, Madrid, 31−V−1931, in AGP, serie A.3.4, 253−1, 310505−1).
[74] In Spagna la giurisdizione palatina riguardava l’assistenza spirituale della famiglia reale e del personale al suo servizio. Un prelato esercitava la sua giurisdizione su una prelatura o parrocchia nullius con territorio, clero e popolo propri, vale a dire, al di fuori della giurisdizione ordinaria. Questo prelato era denominato Pro−Cappellano maggiore, e il suo incarico prevedeva il titolo di vescovo di Sión e di Patriarca delle Indie. A Madrid aveva giurisdizione sul Palazzo Reale e sui sei Reali Patronati, il cui organico comprendeva circa sessanta cappellani (cfr. Juan Postius y Sala, El Código de Derecho Canónico aplicado a España, Corazón de María, Madrid 1926, pp. 535−536).
[75] Un riassunto di quello che accadde a Madrid si può leggere nel nostro contributo in El clero en la Segunda República. Madrid, 1931−1936, o. c., pp. 346−363. Una visione d’insieme sulla vicenda e le sue conseguenze in William J. Callahan, La Iglesia Católica en España (1875−2002), Crítica, Barcelona 2003, pp. 226−229.
[76] Apuntes íntimos, n. 202 (18−V−1931), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 383.
[77] Cfr. Relato autobiografico di José Romeo Rivera (inizio del 1935), in AGP, serie A.2, 34−3−10.
[78] Apuntes íntimos, n. 877 (24−XI−1932) in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 513. Durante i giorni degli «incendi dei conventi» José María e suo fratello Santiago vissero in casa dei Romeo, mentre sua madre e sua sorella si trasferirono in casa di conoscenti in calle General Oraá.
[79] José Muñoz Aycuéns era stato per un certo tempo geronimita nel monastero di Santa María del Parral (Segovia). Conobbe José María Escrivá attraverso il religioso clarettiano Juan Postius. Non sembra che sia arrivato a frequentare DYA, perché smise di avere rapporti con Escrivá nell’autunno del 1933. Morì ad Azuqueca de Henares (Guadalajara) l’11 ottobre 1964. Cfr. ABC, 13−X−1964, p. 100.
[80] Adolfo Gómez Ruiz era nato a Segovia nel 1909. Si laureò in Medicina all’Università Centrale e fu un medico della Beneficenza Municipale. Confinato a Villa Cisneros nel settembre del 1932 per aver partecipato al tentativo di colpo di Stato del 10 agosto, ritornò nella Penisola Iberica, a Lisbona, nella primavera del 1933. Nell’aprile del 1934 fu amnistiato e poté ritornare in Spagna. Da allora frequentò in modo sporadico la Residenza DYA, pur non sentendosi vincolato all’Opera. Dopo la guerra civile fu procuratore nel Parlamento Spagnolo. Morì per un tumore a 47 anni, nell’ottobre del 1956. Cfr. ABC (edizione di Siviglia), 12−X−1956, p. 32.
[81] Sebastián Cirac Estopañán era nato a Caspe (Saragozza) il 17 settembre 1903. Il 17 marzo 1928 era stato ordinato presbitero. Nel 1930 ottenne un canonicato nel capitolo di Cuenca; quando si presentò, il vescovo lo nominò archivista. Ottenne il dottorato in Filosofia, Teologia, Filologia e in Filosofia e Lettere. Nella primavera del 1934 si occupò del nihil obstat necessario per la pubblicazione di Consideraciones Espirituales, che precedette Camino. Dall’ottobre del 1934 fino a metà del 1938 approfondì gli studi a Monaco (Germania). Dopo la guerra civile spagnola fu decano della Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Barcellona. Morì il 17 marzo 1970. Cfr. Jaume Aurell — José Luis González Gullón, “Josemaría Escrivá en los años treinta: los sacerdotes amigos”, o. c., pp. 58−60.
[82] Cfr. Schede delle prime persone trattate da José María Escrivá a Madrid, in AGP, serie A.2, 35−1−1.
[83] Pedro Cantero Cuadrado (1902−1978) aveva studiato all’Università Pontificia di Comillas. Ordinato sacerdote nel 1926, quattro anni dopo si trasferì a Madrid per ultimare gli studi di Diritto e prendere il dottorato. Fu visitatore dell’Associazione Cattolica Nazionale dei Propagandisti. Dopo la guerra civile svolse l’incarico di Rettore del Patronato di Loreto. Ricevette l’ordinazione episcopale nel 1951, trasferendosi nella sede di Barbastro. Nel 1953 passò alla diocesi di Huelva e nel 1964 fu nominato arcivescovo di Saragozza dove rimase fino alla sua rinuncia, per motivi di salute, nel 1977. Per i suoi rapporti con José María Escrivá, cfr. Jaume Aurell — José Luis González Gullón, “Josemaría Escrivá en los años treinta: los sacerdotes amigos”, o. c., pp. 51−55. Una sua breve biografia si trova nel Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza (V−1964) 404−405; e in J.B.P., “Cantero Cuadrado, Pedro”, in Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. III, Zaragoza 1980, p. 631.
[84] Cantero fu coinvolto in una intensa attività nell’Associazione Cattolica Nazionale dei Propagandisti e nell’Istituto Sociale Operaio (cfr. Pedro Cantero Cuadrado, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un hombre de Dios, Palabra, Madrid 1991, p. 20).
[85] Ricordo di José Romeo Rivera, Siviglia, 27−III−1976, in AGP, serie A.5, 242−2−5.
[86] Ricordo di Carlos Sánchez del Río Peguero, Saragozza, 14−XI−1975, in AGP, serie A.5, 245−1−5.
[87] Ricordo di Amalia de Santa Ana Pérez (S.M.R.), Valencia, 15−VI−1980, in AGP, serie A.5, 245−2−9.
[88] Ricordo di Pedro Rocamora Valls, Madeid, 12−XI−1977, in AGP, serie A.5, 241−1−5.
[89] Ibidem.
[90] Cfr. Intervista a Jesús Manuel Sanchiz Granero, Madrid, 7−X−1975, in AGP, serie A.5, 5−2−6.
[91] Julián Cortés−Cavanillas, «Mi amigo el Padre Escrivá», in ABC, 14−IX−1986, p. 52.
[92] Ibidem.
[93] Ibidem.
[94] Ricordo di Manuel Gómez−Alonso Gómez−Alonso, Madrid, 4−X−1976, in AGP, serie A.g, 216−1−3.
[95] Ricordo di Pedro Rocamora Valls, Madrid, 12−XI−1977, in AGP, serie 241−1−5.
[96] Intervista a Guillermo Escribano Ucelay, Madrid, 17−IX−1975, in AGP, serie A.5, 343−2−3.
[97] Ricordo di Pedro Rocamora Valls, Madrid, 12−XI−1977, in AGP, serie A.5, 241−1−5.
[98] Ibidem.
[99] Il mondo cattolico protestò soprattutto perché i religiosi erano diventati “costituzionalmente sospetti”. L’articolo 26, fra gli altri aspetti, dichiarava: «Tutte le confessioni religiose saranno considerate come associazioni sottoposte a una legge speciale»; si proibiva loro di «esercitare l’industria, il commercio o l’insegnamento»; inoltre, «i beni degli Ordini religiosi potranno essere nazionalizzati»; «sono sciolti quegli Ordini religiosi che impongano per statuto, oltre i tre voti canonici, un altro speciale di obbedienza a un’autorità diversa da quella legittima dello Stato. I loro beni saranno nazionalizzati e destinati a fini di beneficenza e di insegnamento». Cfr. Víctor Manuel Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España (octubre de 1931), Encuentro, Madrid 2006; e Fernando de Meer Lecha−Marzo, La Cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II República Española, EUNSA, Pamplona 1975. Per il caso particolare dei gesuiti, cfr. Alfredo Verdoy, Los bienes de los gesuita. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, Trotta, Madrid 1995.
[100] Il cambiamento politico−sociale che la sinistra repubblicana e il socialismo erano riusciti a fare approvare appariva rivoluzionario «in due sensi: come cambiamento radicale delle istituzioni e della forma di governo, ma anche come processo aperto di trasformazione sociale, politica, culturale ed economica» (Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española [1931−1936], Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2002, p. 358).
[101] José María Escrivá annotò che gli erano venute con forza alla mente, in latino, le parole di Gesù «Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12, 32), mentre celebrava la Messa: «E compresi che saranno gli uomini e le donne di Dio a innalzare la Croce con la dottrina di Cristo sul pinnacolo di tutte le attività umana... E vidi il Signore trionfare e attrarre a sé tutte le cose» (Apuntes íntimos, n. 217 [7−VIII−1931], in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 402). La comprensione e la visione di quel giorno conferivano un nuovo senso corredentore ai membri dell’Opera e, per estensione, a tutti i cristiani. Cfr. Pedro Rodríguez, “La exaltación de Cristo en la Cruz (Gv 12, 32) en la experiencia espiritual del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer”, in Gonzalo Aranda, Biblia, Exégesis y Cultura. Estudios en honor del Prof. D. José María Casciaro, EUNSA, Pamplona 1994, pp. 573−601.
[102] Cfr. Fernando Ocáriz, “La filiación divina, realidad central en la vida y en la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer”, in Fernando Ocáriz – Ignacio de Celaya, Vivir como hijos de Dios. Estudios sobre el Beato Josemaría Escrivá, EUNSA, Pamplona 1993, pp. 11−89; Antonio Aranda, “Fundación del Opus Dei”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, o. c., pp. 552−561; ed Ernst Burkhart — Javier López, Vita quotidiana e santità nell’insegnamento di san Josemaría, vol. II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018, pp. 21−56.
[103] La storia del Patronato di Santa Isabel si può leggere in Beatriz Comella Gutiérrez, La jurisdicción eclesiástica palatina en los Patronatos Reales del Buen Suceso y de Santa Isabel de Madrid (1753−1931), Fundación Universitaria Española, Madrid 2004.
[104] Fino al 16 giugno 1931 il rettore era stato Buenaventura Gutiérrez San Juan; il cappellano del monastero, Mariano Villapún Sancha; e il cappellano della scuola, José Cicuéndez Aparicio, proprietario dell’Accademia Cicuéndez, che risultava malato. Cfr. Beatriz Comella Gutiérrez, Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid (1931−1945), o.c., p. 65.
[105] Cfr. Ibidem, pp. 138−142.
[106] Cfr. Ibidem, p. 151, nt. 76; Cfr. anche Benito Badrinas Amat, “Josemaría Escrivá de Balaguer. Sacerdote della diocesi di Madrid”, o. c., p. 616. Il Governo provvisorio della Repubblica creò una commissione per i patronati che nominò i nuovi rettori. I cappellani, invece, furono esclusi.
[107] Apuntes íntimos, n. 403 (20−XI−1931), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 400. Le schede richieste dal vescovo si possono vedere nell’Archivio Storico della Diocesi di Madrid, “Carpeta E, Serie V. Estadística sacerdotal parroquial. 1931”.
[108] Apuntes íntimos, n. 731 (20−V−1932), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 460.
[109] Cfr. “El R. p. José María Escrivá de Balaguer y la Congregación de Hermanos Filipenses”, Como yo os amé 32 (1975) 5.
[110] Da allora, e fino alla guerra civile spagnola, le visite di José María Escrivá ai malati dell’Ospedale Provinciale furono frequenti. A seguito di una sua richiesta, la Giunta dei filippini lo nominò «fratello della nostra amata congregazione» (Lettera di Tomás Mínguez a José María Escrivá, Madrid, 10−VI−1934, in AGP, serie A.1, 5−3−11).
[111] Pedro Cantero Cuadrado, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un hombre de Dios, o.c., p. 23.
[112] Ibidem.
[113] Appunti di una riunione di famiglia, 19−II−1975, in Catequesis en América 1975, vol. III, p. 278 (AGP, Biblioteca, P.04).
[114] Apuntes íntimos, n. 306, in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., p. 8, nt. 21. Secondo Pedro Rodríguez, autore di questa edizione, si tratta di una nota a margine autografa di José María Escrivá, scritta nel 1968 in un quaderno del 1932.
[115] Cfr. Ricordo di José Romeo Rivera, Siviglia, 27−III−1976, in AGP, serie A.5, 242−1−1.
[116] Ibidem.
[117] Ricordo di José Manuel Doménech de Ibarra, Lérida, 13−III−1985, in AGP, serie A.5, 208−3−5.
[118] Apuntes íntimos, n. 410, (23−XI−1931), in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o. c., p. 986.
[119] Apuntes íntimos, n. 479 (14−XII−1931).
[120] Apuntes íntimos, n. 476 (13−XII−1931, in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 413. È la citazione esatta del salmo 103, versetto 10 (salmo 104 nell’edizione della Vulgata).
[121] Lino Vea−Murguía Bru era nato a Madrid il 24 aprile 1901. Fu ordinato presbitero il 18 dicembre 1926. Dal 1930 e fino alla guerra civile fu cappellano delle religiose Schiave del Sacro Cuore in calle Martínez Campos 6, collaborando all’apertura dell’Accademia DYA. Fu assassinato, in quanto sacerdote, il 15 agosto 1936. Cfr. Jaume Aurell — José Luis González Gullón, “Josemaría Escrivá en los años treinta: los sacerdotes amigos”, o. c., pp. 60−64.
[122] Cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 486.
[123] José María Vegas Pérez (1902−1936). Ricevette l’ordinazione sacerdotale nel 1927. Fu nominato cappellano della parrocchia di San Ginés. Nel 1935 fu assegnato al rettorato del Santuario del Cerro de los Ángeles, a sud di Madrid. Morì fucilato il 27 novembre 1936 in uno dei tristemente celebri “rastrellamenti” di Paracuellos del Jarama (cfr. AHN, Fondo Contemporáneo, Causa General, 1557, f. 291).
[124] José María Somoano Berdasco era nato ad Arriondas (Asturie) il 4 febbraio 1902. Ordinato sacerdote della diocesi di Madrid−Alcalá l’11 giugno 1927, era stato il cappellano dell’Asilo di Porta Coeli di Madrid dall’aprile del 1929 al febbraio del 1931; poi dell’Ospedale del Re dall’aprile del 1931 fino al decesso. Per la sua morte prematura, il 16 luglio 1932, fu il primo defunto dell’Opus Dei. Cfr. José Miguel Cejas, José María Somoano en los comienzos del Opus Dei, Rialp, Madrid 1995.
[125] Cfr. José María García Lahiguera, Josemaría Escrivá de Balaguer: Un hombre de Dios. Testimonios sobre el Fundador del Opus Dei, Palabra, Madrid 1991, p. 16; e Ricordo di José María García Lahiguera, Madrid, 23−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 214−3−1.
[126] Apuntes íntimos, n. 613 (II−1932), in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., p. 562, nt. 11. Le meditazioni, comprese tra i mesi di febbraio e luglio 1932, si trovano in AGP, serie A.3, 177−3−2.
[127] Saturnino de Dios Carrasco era nato il 14 dicembre 1906 ad Arabayona de Mógica (Salamanca). Fece gli studi di Teologia a Comillas (Cantabria). Ordinato nel 1931, restò incardinato nella diocesi di Salamanca. Tra il 1931 e il 1933 fu precettore di un figlio adottivo della famiglia Ruiz−Ballesteros. Nell’estate del 1935 si traferì a Mieres (Asturie) per lavorare nel Liceo del paese. Dopo la guerra civile ottenne un canonicato nel Sacro−Monte di Granda. Morì nel 1981. Cfr. Ricordo di Saturnino de Dios Carrasco, Gijón, 30−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 208−2−17.
[128] Cfr. Jaume Aurell — José Luis González Gullón, “Josemaría Escrivá en los años treinta: los sacerdotes amigos”, o.c., p. 75.
[129] Cfr. Apuntes íntimos, n. 381 (8−XI−1931), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 488−489. María del Carmen Cuervo Radigales era nata il 25 febbraio 1895 a Madrid. Laureata in Filosofia e Lettere, in Diritto e “maestra nazionale”, diede alcune lezioni nella Scuola dell’Assunzione del Patronato di Santa Isabel. Ispettrice ausiliare del Lavoro dal 1928. Nel mese di aprile del 1933 vinse un concorso al Ministero del Lavoro e fu destinata a Soria. Un anno dopo interruppe ogni contatto con l’Opera. Morì il 28 luglio 1996. Cfr. Pratica personale di María del Carmen Cuervo Radigales, in AGA, Trabajo, 36/13818; AGP, serie A.6, 375−3; e Gloria Toranzo, “Los comienzos del apostolato del Opus Dei entre mujeres (1930−1939)”, o.c., pp. 32−38.
[130] Intervista a Carmen Cuervo Radigales, Madrid, 29−X−1975, in AGP, serie A.5, 206−2−8.
[131] Cfr. Apuntes íntimos, n. 602 (15−II−1932), in Romana et Matritense. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Iosephmariae Escrivá de Balaguer, Sacerdotis Fundatoris Societatis Sacerdotalis S. Crucis et Opus Dei. Positio super vita et virtutibus. Biographia documentata, Roma 1988 (in seguito, Positio...), p. 324.
[132] María Ignacia García Escobar era nata a Hornachuelos (Córdoba) il 2 luglio 1896. Dal luglio del 1930 si trovava nell’Ospedale del Re per essere curata da una tubercolosi che l’aveva colpita dieci anni prima e che le provocherà la morte il 13 settembre 1933. Cfr. José Miguel Cejas, La paz y la alegría: María Ignacia García Escobar en los comienzos del Opus Dei. 1896−1933, Madrid, Rialp, 2001.
[133] Antonia Sierra Pau era nata il 3 aprile 1895. Nel 1912 si sposò ed ebbe una figlia. Fu ricoverata all’Ospedale del Re e dopo, tra il maggio del 1934 e il dicembre del 1936, fu trasferita all’Ospedale Generale. Andata via da Madrid, fu ospite di diversi ospedali del Levante —Villafranca del Cid (Castellón), Castellón, Lucena e Estivella (Valencia)— per ritornare poi nell’Ospedale Generale di Madrid. Nel settembre del 1937 José María Escrivá cercò di inviarle un po’ di denaro; nel 1938 ebbe nuove informazioni sul suo stato di salute. Sierra morì il 13 agosto 1939. Cfr. Gloria Toranzo, “Los comienzos del apostolato del Opus Dei entre mujeres (1930−1939)”, o. c., pp. 49−54; e Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., II, o.c. p. 148 e 300.
[134] Luis Gordon Picardo era nato a Cadice il 20 agosto 1898. Nel 1925 creò una società per la fabbricazione del malto, indispensabile per la produzione della birra, a Ciempozuelos (Madrid). Gordon presentò Saturnino de Dios a José María Escrivá nell’Ospedale Provinciale. Colpito da una polmonite, morì a Madrid il 5 novembre 1932. Cfr Pedro Pablo Ortúñez Goicolea — Luis Gordon Beguer, “Luis Gordon Picardo. Un empresario en los primeros años del Opus Dei (1898−1932)”, Studia et Documenta 3 (2009) 107−138.
[135] Antonio Medialdea era di Guadix. Probabilmente si trasferì a Jaén dopo la guerra civile. Lì aprì un negozio di paramenti liturgici e di immagini sacre. Morì nel 1965. Cfr. Ricordo di José Romeo Rivera, Siviglia, 27−III−1976, in AGP, serie A.5, 240−1−1.
[136] Cfr. Ricordo di Sor María Casado, Figlia della Carità, Gijón, 16−III−1993, in AGP, serie A.5, T−13083.
[137] Adolfo Gómez Ruiz (ventitré anni) era presidente dell’Associazione degli Studenti Tradizionalisti. Erano tradizionalisti anche Pepe Romeo (ventun anni), José Antonio Palacios (venti anni), José Manuel Doménech (ventitré anni) e Julio Torres Azara (venticinque anni). Al colpo di mano partecipò anche Luis Gordon (trentatré anni).
[138] Cfr. Julio Gil Pecharromán, “Sobre España immortal, sólo Dios”. José María Albiñana y el Partido Nacionalista Español (1930−1937), UNED, Madrid 2000, p. 51.
[139] Dopo gli incendi del maggio 1931, alcuni tradizionalisti e “albiñanisti” presidiarono di notte i conventi di Madrid, soprattutto quelli di Clausura. Cfr. Ricordo di José Antonio Palacios López, Madrid, 30−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 235−2−8.
[140] Una buona descrizione della vicenda accaduta a Madrid si può leggere in Ahora, 10 e 11−VIII−1932.
[141] Cfr. Relato autobiografico de José Romeo Rivera (inizi del 1935), in AGP, serie A.2, 34−3−10.
[142] Tra i deportati c’erano anche il fratello e il padre di Adolfo Gómez. I tre riuscirono a fuggire da Villa Cisneros su un peschereccio francese il 31 dicembre 1932. Poi si rifugiarono a Lisbona e a Parigi. Nell’aprile del 1934 rientrarono in Spagna perché il Governo repubblicano aveva concesso l’amnistia ai condannati per l’insurrezione. Cfr. Fernando G. Vinuesa, De Madrid a Lisboa por Villa Cisneros, Estrella, Madrid 1933, pp. 361−362.
[143] José María Escrivá si recò al Carcere Modello per offrire il suo aiuto spirituale e la sua vicinanza a Gómez Ruiz e ai suoi amici. Quelli che non furono deportati rimasero nel carcere di Madrid circa dodici mesi (cfr. Ricordo di José Antonio Palacios López, Madrid, 30−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 235−2−8).
[144] Ricordo di José Romeo Rivera, Siviglia, 27−III−1976, in AGP, serie A.5, 242−2−5.
[145] Ricordo di José Antonio Palacios López, Madrid, 30−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 235−2−8.
[146] Ricordo di José Manuel Doménech de Ibarra, Lérida, 13−III−1985, in AGP, serie A.5, 208−3−5, che aggiunge: «Per il Padre la politica era una opzione responsabile e personale. Egli rispettava le idee di tutti e non manifestava le sue». I partecipanti alla bravata sono unanimi: «Mai il Padre ha parlato esplicitamente delle sue idee politiche» (Ricordo di José Romeo Rivera, Siviglia, 27−III−1976, in AGP, serie A.5, 242−2−5); don José María, «senza far politica e parlando soprattutto di amore per la Chiesa e il Papa, dava dottrina» (Ricordo di José Antonio Palacios López, Madrid, 30−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 235−2−8)..
[147] Quando Romeo ritornò a Madrid, i problemi di stanchezza mentale, che gli rendevano difficile seguire i corsi universitari, continuarono (cfr. Lettera di Ricardo Fernández Vallespín a Manuel Sainz de los Terreros, Madrid, 18−VII−1934, in AGP, serie M 1.1, C146−B3; e Diario di Ferraz, 15−I−1935, p. 111).
[148] Cfr. Apuntes íntimos, n. 42 (15−VI−1930), in Amadeo de Fuenmayor — Valentín Gómez Iglesias — José Luis Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma, Giuffrè Editore, Milano 1991, p. 65; e Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., II, o.c., p. 440.
[149] Valentín María Sánchez Ruiz era nato a Orellana la Vieja (Badajoz) il 16 ottobre 1879. Entrò nella Compagnia di Gesù che era ancora adlescente. Il 21 giugno 1911 ricevette l’ordinazione sacerdotale. Emise il quarto voto il 2 febbraio 1914. Era conosciuto per il suo Misal cotidiano latino−spagnolo ad uso dei fedeli, che ebbe quindici edizioni. José María Escrivá lo scelse come direttore spirituale dal 1930 al 1940, salvo il periodo della guerra civile. Il padre Valentín Sánchez Ruiz non si intromise nel governo dell’Opera, perché riconosceva che era un compito esclusivo del fondatore. Invece Escrivá gli chiedeva il parere su temi precisi, per raccogliere elementi sui quali riflettere. Sánchez Ruiz morì a Madrid il 30 novembre 1963 (cfr. Ramón Pereira, “Sánchez Ruiz, Valentín María”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, o.c., pp. 1108−1109).
[150] Pedro Poveda Castroverde era nato a Linares (Jaén) il 3 dicembre 1874. Il 17 aprile 1897 ricevette l’ordinazione sacerdotale. Fu professore nel seminario di Guadix, città nella quale aiutò i poveri e i bambini analfabeti. Tra il 1906 e il 1913 fu canonico a Covadonga (Asturie). La distanza che si era creata tra la fede e la ragione moderna era la sua preoccupazione dominante, che si concretò nella fondazione dell’Istituzione Teresiana. Nel 1911 aprì a Oviedo un’Accademia Femminile per Normaliste (allieve magistrali), la prima delle Accademie Teresiane. Nel 1924 la Istituzione Teresiana fu approvata come Pia Unione di fedeli. Poveda fu nominato cappellano d’onore della Reale Cappella a Madrid. Durante la Seconda Repubblica spagnola collaborò con le istituzioni nate per proteggere l’insegnamento cattolico nelle scuole, come S.A.D.E.L. (Società Anonima di Insegnamento Libero) o Los Cruzados de la Enseñanza [I percorsi dell’Insegnamento]. Era anche segretario della Procappellanía Mayor, dalla quale dipendevano i patronati reali. Il 28 luglio 1936 morì assassinato nel cimitero dell’Est. Il Papa Giovanni Paolo II lo canonizzò il 4 maggio 2003. Cfr. “Breve noticia biográfica del Autor”, in Pedro Poveda, Obras, I, Creí, por esto hablé, vol. III (1931−1936), Narcea, Madrid 2005, p. 1397.
[151] Juan Postius Sala era nato l’8 luglio 1876 a Berga (Barcelona). Prese i voti nella Congregazione dell’Immacolato Cuore di Maria nel 1894. Diventò dottore in utroque iure a Roma. Svolse diverse mansioni di governo nella sua istituzione. Divulgò la devozione alla Madonna mediante i congressi mariani internazionali. La sua opera più nota è El Código canónico aplicado a España (Corazón de María, Madrid 1926). Morì il 23 agosto 1952 a Solsona (Lérida). Cfr. Tomás Luis Pujadas, El Padre Postius: un hombre para la Iglesia, Claret, Barcelona 1981.
[152] Cfr. Ricordo di José Romeo Rivera, Siviglia, 27−III−1976, AGP, serie A.5, 242−2−5; e AGP, serie A.1, 6−4−1, serie A.3, 179−1−5, e serie A.3, 179−1−6.
[153] Cfr. Pedro Rodríguez, “Apuntes íntimos (opera inedita)”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, o. c., pp. 133−134.
[154] Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 615.
[155] Apuntes íntimos, n. 140 (27−XII−1930), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., III, o. c., p. 302, nt. 126.
[156] Apuntes íntimos, n. 147 (27−XII−1930), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 615.
[157] Apuntes íntimos, n. 144 (27−XII−1930), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 615.
[158] Cfr. Julián Cortés−Cavanillas, “Mi amigo el Padre Escrivá”, in ABC, 14−IX−1986, p. 52.
[159] Cfr. Apuntes íntimos, n. 766 (30−VI−1932), in Positio..., o.c., p. 329.
[160] Cfr. Crónica 1985, p. 604 (AGP, Biblioteca, P.01).
[161] Apuntes íntimos, n. 766 (30−VI−1932), in Positio..., o.c., p. 329. Le «attività a favore delle missioni degli infedeli» erano un’usanza dell’epoca, che riguardava la collaborazione con le missioni in terre dove non era stata predicata la dottrina cristiana. Le «propagande» erano i modi per fare arrivare il messaggio cristiano attraverso pubblicazioni e iniziative benefico−sociali.
[162] Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., pp. 514−515.
[163] «Spero che Gesù ci darà il suggerimento preciso per cominciare come Egli vuole» (Apuntes íntimos, n. 770 [11−VII−1932], in Positio..., o. c., p. 329).
[164] Apuntes íntimos, n. 808 (12−VIII−1932), in Positio..., o.c., p. 343. Non abbiamo trovato riferimenti archivistici o bibliografici sull’associazione dei claretiani.
[165] L’idea non era completamente nuova. Due anni prima aveva scritto: «Non c’è nulla in contrario nel dare ad alcune delle nostre case un carattere simile, esteriormente, a un Ateneo, a un Circolo di belle arti, ecc.» (Apuntes íntimos, n. 39 [15−VI−1930]); sul ruolo dei sacerdoti in queste attività, aveva annotato che «saranno solamente —e non è poco— Direttori di Anime» (Apuntes íntimos, n. 158, [II−1931], in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 615−616).
[166] Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 617.
[167] Cfr. epistolario in AGP, serie A.6, 408−2.
[168] Apuntes íntimos, n. 835 (28−IX−1932), in Positio..., o. c., p. 343. Non conosciamo le idee apportate da Martínez de Muñecas; alcuni mesi dopo la corrispondenza tra i due cessò, senza che risulti che si sia arrivato a qualcosa di concreto.
[169] Apuntes íntimos, n. 837 (29−IX−1932), in Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 533, nt 159 (per errore Vázquez de Prada trascrisse “p. Postius” invece di “p. Poveda”). I consigli che gli poteva dare Poveda provenivano da una persona assai esperta. A Madrid l’Accademia delle teresiane si trovava in calle Alameda 7. Durante il 1932 si era trasferita in calle O’Donnell 7; poi, nel 1933, al Paseo del Prado 14, col nome di “Veritas. Academia Femenina”.
[170] Apuntes íntimos, n. 746 (1−VI−1932), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 494.
[171] Apuntes íntimos, n. 1642 (6−X−1932), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 496.
[172] Il fondatore aggiunse subito l’altra invocazione a tre apostoli, e così si formarono le invocazioni a San Michele e San Pietro, a San Gabriele e San Paolo, e a San Raffaele e San Giovanni. Fin dall’inizio José María Escrivá pensava alle persone che sarebbero entrate nell’Opus Dei con vocazione al matrimonio; questa realtà si poté concretare nel 1948, con l’approvazione della Santa Sede (cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., III, o.c., pp. 141−148).
[173] Apuntes íntimos, n. 1697 (10−X−1932), in Positio..., o. c., pp. 335 e 349.
[174] Ibidem.
[175] Ibidem.
[176] Apuntes íntimos, n. 1697 (10−X−1932), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 534, nt. 161.
[177] L’idea appare annotata già il 10 febbraio 1932 (cfr. Escrito para Carmen Cuervo, in AGP, serie A.3, 175−6−4).
[178] Ricordo di Juan Jiménez Vargas, Pamplona, 1−X−1976, in AGP, serie A.5, 221−1−2.
[179] Apuntes íntimos, n. 834 (28−IX−1932), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 487.
[180] Modesta Cabeza Cobos era nata in novembre del 1902. Studiò nel conservatorio di Madrid. Conobbe il fondatore dell’Opera nel confessionale di Santa Isabel. All’inizio della guerra civile subì un forte shock vedendo l’incendio di una chiesa; fu un colpo che poi si trasformò in una turba psichica permanente. Morì a Ciempozuelos (Madrid) il 4 novembre 1971. Cfr. Gloria Toranzo, “Los comienzos del apostolato del Opus Dei entre mujeres (1930−1939)”, o. c., pp. 61−64; e Ricordo di Braulia García Escobar, Hornachuelos, 29−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 213−3−12.
[181] Hermógenes García Ruiz era nata il 25 aprile 1897. Lavorò come dattilografa nella sede di Madrid di una ditta tedesca. Certe volte copiava a macchina «alcuni fogli con scalette che l’aiutavano a fare la meditazione e dove si trascrivevano anche gli argomenti spirituali appuntati durante le riunioni [con Escrivá] alle quali assisteva» (Ricordo di Braulia García Escobar, Hornachuelos, 29−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 213−3−12). Durante la guerra civile mantenne i contatti con la madre e la sorella di don José María. Morì il 27 marzo 1974. Cfr. Gloria Toranzo, “Los comienzos del apostolado del Opus Dei entre mujeres (1930−1939)”, o. c., pp. 55−60; e Ricordo di Natividad González Fortún, Madrid, 4−IX−1975, in AGP, serie A.5, 217−1−3.
[182] Jenaro Lázaro Gumiel era nato a Villaluenga (Saragozza) il 20 ottobre 1901. Studiò nell’Istituto Cattolico di Arti e Industrie (I.C.A.I.) di Madrid, acquisendo il titolo di aiutante tecnico elettricista. Fu poi alunno esterno della Scuola di San Fernando. Sino alla guerra civile lavorò nelle ferrovie spagnole. Divenne un celebre scultore di immagini processionali e di pezzi di oreficeria. Morì a Codosera (Badajoz) il 15 settembre 1977. Cfr. “Genaro [sic] Lázaro Gumiel”, in Antonio Bonet Salamanca, Escultura procesional en Madrid (1940−1990), Pasos, Madrid 2009, pp. 143−144.
[183] In ottobre scrisse: «24−X−1932: Questa mattina mi sono raccomandato al Sto. [Santo] Arcangelo, sollecitandolo a farci cominciare presto questa parte dell’O. [Opera]»: Apuntes íntimos, n. 851 (24−X−1932), in Positio..., o. c., p. 335. Nel calendario liturgico allora vigente il 24 ottobre era la festa dell’Arcangelo San Raffaele.
[184] Apuntes íntimos, n. 884 (2−XII−1932), in Andrés Vázques de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 507. Una copia del contratto si trova in AGP, serie A.1, 5−2−12. Un dettaglio aneddotico: la famiglia Escrivá Albás non aveva telefono. Se don José María doveva telefonare, usava «il telefono del bar che stava sotto l’appartamento in cui abitava» (Ricordo di José María González Barredo, Washingron D. C., 25−V−1976, in AGP, serie A.5, 216−1−11).
[185] Escrivá andava per la catechesi e le confessioni delle bambine in occasioni precise, perché quella scuola aveva un proprio cappellano. Cfr. Ricordo di Pilar Crespí de Valldaura y Liniers, Madrid, 9−X−1975, in AGP, serie A.5, 206−2−5.; e Beatriz Comella Gutiérrez, Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid (1931−1945), o. c., pp. 177−180.
[186] Cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 544.
[187] Sul significato e la varietà dei suoi scritti, cfr. José Luis Illanes, “Obra escrita y predicación de san Josemaría Escrivá de Balaguer”, Studia et Documenta 3 (2009) 203−276.
[188] Apuntes íntimos, n. 218 (7−VIII−1931), in Amadeo de Fuenmayor, Valentín Gómez−Iglesias, José Luis Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei, o.c., p. 21.
[189] Cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Santo Rosario. Edición crítico−histórica preparada por Pedro Rodríguez, Constantino Ánchel y Javier Sesé, Rialp, Madrid 2010, pp. 3−5.
[190] Sulla stampa del testo, cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Santo Rosario. Edición crítico−histórica, o.c., pp. 8−9. Il testo al ciclostile si trova in AGP, serie A.3, 102−2−1, e l’originale in AGP, serie A.3, 102−3−1. Il ciclostile era una copiatrice ad alcool, una macchina rudimentale che funzionava con una pasta di glicerina o gelatina posta su un vassoio della grandezza del foglio sul quale andava passando la carta che rimaneva stampata con un colore violaceo. Pepe Romeo possedeva un ciclostile che fu utilizzato in diverse occasioni per stampare documenti dell’Opera.
[191] Cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o. c., p. 28.
[192] Cfr. AGP, serie A.3, 102−2−1, per Santo Rosario; e AGP, serie A.3, 96−1−1 per Consideraciones espirituales.
[193] Scritto a Pedro Cantero, 19−II−1932, in AGO, serie A.3, 175−6−3.
[194] Apuntes íntimos, n. 863 (6−XI−1932), Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., p. 833.
[195] Juan Jiménez Vargas era nato a Madrid il 24 aprile 1913. Iniziò gli studi universitari nel 1928, laureandosi nel giugno del 1935 e ottenendo poi il titolo di dottore in medicina il 26 luglio 1940. Fu professore ordinario di Fisiologia all’Università di Barcellona (luglio 1942) e all’Università di Navarra (1954). A Pamplona avviò la Facoltà di Medicina, della quale fu decano. Morì il 29 aprile 1997. Cfr. AGUCM, Expedientes Medicina, M−352, 9; Francisco Ponz − Onésimo Díaz, “Juan Jiménez Vargas (1913−1997)”, Studia et Documenta 5 (2011) 229−260.
[196] Racconto autobiografico di Juan Jiménez Vargas, Madrid, 15−II−1934, in AGP, serie A.2, 34−3−1. Ricordiamo che dal mese di settembre del 1932 Adolfo Gómez Ruiz era esiliato a Villa Cisneros per aver partecipato alla bravata.
[197] Alla fine del 1932 Valentín fu presentato al fondatore da Juan Jiménez Vargas nell’appartamento di Martínez Campos (cfr. Ricordo di José María Valentín, Toledo, 31−XII−1975, in AGP, serie A.5, 251−1−5). José María Valentín y Fernández de la Hoz era nato a Madrid il 19 dicembre 1914. Era un medico oculista. Morì nel 2004.
[198] Racconto autobiografico di Juan Jiménez Vargas, Madrid, 15−II−1934, in AGP, serie A.2, 34−3−1. Dell’Asilo di Porta Coeli si parlerà più avanti.
[199] Cfr. Ricordo di Luis Sevilla González, Betanzos (La Coruña), 18−IV−1978, in AGP, serie A.5, 246−1−8.
[200] Ricordo di sor Severina Casado Yagüe, in AGP, serie A.5, 203−1−10. In quegli anni la Casado lavorava come domestica della famiglia Sevilla.
[201] Apuntes íntimos, n. 647 (11−III−1932), in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., p. 587.
[202] Apuntes íntimos, n. 883 (28−XI−1932), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 507. Questa scuola del Patronato de Enfermos stava sotto casa sua nella calle de Viriato.
[203] Ricordo di la Hermana San Pablo (María Auxiliadora) Lemus y González de la Rivera (senza data), in AGP, serie A.5, 222−3−2.
[204] Cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 628, nt. 27. Juan Francisco Morán Ramos era nato a Manzano (Salamanca) nel 1874. Dottore in Giurisprudenza e in Diritto Canonico, fu vicario generale della diocesi di Madrid−Alcalá dal 1927 fino alla sua morte, avvenuta nel 1943. Cfr. Santiago Casas Rabasa, “Las relaciones escritas...”, o. c., p. 372.
[205] Apuntes íntimos, n. 907 (19−I−1933), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 508.
[206] Ricordo di la Hermana San Pablo (María Auxiliadora) Lemus y González de la Rivera (senza data), in AGP, serie A.5, 222−3−2.
[207] Ricordo di la Hermana Pilar Ángela Hernando Carretero, Caldas de Reyes, 3−V−1977, in AGP, serie A.5, 219−2−5.
[208] Ángel Cifuentes Martín era nato a Villalpando (Zamora) il 23 settembre 1913. Cominciò gli studi di Medicina a Madrid nel 1930 e li terminò dopo la guerra civile. Durante gli anni della Repubblica ricevette la direzione spirituale da José María Escrivá.
[209] Joaquín Herrero Fontana era nato il 29 settembre 1914 a Logroño. Anch’egli iniziò gli studi di Medicina nel 1930 e si laureò nel 1935. Durante la guerra civile nascose José María Escrivá nel sanatorio per malati mentali di un suo amico medico, Ángel Suils. Esercitò come medico ginecologo. Morì il 20 novembre 1992.
[210] Aurelio Torres−Dulce Ruiz era nato a Vellisca (Cuenca) il 14 ottobre 1915. Cominciò gli studi di medicina nell’anno accademico 1931−1932 e li terminò nel 1940. Morì il 17 dicembre 2002.
[211] Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., pp. 508−509.
[212] Ricordo di la Hermana María Auxiliadora Lemus y González de la Rivera (senza data), in AGP, serie A.5, 222−3−2.
[213] Ricordo di José Ramón Herrero Fontana, Madrid, 1−III−1979, AGP, serie A.5, 7−3−4.
[214] Ricordo di la Hermana San Pablo (María Auxiliadora) Lemus y González de la Rivera (senza data), in AGP, serie A.5, 222−3−2.
[215] “Catecismo. Catequesis” (senza data), in AGP, serie A.2, 40−1−6.
[216] Cfr. “Orden de la Catequesis” (senza data), in AGP, serie A.2, 40−1−6.
[217] Cfr. Ricordo di Braulia García Escobar, Hornachuelos, 29−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 213−3−12.
[218] Ricordo di Juan Jiménez Vargas, Madrid, 22−II−1985, in AGP, serie A.5, 221−1−2.
[219] Cfr. Apuntes íntimos, n. 913 (25−I−1933), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 509.
[220] Vicente Hernando Bocos era nato il 5 novembre 1909. Nel 1933 era il presidente dell’Associazione degli Studenti Cattolici di Medicina. Dopo la guerra civile esercitò la professione medica. Morì a San Esteban de Gormaz (Soria) l’8 maggio 2001. Cfr. Ricordo di Vicente Hernando Bocos, Palencia, 3−IX−1975, in AGP, serie A.5, 219−2−4.
[221] Cfr. “Obra de San Rafael hasta fin del curso 34−35” (senza data), in AGP, serie A.2, 40−1−2 (questo documento è stato pubblicato e commentato da Fernando Crovetto, “Los inicios de la obra de San Rafael. Un documento del 1935”, Studia et Documenta 6 [2012] 395−412). Alcuni anni dopo Valentín ricorderà «i tempi di Porta Coeli per il freddo che faceva» (Diario de Ferraz, 18−XI−1935, p. 37).
[222] Riassunto dei primi Circoli di San Raffaele, p. 2, in AGP, serie A.2, 40−1−1.
[223] Ibidem, pp. 2−3.
[224] Cfr. Ricordo di Juan Jiménez Vargas, Madrid, 22−II−1985, in AGP, serie A.5, 221−1−2.
[225] Appunti di una riunione di famiglia, 19−II−1975, in Catequesis en América, vol. III, p. 278 (AGP, Biblioteca, P.04). Probabilmente utilizzò una pisside e non un ostensorio, perché fu un’esposizione minore.
[226] Jacinto Valentín y Fernández de la Hoz era nato a Madrid l’11 novembre 1916. Si era iscritto alla Facoltà di Diritto nel 1934. Villeggiava con i suoi genitori e il fratello a Boecillo (Valladolid). Morì all’inizio della guerra civile, nel mese di agosto del 1936.
[227] Eloy González Obeso era nato a Reinosa (Cantabria) nel 1913. Cominciò gli studi di Medicina nell’anno accademico 1929−1930. Nel 1934 si trasferì a Barcellona per finire lì gli studi. Ricevette il titolo di Odontologo il 18 gennaio 1936. Morì nel 1975.
[228] Jaime Munárriz Escondrillas era nato a Cascante (Navarra) il 18 giugno 1915. Iniziò gli studi di Medicina a Madrid nel 1931. Durante gli anni accademici 1934−1935 e 1935−1936 rimase nel suo paese, facendo gli esami nella Università di Saragozza. Morì il 21 luglio 1936 nella guerra civile.
[229] Resoconto dei primi Circoli di San Raffaele, p. 12, in AGP, serie A.2, 40−1−1. Più tardi la lettura del resoconto della lezione precedente fu sostituita da un riepilogo orale.
[230] L’Imitazione di Cristo —scritto alla fine del XIV secolo o al principio del XV— aveva avuto numerose edizioni; è forse il libro di spiritualità più diffuso. Il libro del padre Sánchez Ruiz fu pubblicato come Catecismo social: sacado de documentos de la Santa Sede y de autores Católicos: para uso de personas adultas, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1933.
[231] Si conservano le tracce di tutte le lezioni di formazione, eccetto di due, delle quali si menziona soltanto il luogo, il giorno e i partecipanti (cfr. resoconto dei primi Circoli di San Raffaele, pp. 2−26, in AGP, serie A.2, 40−1−1).
[232] Ricordo di José María Valentín, Toledo, 31−XII−1975, in AGP, serie A.5, 251−1−5.
[233] Resoconto dei primi Circoli di San Raffaele, p. 12, in AGP, serie A.2, 40−1−1.
[234] Ibidem.
[235] “Obra de San Rafael hasta fin del curso 34−35”, di Juan Jiménez Vargas (senza data), in AGP, serie A.2, 40−1−2.
[236] Apuntes íntimos, n. 1029 (4−VII−1933), in Federico M. Requena, «San Josemaría Escrivá de Balaguer y la devoción al Amor Misericordioso (1927−1935)», Studia et Documenta 3 (2009) 169. Una copia di questo santino, che riproduce una scultura di Coullaut Valera, nella quale appare un Crocifisso con la sfera del mondo ai suoi piedi, si conserva in AGP, serie A.1, 6.2.1. Sul messaggio e la portata della devozione all’Amore Misericordioso, cfr. Federico M. Requena, Católicos, devociones y sociedad durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República: La Obra del Amor Misericordioso en España (1922−1936), Biblioteca Nueva, Madrid 2008. L’invocazione alla Vergine Maria come Nostra Signora della Speranza nell’attività con la gioventù, che don José María utilizzò dal mese di giugno del 1932, si è conservata come invocazione ordinaria nella vita dell’Opus Dei (cfr. Escrito de Juan Jiménez Vargas, 17−VI−1940, in AGP, serie A.3, 87−5−7).
[237] Resoconto dei primi Circoli di San Raffaele, p. 12, in AGP, serie A.2, 40−1−1.
[238] Luis de Azúa Dochao era nato il 24 giugno 1913 a Villa de Ves (Albacete). Frequentò l’Accademia DYA a Luchana e a Ferraz. Si laureò in Medicina. Nel 1946 ottenne la cattedra di Dermatologia all’Università di Saragozza. Morì il 15 settembre 1977.
[239] “San Rafael”, in AGP, serie A.2, 40−1−5 (sul retro di questo volantino si legge, in stampatello, l’invito a una riunione presieduta da Ángel Herrera Oria in occasione della giornata della Stampa Cattolica, che ebbe luogo giovedì 29 giugno 1933). Il “piccolo” dei Valentín era Jacinto; il suo incarico nelle missioni consisteva, probabilmente, nel raccogliere piccole quantità di denaro da inviare nei paesi di missione. “Proselitismo” significava avvicinare persone all’apostolato dell’Opus Dei. Questo termine non aveva l’odierna connotazione negativa. Per esempio, tre anni dopo Jiménez Vargas scriverà del suo desiderio di essere aiutato a installare qualche attrezzatura sportiva nella nuova residenza. E si espresse così: «Continuo a fare proselitismo per la palestra» (Diario di Ferraz, 9−VII−1936, p. 70a). Cfr. Javier López Díaz, “Proselitismo”, in Diccionario de San José María Escrivá de Balaguer, o. c., pp. 1029−1033).
[240] «San Rafael», in AGP, serie A.2, 40−1−5.
[241] José María González Barredo nacque a Colunga (Asturie) il 3 giugno 1906. Si laureò in Scienze Chimiche alla Università di Madrid. Durante la Seconda Repubblica fu professore nell’Istituto di Linares (Jaén) fino a giugno del 1933; tra il novembre di quell’anno e l’estate del 1935 fu destinato all’Istituto di Plasencia (Cáceres), anche se per qualche tempo si stabilì a Madrid per redigere la tesi dottorale. Conclusa la guerra civile, ottenne la cattedra di Fisica−Chimica all’Università di Saragozza. Nel 1946 andò a lavorare negli Stati Uniti, dove rimase per oltre quarant’anni. Morì a Pamplona il 28 novembre 1993. Cfr. Constantino Ánchel, “Fuentes para la historia de la Academia y de la Residencia DYA”, o. c., p. 76, nt. 27.
[242] Apuntes íntimos, n. 184 (25−III−1931), in Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 516.
[243] Il “Hogar Santa María” era una casa che ospitava i cattolici tedeschi che studiavano in Spagna. Era diretta da un sacerdote che nel 1935 si recò in visita alla Residenza DYA (cfr. Diario di Ferraz, 30−VI−1935, pp. 44−45).
[244] Ricordo di José María González Barredo, Washingron D. C., 25−V−1976, in AGP, serie A.5, 216−3−11.
[245] Cfr. José Miguel Pero−Sanz Elorz, Isidoro Zorzano Ledesma, o. c., pp. 144−145.
[246] Ricordo di Ricardo Fernández Vallespín, Madrid, 7−VII−1975, in AGP, serie A.5, 211−2−1.
[247] Ricardo Fernández Vallespín era nato a El Ferrol (La Coruña) il 23 settembre 1910. Tra il 1928 e il 1934 frequentò i corsi di Architettura nella Scuola Superiore di Madrid. Nel dicembre del 1934 fu nominato aiuto della Scuola Superiore di Architettura di Madrid. Alla fine della guerra civile progettò e diresse la costruzione di diversi edifici del Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica, sempre a Madrid. Ricevette l’ordinazione sacerdotale nel 1949. Nel marzo dell’anno dopo, su richiesta del fondatore, partì per l’Argentina per iniziarvi l’attività apostolica dell’Opus Dei. Nel 1962 ritornò in Spagna, dove continuò la sua attività pastorale. Morì il 28 luglio del 1988. Cfr. José Luis González Gullón, “Fernández Vallespín, Ricardo”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, o. c., pp. 501−502.
[248] Ricordo di Ricardo Fernández Vallespín, Madrid, 7−VII−1975, in AGP, serie A.5, 211−2−1.
[249] Ibidem. Don José María aveva fatto anche una versione di questa preghiera in chiave mariana: «Non mi abbandonare, Madre! Fa’ che io cerchi tuo Figlio, fa’che io trovi tuo Figlio, fa’ che io ami tuo Figlio... con tutto il mio essere! Ricordati, Madonna, ricordati» (Apuntes íntimos, n. 122 [8−XII−1930], in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o.c., p. 554).
[250] Scritto di Ricardo Fernández Vallespín (senza data), in AGP, serie A.2, 7−3−1.
[251] Ricordo di Ricardo Fernández Vallespín, Madrid, 7−VII−1975, in AGP, serie A.5, 211−2−1.
[252] Ibidem.
[253] Manuel Sainz de los Terreros Villacampa era nato a Solares (Cantabria) il 12 agosto 1907. Collaborò all’apertura dell’Accademia e della Residenza DYA. Nel 1937 passò dalla zona repubblicana a quella nazionalista attraverso i Pirenei insieme a José María Escrivá. A partire dall’ottobre 1938 mantenne contatti più sporadici con l’Opera, della quale fu cooperatore sino alla fine della sua vita. Lavorò come ingegnere a Pamplona. Morì il 18 giugno 1995.
[254] Scritto di Manuel Sainz de los Terreros, Madrid, 25−IV−1934, in AGP, serie A.5, 243−3−4.
[255] Ibidem.
[256] Cfr. Apuntes íntimos, n. 952 (19−III−1933), in Flavio Capucci, “Croce e abbandono. Interpretazione di una sequenza biografica (1931−1935)”, in AA.VV., San Josemaría Escrivá. Contesto Storico. Personalità. Scritti, Università della Santa Croce, Roma 2003, p. 166, nt. 33.
[257] Ricordo di Santiago Escrivá de Balaguer, Madrid, 10−II−1979, in AGP, serie A.5, 210−1−5.
[258] Ibidem.
[259] Ricordo di José María González Barredo, Washington D. C., 25−V−1976, in AGP, serie A.5, 216−3−11. González Barredo si trovava a Madrid dall’aprile del 1933, avendo terminato le sue lezioni nell’Istituto di Linares. Nell’estate di quell’anno andò a vivere in una pensione situata in calle Luchana.
[260] Ricordo di Juan Jiménez Vargas, Madrid, 22−II−1985, in AGP, serie A.5, 221−1−2.
[261] «Le Norme provvisorie furono scritte dal fondatore il 24−III−1933, festa di san Gabriele (Apuntes, n. 966). Nascono da una sintesi del piano di norme di pietà che aveva scritto durante il ritiro spirituale del 1932 a Segovia» (Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o.c., p. 537, nt. 204). Esiste una copia dattilografata delle “Norme provvisorie” in AGP, serie A.2, 7−3−5 (il documento non è datato, salvo un’aggiunta di ottobre 1933).
[262] Per esempio, cfr. Pedro Poveda, Plan de vida. Colección de Instrucciones, Reglas prácticas y Consideraciones devotas, Publicaciones de la Institución Teresiana, Madrid 19649 (la prima edizione è del 1910). I ragazzi che ricevettero la formazione spirituale di Escrivá utilizzavano l’espressione “piano di vita” abitualmente: Cfr. Lettera di Ángel Cifuentes Martín a José María Escrivá, Villalpando (Zamora), 30−VI−1933, in AGP, serie A.6, 372−2.
[263] Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore..., I, o. c., p. 519. Il fondatore dell’Opera considerava il piano di vita una realtà onnicomprensiva, che favorisce l’unione con Dio nelle diverse attività della giornata. Cfr. Elena Álvarez, “Plan de vida”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, o. c., pp. 977−980.
[264] La Chiesa raccomandava un piano di vita simile al clero secolare e ai fedeli devoti. José María Escrivá osservava queste pratiche da quando era adolescente. Cfr. Ramón Herrando Prat de la Riba, Los años de seminario de Josemaría Escrivá a Zaragoza (1920−1925), o. c., p. 268.
[265] Le preci dell’Opera contengono una serie di testi tratti dalla Sacra Scrittura e dalla Liturgia della Chiesa (cfr. AGP, serie A.3, 7−3−5). Le prime copie delle “Preces ab Operis Dei sociis recitandae” sono del novembre 1930 (cfr. AGP, serie A.3, 87−6−1).
[266] Il piano di vita contiene in più la confessione sacramentale ogni settimana, l’offerta di una mortificazione il sabato, il ritiro mensile quando possibile e l’impegno a mantenere sempre vivo il rapporto con Dio; nel documento appaiono anche altre norme di carattere pratico come la collocazione di una immagine della Madonna in camera da letto o avvisare quando si era malati per poter essere accuditi (cfr. AGP, serie A.2, 7−3−5).
[267] Cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico−histórica, o. c., p. 287, dove si commenta il punto 76 di Cammino: «Se non hai un piano di vita, non avrai mai ordine».
[268] Ricordo di Benilde García Escobar, Hornachuelos, 25−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 213−3−11.
[269] Cfr. Ricordo di Braulia García Escobar, Hornachuelos, 29−VIII−1975, in AGP, serie A.5, 213−3−12. Nel settembre del 1933 María Ignacia García Escobar morì e le sue due sorelle lasciarono Madrid, interrompendo così ogni rapporto con Escrivá.
[270] Cfr. Ricordo di Santiago Escrivá de Balaguer, Madrid, 10−II−1979, in AGP, serie A.5, 210−1−5.
[271] Blas Romero Cano era nato il 1° marzo 1882 a Membrilla (Ciudad Real). Fu ordinato il 25 maggio 1907. Lavorò in varie parrocchie di Ciudad Real fin quando si trasferì a Madrid. Nel 1929 ricevette la nomina a cappellano della parrocchia di Santa Bárbara. Diede lezioni di canto nella Residenza DYA. Dopo la guerra civile ritornò a Ciudad Real. Morì il 28 marzo 1958. Cfr. Jaume Aurell — José Luis González Gullón, “Josemaría Escrivá en los años treinta: los sacerdotes amigos”, o. c., pp. 55−58.
[272] Apuntes íntimos, n. 1035 (VII−1933), in Positio..., o. c., p. 346. Nella stanza dove si riunivano c’era un quadro della Madonna col Bambino, che ora presiede l’Oratorio di Santa María, Stella Orientis, nella Curia della Prelatura dell’Opus Dei a Roma. Cfr. Crónica VI−1955, pp. 59−60 (AGP, Biblioteca, P.01).
[273] Pedro Cantero Cuadrado, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un hombre de Dios, o.c., p. 25.
[274] I fascicoli si trovano in AGP, serie A.3, 96−1−2. Questa edizione del 1933 s’intitola Consejos espirituales −Consideraciones espirituales. In questo periodo trascrisse una serie di 112 brani della Scrittura, che utilizzava per la sua orazione e per la sua predicazione. Cfr. Francisco Varo, “San Josemaría Escrivá de Balaguer. ‘Palabras del Nuevo testamento, repetidas veces meditadas. Junio − 1933”, Studia et Documenta 1 (2007) 259−286.
[275] Cfr. Lettera di Isidoro Zorzano a José María Escrivá, Málaga, 22−VII−1933, in AGP, IZL, C 330722.