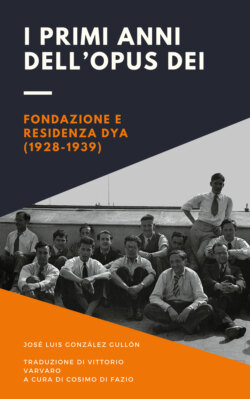Читать книгу I primi anni dell'Opus Dei - José Luis González Gullón - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRESENTAZIONE
ОглавлениеJosemaría Escrivá de Balaguer ha diffuso il messaggio dell’Opus Dei fin dalla sua fondazione, il 2 ottobre 1928[1]. Presto formò piccoli gruppi di studenti, laureati, impiegati, artigiani, lavoratori manuali e sacerdoti. Cinque anni più tardi aprì a Madrid un’accademia per l’approfondimento degli studi universitari, l’Accademia DYA. L’intenzione di questo progetto era di trasmettere lo spirito dell’Opera, specificamente agli studenti e ai laureati. Nel 1934 l’iniziativa si ampliò con la creazione di una residenza universitaria, l’Accademia—Residenza DYA, attiva per due anni accademici, fino allo scoppio della guerra civile spagnola nel luglio del 1936.
La storia della DYA aiuta a capire la figura di Josemaría Escrivá de Balaguer e il modo in cui comunicava il messaggio dell’Opera. Nell’accostarci a quegli anni, ci addentriamo in un periodo appena successivo alla fondazione, ad anni in cui il fondatore riceveva quelle che poi chiamò “particolari luci di Dio”.
Frequentavano l’Accademia -Residenza molte persone con cui il fondatore era entrato in contatto. Si trattava soprattutto di studenti universitari che si ritrovarono, negli anni della Seconda Repubblica spagnola (1934−1936), in un contesto di grandi passioni e di grandi agitazioni, di confronti socio-politici sempre più aspri.
In questo libro analizzeremo il duplice soggetto storico che caratterizzò DYA. Per un verso, l’Accademia-Residenza fu il luogo dove si svolgeva l’attività accademica e residenziale; per un altro, fu l’ambito in cui Josemaría Escrivá de Balaguer diffuse il messaggio dell’Opus Dei. Questo duplice aspetto —che si svelerà progressivamente, man mano che illustreremo attività accademiche, scientifiche e formative— influenzerà successivamente alcune caratteristiche dell’Opera. Certamente la storia dell’Accademia-Residenza fu una realtà circoscritta, soprattutto se paragonata alle vicende della Spagna e della Chiesa in quei tempi, su cui faremo delle digressioni di micro-storia, ma si tratta di una vicenda emblematica per comprendere l’avvio dell’apostolato dell’Opus Dei.
Dopo la guerra civile spagnola le persone dell’Opera aprirono alcune residenze universitarie, come quella di Jenner (Madrid, 1939), Samaniego (Valencia, 1940) o Zurbarán (Madrid, 1945). A metà degli anni quaranta del secolo scorso l’Opus Dei si diffuse nei cinque continenti e contemporaneamente furono inaugurate diverse residenze, tuttora esistenti, come la Residenza Universitaria Panamericana (Città del Messico, 1949), la RUI (Roma, 1958) Althaus (Bonn, 1959), Ashwell House (Londra, 1962), Los Aleros (Buenos Aires, 1963) o Warrane College (Sydney, 1971).
Su DYA finora erano stati pubblicati brevi studi, nelle biografie sul fondatore e nelle storie dell’Opera, tra cui spicca la monografia di John Coverdale sui primi anni dell’Opus Dei[2]. Esistono anche due ricerche specifiche: una panoramica della documentazione dell’Archivio Generale della Prelatura su DYA e la pubblicazione delle lettere di un residente ai suoi genitori[3]. Sono stati inoltre pubblicati diversi documenti e racconti della vita di Escrivá de Balaguer in quegli anni, in particolare i suoi appunti sui rapporti intercorsi col vicario generale della diocesi di Madrid-Alcalá, e le ricerche relative al suo lavoro pastorale nel Patronato di Santa Isabel[4].
La nostra monografia è pensata per un pubblico non particolarmente esperto delle vicende della Seconda Repubblica spagnola né della storia dell’Opus Dei. Si consiglia in tal senso la lettura del dizionario dedicato al fondatore dell’Opera[5] e della sua biografia scritta da Andrés Vázquez de Prada[6]. Il dizionario presenta sinteticamente molti aspetti della vita e del messaggio di Josemaría Escrivá de Balaguer; a sua volta, la biografia analizza dettagliatamente la vita spirituale del fondatore —ciò che la Chiesa chiama santità di vita che culminò nel 2002 con la canonizzazione—, aspetto chiave e imprescindibile per chi vuole capire la forza con cui operò Josemaría Escrivá nella diffusione dell’Opus Dei.
Per la metodologia adottata, questo testo può inserirsi, in buona misura, negli studi di storia culturale e religiosa, soprattutto nell’analisi del contesto universitario dell’epoca e nei risvolti sociologici e prosopografici.
Dato che l’oggetto storico del libro è l’Accademia - Residenza DYA, il lettore non troverà una biografia di Josemaría Escrivá de Balaguer, e neppure una storia dell’Opus Dei tra gli anni 1933 e 1936, anche se buona parte della vita del fondatore e del suo messaggio si intrecciò con la storia di DYA. Per questa ragione, non analizzeremo la sua tesi dottorale né i suoi impegni pastorali o l’insieme delle persone che trattava, a voce o per corrispondenza[7]. Tuttavia, ricorderemo le persone che frequentarono DYA e a piè di pagina riporteremo i dati biografici di chi ebbe un più stretto rapporto con il fondatore.
Gli scenari spaziali e cronologici nei quali ci muoveremo sono ben delimitati. Apre il libro un capitolo che analizza gli anni precedenti l’apertura di DYA (1927−1933). Dopo alcuni brevi riferimenti all’Università di Madrid e al ruolo degli intellettuali spagnoli in quell’epoca, si illustra il contesto nel quale nacque, nella mente del fondatore, l’idea di aprire un’accademia universitaria.
Dopo, il secondo capitolo inizia illustrando il mondo studentesco di allora, per passare poi all’Accademia DYA, che, tra il dicembre del 1933 e il settembre del 1934, aveva sede in calle Luchana 33.
Il terzo capitolo è dedicato all’anno accademico 1934−1935, primo anno dell’Accademia-Residenza in calle Ferraz 50. Come introduzione, basta una breve panoramica sul ruolo delle residenze universitarie in quel periodo di crescente tensione sociale. Successivamente, analizzeremo in dettaglio l’evoluzione di DYA, sia negli aspetti didattici e residenziale, lezioni nell’Accademia e vita della Residenza, sia in quelli formativi cristiani.
L’anno accademico 1935−1936 è l’oggetto del quarto capitolo. Si metterà in rilievo il successo della Residenza DYA, con l’affluenza di numerosi universitari, sullo sfondo di una crisi molto complessa per l’Università e per la società spagnola in genere.
Il quinto capitolo comincia con la descrizione della situazione socio-politica spagnola nella primavera del 1936. Quindi, si spiegano i motivi per cui DYA, nel mese di luglio, cambiò sede. Infine si illustra lo stato in cui si ritrovò la casa durante la guerra civile spagnola.
Questo libro è stato scritto sulla base delle fonti disponibili, abbondanti per alcuni argomenti, scarse per altri. Le fonti primarie provengono dall’Archivio Generale della Prelatura dell’Opus Dei. Tra esse, il diario di DYA —che ci è servito per strutturare il libro— è una ricca risorsa storica. Spesso siamo riusciti a rimanere dietro agli avvenimenti, lasciando che fosse il redattore del diario a raccontare, col suo stile personale, quali furono le persone o le vicende di maggior rilievo. Inoltre, sono risultati utili gli schemi per le lezioni di formazione cristiana impiegati dal fondatore dell’Opera, i riassunti delle riunioni del primo Consiglio dell’Opera e la corrispondenza di Josemaría Escrivá de Balaguer, degli altri membri dell’Opera e di alcune persone conosciute.
Abbiamo consultato anche alcuni archivi statali di Madrid. Tra le fonti secondarie, sono stati estremamente preziosi i ricordi delle persone che frequentarono il fondatore[8]. Abbiamo anche potuto intervistare, prima che morissero, José Ramón Herrero Fontana e Javier Lahuerta Vargas, che avevano frequentato l’Accademia-Residenza.
Infine, descriviamo il diario dell’Accademia−Residenza, che è stata la fonte essenziale per il nostro studio.
Josemaría Escrivá de Balaguer era ben consapevole che stava contribuendo alla nascita di un nuovo fenomeno pastorale nella vita della Chiesa. Per questo motivo archiviò, per quanto possibile, i resoconti degli avvenimenti. A tal riguardo, affidò ai suoi Apuntes íntimos[9] e ad altri scritti personali, gli aspetti che riguardavano il progresso interno dell’Opus Dei, segnato da luci e mozioni che, come diceva, Dio gli andava concedendo. Dopo, quando si aprì l’Accademia DYA, il fondatore stabilì che si scrivesse un diario, affinché rimanesse memoria degli avvenimenti significativi, anche se minimi, della vita quotidiana[10] (gli faceva piacere pure che si facessero delle fotografie, per conservare alcuni documenti visivi per i posteri[11]). Come scrisse un mese più tardi, «di tutto l’apostolato esterno dell’Opera di Dio di solito non prenderò nota. Se ne occupano i ragazzi»[12]. Infatti i membri dell’Opera si avvicendavano nell’annotare anche solo qualche riga su ciò che avveniva ogni giorno[13].
In questo modo scrissero cinque quaderni, che costituiscono il Diario di DYA, tra il 1933 e il 1936[14]:
Diario 1, intitolato “Quaderno N. 1. Diario della Casa dell’Angelo Custode, che riguarda il periodo tra il 15 novembre 1933 e il 2 settembre 1934[15]. Si compone di 223 pagine: 206 seguite da altre 17 intercalate. Si cominciò a scrivere il 25 gennaio 1934 —ricostruendo a memoria quello che era successo nelle prime settimane— e si concluse il giorno 26 febbraio[16]. La finalità del diario, come è detto all’inizio, è che si possa «sapere come questa [iniziativa] era cominciata, e di quali mezzi si era avvalso il Signore per la sua O. [Opera]»[17]. Manuel Sainz de los Terreros scrisse il diario dal 15 novembre 1933 al 5 luglio 1934 e Ricardo Fernández Vallespín continuò la redazione tra il 15 luglio e il 2 settembre 1934.
Diario 2, intitolato “Quaderno N. 2. Diario della Casa dell’Angelo Custode”, compilato fra il 3 settembre 1934 e il 5 aprile 1935. Contiene 206 pagine: 201 seguite da altre 5 intercalate. Ricardo Fernández Vallespín vi scrisse dal 3 settembre al 16 ottobre 1934; Manuel Sainz de los Terreros gli subentrò dal 19 ottobre 1934 al 9 aprile 1935.
Diario 3, intitolato “Quaderno N. 3. Diario della Casa dell’Angelo Custode”, scritto tra il 10 aprile e il 15 settembre 1935. Sono 107 pagine: 91 di fila più 16 aggiunte. Lo scrissero Manuel Sainz de los Terreros dal 10 aprile al 19 maggio 1935; Ricardo Fernández Vallespín, dal 9 giugno al 15 settembre 1935; e Julio Roca, dal 9 agosto al 20 agosto 1935. Vi sono inoltre tre annotazioni isolate di Fernández Vallespín: una del settembre 1935, senza data; un’altra del 20 ottobre 1935 e una terza del 28 gennaio 1936.
Diario 4, intitolato “Diario N. 3” [sic]. Sono 181 pagine, scritte tra il 24 settembre 1935 e il 3 maggio 1936. I redattori del diario furono: Álvaro del Portillo, dal 24 settembre al 12 novembre 1935; Juan Jiménez Vargas, dal 14 novembre al 4 dicembre 1935; Álvaro del Portillo, dal 5 dicembre 1935 al 22 gennaio 1936 (con alcune annotazioni di Manuel Sainz de los Terreros, il 16 dicembre 1935); Pedro Casciaro, dal 23 gennaio al 16 febbraio 1936; Josemaría Escrivá, dal 24 al 25 febbraio 1936; Ricardo Fernández Vallespín, il 26 febbraio 1936; Pedro Casciaro, dal 26 febbraio al 31 marzo 1936; e Juan Jiménez Vargas, dall’1 aprile al 3 maggio 1936.
Diario 5, intitolato semplicemente “5”. 202 pagine, scritte tra il 4 maggio e il 28 luglio 1936. Fu scritto esclusivamente da Juan Jiménez Vargas.
Ringrazio Mons. Javier Echevarría, vescovo e prelato dell’Opus Dei, per la fiducia dimostratami, permettendomi di fare ricerche nell’Archivio della Prelatura, anche se attualmente sottoposto ad un riordino. Sono anche in debito di gratitudine verso i professori Mercedes Alonso, Constantino Ánchel, Eduardo Baura, José Luis Illanes, Jesús Longares, José Manuel Martín, Lucas Francisco Mateo-Seco, Fernando de Meer, Ignacio Olábarri, María Eugenia Ossandón, Santiago de Pablo, Cristóbal Robles e Alfredo Verdoy, che hanno letto una delle versioni del manoscritto del libro e mi hanno inviato preziosi suggerimenti.
Torna all'indice
Prossimo capitolo
[1] Siccome l’oggetto storico del nostro studio si colloca negli anni trenta del secolo scorso, utilizzeremo i modi usati allora per riferirsi alle persone e agli avvenimenti. Così, il nome del fondatore dell’Opus Dei apparirà come era: José María Escrivá Albás. Fu più tardi, negli anni sessanta, che sulla carta intestata riunì in uno i due primi nomi di battesimo, “Josemaría”, per devozione a san Giuseppe e alla Vergine Maria.
Allo stesso modo, salvo che in questa introduzione, il primo cognome apparirà come egli lo utilizzava negli anni trenta: Escrivá. Successivamente —nell’ottobre del 1940— adottò la dizione “Escrivá de Balaguer” (Balaguer è il territorio di Lérida in cui, nei secoli passati, si erano stabiliti gli Escrivá). Il motivo del cambiamento fu il desiderio di distinguersi da altri rami della famiglia, perché talvolta col suo cognome si faceva un po’ di confusione. Per esempio, nello stesso edificio in cui aveva sede la Residenza DYA, a Madrid, c’era una famiglia che si chiamava “Escrivá de Romaní”, che non era imparentata con gli Escrivá Albás.
D’altra parte, l’espressione “Opus Dei” fu utilizzata da José María Escrivá dopo la guerra civile spagnola. Negli anni trenta impiegò l’espressione “l’Opera di Dio” o, semplicemente, “l’Opera”. Per questo motivo, menzioneremo l’Opus Dei solo in contesti generici.
[2] Cfr. John F. Coverdale, La fundación del Opus Dei, Ariel, Barcelona 2002, pp. 123−165.
[3] Cfr. Constantino Ánchel, “Fuentes para la historia de la Academia y de la Residencia DYA”, Studia et Documenta 4 (2010) 45-101; e José Carlos Martín de la Hoz — Josemaría Revuelta Somalo, “Un estudiante en la Residencia DYA. Cartas de Emiliano Amann a su familia (1935−1936)”, Studia et Documenta 2 (2008) 299−358. Citeremo l’Archivio Generale della Prelatura con la sigla AGP perché è quella adottata da molte pubblicazioni sulla storia dell’Opus Dei. In Spagna questa sigla è usata dai ricercatori per indicare l’Archivio Generale di Palazzo (Madrid).
[4] Cfr. Santiago Casas Rabasa, “Las relaciones escritas de san Josemaría sobre sus visitas a Francisco Morán (1934−1938)”, Studia et Documenta 3 (2009) 371−411; Beatriz Comella Gutiérrez, Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid (1931−1945), Rialp, Madrid 2010; Idem, “Introducción para un estudio sobre la relación de Josemaría Escrivá de Balaguer con el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid”, Studia et Documenta 3 (2009) 175−200.
[5] Cfr. Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Monte Carmelo — Instituto Histórico San Josemaría Escrivá, Burgos 2013.
[6] Cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore dell’Opus Dei, vol. I (“Signore, che io veda!”), Leonardo International, Milano 1998; vol. II (“Dio e audacia”), Leonardo International, Milano 2003; vol. III (“I cammini divini della terra”), Leonardo International, Milano 2004.
[7] In quanto estranei all’oggetto, questa monografia non si occupa neppure di altri elementi che mostrano la ricchezza interiore del fondatore dell’Opus Dei —la sua vita di relazione amorosa con Dio— o del significato teologico e giuridico del messaggio dell’Opera. Ci limitiamo a mostrare la vita del fondatore dell’Opus Dei negli aspetti più inerenti alla storia dell’Accademia e della Residenza DYA.
[8] Molti ricordi sono estratti dalle dichiarazioni presentate in occasione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Josemaría Escrivá. Qui appaiono sotto il titolo “Ricordo di”, seguito dal luogo e dalla data in cui furono firmati.
[9] Sugli Apuntes íntimos del fondatore dell’Opus Dei, cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, Rialp, Madrid 2004, pp. 18−27, e Pedro Rodríguez, “Apuntes íntimos (obra inédita)”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, o.c., pp, 131−135. Non abbiamo potuto consultare questa fonte.
[10] Poco dopo aver cominciato il diario, Josemaría Escrivá diede al suo primo redattore, Manuel Sainz de los Terreros, la seguente istruzione: «da ora in avanti metteremo in questo diario non solo quello che succede o si progetta, ma tutte le osservazioni che facciamo, che pensiamo siano di qualche interesse in futuro e tutto ciò che riteniamo opportuno, con assoluta libertà» (Diario de Luchana, 22−III−1934, pp. 58 e 59, in AGP, serie A.2, 7−2−1); lì si dice che il sacerdote Pedro Poveda confidò a Josemaría Escrivá che si pentiva di non aver fatto lo stesso con l’Istituzione Teresiana (cfr. ibidem, p. 58). Anche Ricardo Fernández Vallespín, direttore di DYA, ricevette l’indicazione di «annotare qualche fatto o dettaglio della nostra vita che col tempo ci aiuterà a ricordare» (Scritto da Ricardo Fernández Vallespín, 29−V−1934, in AGP, serie A.2, 7−2−1).
[11] Cfr. Diario de Luchana, 23−IV−1934, pp. 88-89; Diario de Ferraz, 15−I−1935, p. 111; 17−I−1935, p. 115; e 19−I−1935, p. 118.
[12] Apuntes íntimos, n. 1097 (30−XII−1933), in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico-histórica, o.c., p. 885.
[13] Conosciamo il metodo che seguì uno di loro, Juan Jiménez Vargas: durante la giornata prendeva nota nella sua agenda degli avvenimenti che considerava rilevanti e la sera li passava in bella nel diario (cfr. Diario di Ferraz, 19-VI-1936, p. 43a).
[14] Cfr. Diario 1, in AGP, serie A.2, 7−2−1; Diario 2, con la stessa segnatura; Diario 3, in AGP, serie A.2, 7−2−2; Diario 4, in AGP, serie A.2, 7−2−3; e Diario 5, AGP, serie A.2, 7−2−4. Al fine di evitare ripetizioni, non scriveremo di nuovo i riferimenti archivistici di questi documenti, né ricorderemo le persone che ne furono i redattori.
[15] Spiegheremo in seguito che la “Casa dell’Angelo Custode” fu il nome della prima sede dell’Opera.
[16] Manuel Sainz de los Terreros scrisse il diario in casa della sua famiglia fino al 26 febbraio, giorno in cui lo portò all’Accademia (cfr. Diario di Luchana, 26−II−1934, p. 47). Supponiamo che, da quel momento, scrisse il diario nella sede dell’Accademia.
[17] Diario di Luchana, 25−I−1934, p. 2.