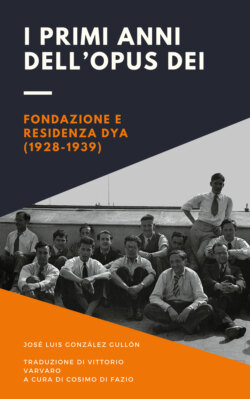Читать книгу I primi anni dell'Opus Dei - José Luis González Gullón - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITOLO I. I PRIMI PASSI DELL’OPUS DEI
ОглавлениеIl nostro racconto comincia nel 1927, quando José María Escrivá si trasferì a Madrid. In quegli anni la Spagna era una nazione di profilo modesto, sia per la sua forza economica che per il suo sviluppo sociale. Il paese si era lasciato alle spalle la perdita di Cuba, di Puerto Rico e delle Filippine nel cosiddetto “disastro” del 1898 e, ripiegato in sé stesso, attraversava una lunga fase di modernizzazione.
Contando sull’appoggio del re Alfonso XIII, nel 1923 alcuni generali, con in testa Miguel Primo de Rivera, avevano fatto un colpo di Stato. Il dittatore aveva proposto un ambizioso programma di progresso, che includeva tre punti: la fine della guerra con le tribù marocchine del Rif, che si concluderà nel 1926; il rinnovamento della vita politica e istituzionale, obiettivo mancato, perché non concesse le indispensabili libertà politiche; e la pacificazione sociale, un compito impegnativo, che non seppe affrontare per svariati motivi, come il confronto con le idee rivoluzionarie o le conseguenze dell’intenso esodo dalle campagne verso le grandi città[1].
Nel 1927 il generale Primo de Rivera teneva in piedi un regime che, pur essendo un direttorio civile —era stata ripristinata la carica di presidente del Consiglio dei Ministri ed era stata creata una Assemblea Nazionale Consultiva—, non disponeva degli strumenti necessari per stimolare la vita politica. Cominciavano a moltiplicarsi le voci a favore di un sistema repubblicano, anche tra alcuni politici di destra, come Niceto Alcalá−Zamora o Miguel Maura, e fra gli intellettuali[2]. Inoltre, nelle grandi città cresceva il desiderio di cambiamento, soprattutto di una maggiore partecipazione alla vita sociale. I partiti politici e i sindacati vedevano aumentare il numero di iscritti. La diffusione delle idee trovava nuovi campi di espressione attraverso il cinema e la radio, e gli incontri sportivi e folcloristici mobilitavano le masse.
La capitale, Madrid, risentiva in quegli anni di una forte espansione. Pur non essendo originariamente una città industriale, fin dall’inizio del XX secolo vi si erano stabilite parecchie imprese e industrie, con la corrispondente crescita del numero dei lavoratori. Si verificò un’autentica alluvione di immigranti dalle campagne, alla ricerca di migliori condizioni di vita, anche in settori dove il lavoro era duro, come quello edile o ferroviario. Così, dai 750.800 abitanti del 1921, Madrid passò agli 866.200 del 1927. La popolazione era foranea ed era giovane: il 68,6% degli abitanti era nato fuori dalla capitale; l’età media era di 29,1 anni e la media di quelli in età lavorativa si aggirava sui 35 anni[3].
La distribuzione della popolazione madrilena rispecchiava le differenze sociali ed economiche tra i vari gruppi. La zona del centro e quella della prima espansione erano abitate da gente di buona posizione sociale, soprattutto nei quartieri creati da progetti urbanistici definiti, come quello di Salamanca. Invece i quartieri della zona sud di sviluppo e quelli periferici presentavano vasti insediamenti di baracche, abitate da operai e impiegati. A nord, attorno alla borgata di Tetuán de las Victorias, abitavano persone di scarse risorse economiche[4].
Da parte sua, la Chiesa cattolica in Spagna contava 49.000 sacerdoti e religiosi[5]. Il suo statuto giuridico era definito nel Concordato del 1851. Lo stato era confessionale cattolico, con una voce del bilancio nazionale destinata al “culto e clero”, e con vari vescovi che, in accordo con la costituzione del 1876 ancora vigente, erano senatori in Parlamento. Il multisecolare impianto della Chiesa era organizzato in diocesi, a loro volta divise in parrocchie. La capitale, Madrid, faceva parte della diocesi di Madrid−Alcalá, suffraganea di Toledo. Il vescovo era Leopoldo Eijo Garay, al governo della diocesi dal 1923.
Alla fine degli anni venti risiedevano a Madrid in modo stabile 1.700 sacerdoti, dei quali 1.100 erano secolari o diocesani e 600 di ordini e congregazioni religiosi. Il numero era sufficiente per l’assistenza spirituale degli abitanti della capitale. Tra i secolari, la metà apparteneva alla diocesi di Madrid−Alcalá, e l’altra metà proveniva da altre. I presbiteri servivano con il loro ministero un certo numero di istituzioni, sia ecclesiastiche che civili: parrocchie, comunità religiose, ospedali, scuole e cimiteri. La maggior parte di questo clero viveva modestamente[6].