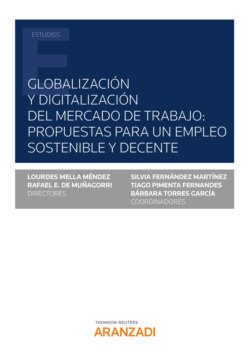Читать книгу Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente - Lourdes Mella Méndez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. TRA RAZIONALITÀ GIURIDICA E RAZIONALITÀ ECONOMICA: LE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI NON ESSENZIALI
ОглавлениеA seguito dell’annuncio dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Governo italiano e le autorità territoriali di governo hanno provveduto alla adozione di una eterogena varietà di misure per contenere i contagi e la diffusione della epidemia. Su tutte spiccano i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze regionali. Accanto ai provvedimenti di carattere medico e sanitario, un peso centrale è stato indubbiamente assunto dalle disposizioni normative relative ai divieti di spostamento delle persone e alle sospensioni delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli ritenuti di pubblica utilità.
Una analisi a sé meriterebbe, ai fini della valutazione della efficacia delle misure di contenimento e prevenzione, il nodo degli spostamenti per motivi di lavoro, che era stato inizialmente ipotizzato in termini decisamente restrittivi –e cioè unicamente per “indifferibili esigenze lavorative”16 –e però poi normativamente definito in termini decisamente assai più laschi, facendo ricorso, nel pieno della emergenza sanitaria, al concetto di “comprovate esigenze lavorative”17 e, dunque, ad esigenze che fossero documentabili ancorché non improcrastinabili. In questa sede rileva tuttavia concentrare la nostra attenzione, per le considerazioni svolte nel paragrafo che precede, alle sole disposizioni emergenziali contenenti limitazioni, per ragioni di sanità pubblica, alle attività produttive industriali, alle attività commerciali e di vendita al dettaglio, ai servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto, ai servizi alla persona e ad ogni altra attività ritenuta non essenziale o strategica.
Da questo punto di vista pare invero privo di utilità il tentativo di ripercorrere cronologicamente i successivi aggiustamenti normativi che hanno portato il Governo, sotto la pressione di numerosi scioperi spontanei dei lavoratori e una accesa dialettica pubblica tra mondo delle imprese e sindacato dei lavoratori, alla messa a punto dell’elenco (progressivamente esteso in ragione dell’aggravarsi della curva dei contagi) delle attività economiche e produttive sospese rispetto alle prime chiusure stabilite per limitate e specifiche attività economiche (palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e ricreativi, impianti sciistici, bar e ristoranti, medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive, ecc.)18. Per evitare ricostruzioni pedanti è sufficiente richiamare, ai fini del nostro ragionamento, il meccanismo adottato dal decisore politico nel pieno della emergenza sanitaria, seppure su basi normative precarie e anche discutibili sul piano del sistema delle fonti, per indicare in termini di razionalità giuridica e, quindi, di disciplina le attività economiche ammesse.
Il riferimento normativo è al d.P.R. 22 marzo 202019, che, in sé considerato, segue uno schema abbastanza lineare e intuitivo. In esso si stabilisce che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il c.d. “lavoro agile” –ma sarebbe meglio dire “lavoro domiciliare”20– è la modalità ordinaria per tutta l’emergenza21. Il lavoro agile resta lo schema da adottare anche nel settore privato, là dove ciò sia possibile sul piano organizzativo e in relazione alle mansioni del lavoratore, anche alla luce delle modifiche introdotte al quadro legale per renderlo più facilmente accessibile nel tempo della emergenza, e anche per attività che altrimenti sarebbero sospese. Restano invece ammesse le attività che erogano “servizi di pubblica utilità”, nonché i “servizi essenziali” di cui alla l. 12 giugno 1990, n. 146, ben nota ai giuslavoristi, e ogni altra “attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”. Restano consentite anche le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Previa comunicazione al Prefetto, sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, nonché attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale tra cui le attività della industria dell’aerospazio e della difesa. Tutte le altre attività produttive industriali e commerciali sono invece state temporaneamente sospese, fatta eccezione per un elenco di attività contenute in allegato allo stesso d.P.R. 22 marzo 2020, modificabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico22, e incentrate sulla identificazione di settori produttivi mediante il ricorso ai codici ATECO. Previa comunicazione al Prefetto, restano infine ammesse, anche se non rientranti nei codici ATECO espressamente menzionati, le attività economiche e produttive che risultino funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori indicati nell’elenco allegato al decreto.
Gli spunti di discussione e di analisi scientifica che offre questo elenco, solo apparentemente banale, di codici ATECO posizionati uno dietro l’altro possono essere molteplici e di diversa natura anche solo restando dentro i confini, che ci eravamo riproposti, della ricerca di una migliore connessione tra razionalità giuridica e razionalità economica nella gestione delle problematiche lavoristiche ed occupazionali della emergenza sanitaria. Non rientra certo nelle nostre competenze disciplinari misurare il reale impatto del provvedimento in termini di punti percentuali persi di valore economico (leggasi PIL/contrazione del fatturato) e di unità di lavoro sospese/ore non lavorate in funzione dell’obiettivo di salvare vite umane, sempre ammesso che sia poi possibile, su materie così delicate, sviluppare una analisi costi e benefici23, opinabile non solo in termini etici24 ma anche alla luce delle prime risultanze empiriche25. Parimenti riteniamo che si possa lasciare alla emotività del contesto emergenziale, e a più approfondite e impegnative valutazioni future sulle modalità giuridiche di riconoscimento del “valore sociale” del lavoro, oltre cioè la sua mera dimensione economica o di mercato, la rilevante attenzione prestata dalla opinione pubblica ai singoli lavori e mestieri essenziali piuttosto che ai settori generali di attività, su cui si è invece soffermata l’attenzione del Governo. Non mancano comunque, anche in questa direzione di analisi, contributi di un certo interesse che suggeriscono come forse il decisore politico avrebbe potuto seguire strade diverse e soluzioni tecnicamente più raffinate perché capaci di tenere in debita considerazione anche il grado di rischiosità dei singoli lavori e mestieri in correlazione al loro livello di importanza o, appunto, essenzialità per la soddisfazione delle esigenze primarie della persona e della società nel suo complesso durante l’emergenza sanitaria26.
Ciò che invece maggiormente interessa, ai fini della discussione del problema che abbiamo posto all’inizio del nostro ragionamento, è una diversa questione che emerge analizzando le ragioni più profonde della dura reazione degli attori del sistema di relazioni industriali (e cioè i rappresentanti della economia, delle imprese e del lavoro) rispetto alla scelta (di razionalità) normativa del ricorso ai codici ATECO. Poco è dato sapere, invero, sulla concertazione sotterranea avvenuta sul punto –come documentato dai tanti “messaggi in codice” veicolati sugli organi di informazione nei giorni della emergenza– tra Governo e Confindustria, in prima battuta, e tra Governo e CGIL, CISL e UIL, in seconda battuta. Sta di fatto che l’elenco dei codici ATECO non ha soddisfatto le imprese, che avrebbero preferito protocolli sostanziali di sicurezza piuttosto che rigorosi divieti formali di apertura; e neppure i sindacati, che hanno invece ritenuto troppo permissivo l’elenco alla fine pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2020, sospettando così di essere stati tagliati fuori dal dialogo tra Governo e imprese. Con il risultato, ottenuto sotto la minaccia di ricorrere allo sciopero generale, di arrivare nell’arco di pochi giorni a un nuovo elenco di codici ATECO: un elenco più restrittivo e selettivo, a detta dei sindacati, ma che, in realtà, ha paradossalmente portato a estendere piuttosto che ridurre il numero di lavoratori (potenzialmente) richiamati al lavoro27.