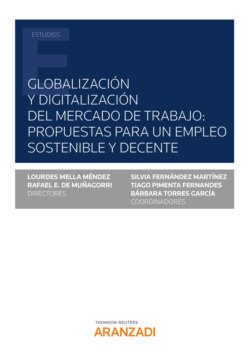Читать книгу Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente - Lourdes Mella Méndez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. SEGUE: LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO TRA CODICI ATECO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ОглавлениеUn importante tentativo di mettere a punto, in ambito lavoristico, migliori e più affidabili connessioni tra la razionalità economica e la razionalità giuridica si è recentemente registrato anche nel campo della regolazione collettiva dei rapporti individuali di lavoro. L’esercizio è stato condotto per iniziativa del CNEL, in collaborazione con l’INPS e le parti sociali rappresentate nel CNEL stesso, nell’ambito del complesso processo di aggiornamento, riclassificazione, ricostruzione storica, digitalizzazione e ricodificazione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito ai sensi dell’art. 17, comma primo, della l. 30 dicembre 1986, n. 93641.
L’associazione dei codici utilizzati rispettivamente da CNEL e INPS per la classificazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro del settore privato ha come obiettivo pratico e dichiarato la realizzazione di una “anagrafe unica nazionale dei contratti collettivi”42. Per contro la banca dati non può, allo stato, fungere da parametro oggettivo per la determinazione e pesatura della reale rappresentatività degli attori firmatari di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento al rispettivo codice merceologico o settoriale di riferimento e, dunque, anche in relazione al relativo campo contrattuale di applicazione (la c.d. categoria). E tuttavia, l’esercizio si muove nella direzione di fornire una robusta e imprescindibile base giuridico-istituzionale al tentativo di contenere, in termini di maggiore aderenza alla realtà dei processi economici e sociali e di ottimizzazione delle risorse pubbliche e delle normative di sostegno alla contrattazione collettiva, la deleteria proliferazione di contratti collettivi di lavoro e, persino, di contratti denominati in letteratura nei termini di “accordi pirata”. Ed infatti, a detta dello stesso CNEL, il lavoro svolto “fornisce una valida indicazione della consistenza numerica degli accordi, contribuendo a inquadrare meglio i possibili contesti in cui possono svilupparsi fenomeni di competizione contrattuale al ribasso [e] pratiche sleali […] attraverso la individuazione di un set di parametri che prendano in considerazione i contenuti degli accordi nazionali, realizzando in tal modo una griglia di lettura qualitativa”43.
Che la direzione sia questa lo dimostra un recente disegno di legge presentato dallo stesso CNEL in Parlamento44 e finalizzato alla introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Nella proposta del CNEL il codice unico (c.d. “codice ccnl”) risulterebbe funzionale alla determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale45 e anche alla compilazione e al monitoraggio digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili da parte dell’INPS. È tuttavia evidente, come conferma un ulteriore disegno di legge46, che questo semplice “accorgimento” per la catalogazione e identificazione dei singoli contratti e accordi nazionali di lavoro potrebbe poi rappresentare una solida base giuridico-istituzionale per l’introduzione di una legge sulla rappresentanza sindacale e sulla determinazione di un salario minimo garantito in attuazione, rispettivamente, degli artt. 39 e 36 Cost.
Non è certo questa la sede per ritornare sulla controversa quanto straordinariamente complessa questione della legge sindacale e dei criteri di selezione degli attori del nostro sistema di relazioni industriali. Ma è palese che questo nodo storico del nostro sistema politico e di relazioni industriali sia il punto di massima ricaduta nella ricerca di quello che, richiamando l’insegnamento di John Commons, Gino Giugni amava definire come “l’agognato ponte tra diritto ed economia”47.
L’iniziativa del CNEL, da questo punto di vista, è di indubbia rilevanza perché, prima ancora di entrare nel merito della opportunità o meno di una legge sindacale, contribuisce nei fatti a rilanciare nel dibattito politico e nel confronto tra le parti sociali la questione, emersa ora con clamore nel pieno della emergenza sanitaria da Covid-19, della necessità di mettere a punto un più preciso ed attendibile canale di integrazione tra la razionalità giuridica e la razionalità economica nell’ambito delle relazioni e dei contratti di lavoro. Ed in effetti, come è stato puntualmente sottolineato48, con questo esercizio “si mette in agevole comunicazione la categoria contrattuale (data dall’ambito di applicazione del CCNL definito dalle parti stipulanti ed espresso in termini di uno o più settori produttivi elementari) e la categoria merceologica (data dai codici ATECO collegabili univocamente ai settori produttivi elementari)”.
Ciò che tuttavia lascia perplessi –e non convince– sono i presupposti fattuali e, ancora di più, le pregnanti implicazioni teoriche, concettuali e anche di politica del diritto e di politica legislativa della operazione messa in campo dal CNEL. In termini fattuali perché il presupposto dell’intera operazione è, ancora una volta, quello dei codici ATECO, che, come più volte segnalato nel corso di questa analisi e come ci hanno mostrato le vibranti polemiche relative alle misure di lockdown adottate nel pieno della emergenza sanitaria, rappresentano una geografia economica e del lavoro del passato contribuendo con ciò ad attrarre e imbrigliare il dinamismo delle relazioni industriali dentro le gabbie concettuali e normative dello scorso secolo. Il lavoro del CNEL, infatti, “ha assunto come riferimento i codici ISTAT delle attività produttive (AtEco), disaggregati al massimo livello (6 digit), attinenti all’ambito di applicazione riportato nel testo di ciascuno dei CCNL depositati”49. E la stessa ricodificazione dei contratti collettivi, che sono niente altro che il principale canale di comunicazione normativa tra la razionalità economica (le dinamiche dei mercati settoriali del lavoro) e la razionalità giuridica (i limiti e le condizioni per l’impiego del fattore lavoro in azienda), è avvenuta attraverso l’abbinamento ai singoli contratti e accordi collettivi di lavoro dei codici ATECO di classificazione delle attività economiche alla sesta cifra, che, come noto, è la profondità massima possibile): “questo abbinamento è stato effettuato dal CNEL sulla base dei campi di applicazione contrattuali quali delineati negli stessi contratti collettivi e sottoponendo l’abbinamento alla verifica e validazione delle parti sociali firmatarie. In realtà il collegamento dei CCNL (circa 800) ai codici ATECO (attualmente in totale 1.224) viene effettuato dal CNEL sulla base del campo di applicazione del CCNL se vi sono indicati i settori ATECO (come avviene in genere nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali rappresentate al CNEL)”50.
La maggiore perplessità deriva tuttavia dalle implicazioni teoriche e concettuali di questa operazione e dal possibile utilizzo in chiave di politica del diritto e di politica legislativa che se ne può poi fare. È indubbio che questo esercizio facilita il tentativo di cogliere con maggiore precisione le aree di contrattazione al ribasso (gli accordi pirata) e i margini di sovrapposizione e la coesistenza di diversi contratti e accordi collettivi entro un identico perimetro delle categorie produttive di contrattazione (il campo di applicazione). E tuttavia agevola, al tempo stesso, anche operazioni burocratiche e di matrice pubblicistica di definizione dei settori di contrattazione collettiva e di selezione degli attori della rappresentanza legale della relativa categoria che ci paiono di dubbia compatibilità rispetto al principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost., che leggiamo, nel rapporto tra razionalità economica e razionalità giuridica, in termini di primato del diritto privato dei contratti (collettivi) rispetto ad operazioni politiche ed amministrative di cristallizzazione del dinamismo di relazioni industriali. Che questo dubbio non sia infondato lo indica chiaramente il già citato disegno di legge, che fa leva sulla proposta del CNEL di codice unico dei contratti collettivi nazionali per disciplinare il cuore delle dinamiche retributive (il salario minimo), la rappresentanza e la contrattazione collettiva, là dove si prospetta la costituzione, in seno al CNEL51, di una commissione paritetica per la individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi chiamata a deliberare –e successivamente a formalizzare mediante appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali– “gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni […]; i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori […]; i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro […]; i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori […]; i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello […]; i criteri per l’individuazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 […]; il salario minimo di garanzia negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva”.
È stato sottolineato –rispetto alla previsione costituzionale che preclude la possibilità di precostituire in via pubblicistica e amministrativa le categorie nel cui ambito la rappresentatività dei sindacati debba essere misurata e nel cui ambito la contrattazione collettiva debba obbligatoriamente incanalarsi– che in questo esercizio di connessione formale tra i codici ATECO e il libero sistema di contrattazione collettiva “la categoria merceologica segue la categoria contrattuale e non preesiste ad essa, nel rispetto dei consolidati principi di libertà sindacale e di inapplicabilità dell’art. 2070 c.c. ai contratti collettivi di diritto comune”52. Affermazione questa in sé lineare. Se non fosse che questo procedimento –e i conseguenti provvedimenti pubblici di recepimento e ratifica formale delle deliberazioni adottate in seno al CNEL– oltre ad essere condotti attraverso una selezione ex ante degli attori sindacali, che ipoteca o comunque pesantemente condiziona le dinamiche future mediante una sorta di oligopolio istituzionale della rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, finisce poi di fatto col cristallizzare, in termini analoghi a quanto avvenuto in epoca corporativa53 e a prescindere dal profilo della pubblicazione e del deposito del contratto collettivo54, un ordinamento delle categorie professionali centrato sul livello nazionale e condizionato dalla definizione in via amministrativa del campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro. Un sistema che finirebbe anche per marginalizzare diverse espressioni ed evoluzioni di un libero sistema di contrattazione collettiva che pure cominciano a emergere (contrattazione di sito, contrattazione di prossimità, ecc.) o che potrebbero anche innescare un radicale cambio di paradigma del sistema di relazioni industriali coerente con le dinamiche indotte dalla Quarta rivoluzione industriale (come ad esempio un sindacalismo di mestiere e una rappresentanza globale di filiera e di territorio).
Da questo punto di vista, rispetto ai processi di integrazione tra razionalità economica e razionalità giuridica, si potrebbe semmai ribaltare la polemica sferrata contro i codici ATECO per concludere che ad essere inadeguati non sono tanto e solo i criteri utilizzati dagli economisti per la rappresentazione ai fini statistici delle attività produttive e dei servizi quanto le linee di azione degli attori del nostro sistema di relazioni industriali che ancora insistono ad alimentare –in una economia governata dalle catene globali del valore e dalle filiere globali di fornitura e subfornitura– una configurazione della economia (i mercati del lavoro, in primis) e delle istituzioni che la regolano (i contratti di categoria) di impronta novecentesca. Contratti nazionali per settore merceologico e rappresentanza di settore sono insomma niente altro che la trasposizione in termini giuridici (dentro gli statuti della rappresentanza d’impresa e del lavoro e lungo i perimetri della contrattazione nazionale di categoria) delle stesse dinamiche di rappresentazione dei processi economici di cui i codici ATECO sono espressione.