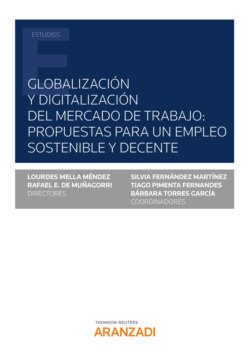Читать книгу Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente - Lourdes Mella Méndez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. POSIZIONE DEL PROBLEMA
Оглавление“Niente sarà più come prima”. È questo il mantra che ha accompagnato il dibattito pubblico sugli effetti della emergenza di sanità pubblica causata dal Covid-19. In questa prospettiva si è collocata anche la riflessione scientifica e dottrinale relativa alle conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro e sulle regole che lo governano. L’impressione, tuttavia, è che l’emergenza sanitaria non abbia fatto altro che accelerare e rendere più nitide alcune tendenze da tempo in atto nel mercato del lavoro e che hanno messo sotto pressione i valori fondativi del diritto del lavoro1. Tendenze “guidate” non tanto e non solo dagli inevitabili cambiamenti tecnologici2, quanto piuttosto dai mutamenti sociali (demografici e ambientali, in primis) che hanno profondamente trasformato i mercati del lavoro e che, come da tempo segnalato3, caratterizzano la nuova modernità nei termini di una “società del rischio” rispetto alla quale fenomeni come le pandemie e altre catastrofi naturali sono tutt’altro che eccezionali o imprevedibili4.
Che quello della società (globale e tecnologica) del rischio sia uno schema interpretativo particolarmente adeguato per ricostruire anche la razionalità giuridica che ha accompagnato le problematiche lavoristiche e occupazionali legate al Covid-19 lo dimostrano almeno due elementi a nostro parere decisivi. Da un lato, una accentuata “politica dirigista di gestione dello stato di emergenza”5 che altera non poco – nel nostro caso con una serie reiterata di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze assunte dalle istituzioni di governo regionale e locale6 – il sistema delle fonti e gli ordinari meccanismi di bilanciamento tra i diversi valori e principi costituzionali, tra cui il diritto-dovere al lavoro e la libertà di iniziativa economica privata. Dall’altro lato, una sempre più evidente fragilità della razionalità tecnico-scientifica nella definizione e nella gestione del rischio7 –nel nostro caso il rischio epidemiologico e la relativa emergenza di sanità pubblica– che, più o meno consapevolmente, ingenera una fuga dalla responsabilità decisionale (dell’attore politico) e che, tra la ricerca ossessiva di alibi e capri espiatori, alimenta un pericoloso cortocircuito comunicativo tra la politica e i mass media nella “costruzione” di una opinione pubblica che a sua volta condiziona, sull’onda della emotività e dell’ultimo sondaggio disponibile, l’alluvionale processo di produzione della normativa emergenziale. Ed in effetti, rispetto alle problematiche lavoristiche e occupazionali della emergenza sanitaria, buona parte del cortocircuito decisionale e normativo è stato innescato dall’aver contrapposto frontalmente due pretese di razionalità che sono state messe in concorrenza tra di loro nella comunicazione pubblica e anche in quella politico-sindacale: la razionalità medico-scientifica (a favore della chiusura delle attività produttive) e la razionalità economica (a favore di una loro rapida riapertura). Come se la razionalità economica fosse espressione del mero e brutale interesse al profitto del singolo imprenditore e non di un ben più complesso ordine sociale di convivenza, mediato nelle scelte di interesse e nei conflitti di potere dalla razionalità giuridica e finalizzato, nella sua totalità, alla creazione di valore, benessere, lavoro e mezzi di sussistenza per l’intera collettività.
È certamente ancora tutto da dimostrare un nesso di causalità che, partendo dalla osservazione delle marcate differenze riguardanti la diffusione del Covid-19 nelle diverse aree del Paese, colleghi direttamente gli effetti più devastanti della pandemia (in termini di contagi e numero di decessi) al grado di industrializzazione e al relativo tasso di inquinamento atmosferico da polveri sottili8. Pare tuttavia già oggi sufficientemente chiaro che ad essere messo in discussione dalla pandemia è un intero modello di sviluppo che, accanto al persistente tema delle diseguaglianze e della distribuzione della ricchezza, rivela oggi –per dirla alla Beck9– “una unilateralità economica della razionalità tecnico-scientifica”, che, una volta recepita meccanicamente dalla razionalità giuridica, porta poi a due inevitabili conseguenze: trattare, da un lato, il lavoro come un semplice fenomeno economico riconoscibile e valutabile unicamente per il suo valore di scambio e dunque di mercato; considerare, dall’altro lato, i rischi connessi ai (o indotti dai) processi produttivi come un dato di fatto socialmente tollerabile in nome del progresso.
L’interesse della presente riflessione intende volutamente lasciare sullo sfondo gli impegnativi dilemmi giuslavoristici della “società del rischio” rispetto ai quali l’emergenza sanitaria da Covid-19 è stato solo uno dei tanti possibili inneschi anche in ragione dei ritardi culturali e delle reticenze con cui sono stati sin qui affrontati i rischi ambientali nella loro connessione col tema del lavoro10. La nostra attenzione sarà infatti rivolta a una più circoscritta ma non meno importante questione di metodo, relativa alle dinamiche di manifestazione e costruzione della razionalità giuridica del lavoro nella nuova modernità quale che sia lo schema interpretativo di volta in volta adottato (la nuova normalità, la società del rischio, la Quarta rivoluzione industriale o altro ancora).
Il punto di attacco del nostro contributo è, ancora una volta, la riflessione di Ulrick Beck sulla risk society quando imputa l’attuale crisi della razionalità tecnico-scientifica non al fallimento di questo o quel ricercatore o delle singole discipline, quanto all’approccio strutturale –e cioè “metodico e istituzionale”– che le scienze hanno rispetto al rischio: “così come sono costruite, con la loro divisione del lavoro iperspecializzata, col loro modo di intendere il metodo e la teoria, con la loro eterodiretta astinenza dalla prassi, le scienze non sono assolutamente in grado di reagire adeguatamente ai rischi della civiltà, poiché sono ampiamente corresponsabili della loro nascita e crescita” (corsivo dell’autore)11. In questa prospettiva, piuttosto che indugiare su temi ampiamente noti alla riflessione giuslavoristica come il ruolo dello Stato nella regolazione della economia, un dato su tutti merita attenzione. E cioè come la contrapposizione tra beni/ valori di rango costituzionale come la “salute”, “l’impresa” e il “lavoro” sia ancora una volta stata rappresentata attraverso il filtro di una razionalità economica unilaterale –tanto in termini di critica (lato imprese) che di rovesciamento (lato sindacati e politica)– che non consente di comprendere pienamente, nella ricerca delle soluzioni normative e nella sistematizzazione dottrinale che le accompagna, non solo la portata reale dei problemi ma anche, secondo una lezione invero da tempo nota alla nostra dottrina12, la ricchezza della dimensione giuridico-istituzionale che scaturisce dalla costante interazione tra i gruppi di interesse contrapposti.
In questa direzione lo spunto di riflessione su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione è dato dalle misure restrittive della libertà di impresa e di accesso al lavoro ai fini del contenimento e della prevenzione del contagio. Provvedimenti che, in termini di presupposti fattuali, si basano su una rappresentazione ancora novecentesca delle attività economiche, professionali e produttive come quella offerta dai codici ATECO e che, in termini giuridici, non beneficiando di una visione della economia di tipo “investigativa” –alla John Commons, per intenderci13– finiscono col trascurare nella gestione politica delle problematiche lavoristiche e occupazionali connesse alla emergenza sanitaria le risposte sistemiche fornite, anche in termini di produzione normativa, dagli attori delle relazioni industriali. Se una lezione ci consegna la crisi sanitaria da Covid-19 è infatti essenzialmente una lezione di metodo. E cioè l’importanza dello studio del diritto che nasce dai sistemi di relazioni industriali –quello che, sotto la guida di Luciano Spagnuolo Vigorita14, abbiamo imparato a chiamare “diritto delle relazioni industriali”– come base per progettare assetti giuridico-istituzionali adattabili e modelli di welfare coerenti con una geografia economica che può essere pienamente compresa, anche in termini di razionalità giuridica, solo ripercorrendo le dinamiche delle catene globali del valore e delle relative filiere produttive e distributive. Una lezione che –nel ricordarci come il diritto del lavoro non sia una semplice tecnica unilaterale di tutela, ma un più complessivo “ordine giuridico” dei processi economici e sociali connessi al lavoro –conferma una volta di più l’importanza di una concezione unitaria delle scienze sociali soprattutto in un Paese come il nostro “al quale, e non sempre a torto, si rimprovera l’eccessivo frazionamento del sapere in settori specializzati”15.