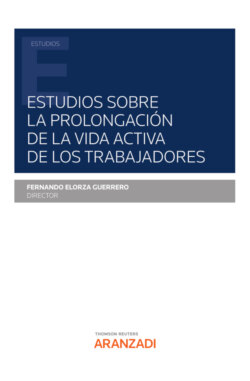Читать книгу Estudios sobre la prolongación de la vida activa de los trabajadores - Fernando Elorza Guerrero - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XI. Segue: la disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione
ОглавлениеUn elemento molto rilevante per valutare l’orientamento del legislatore con riguardo al tema dell’invecchiamento attivo è rappresentato dalla disciplina relativa alla possibilità di “cumulare” o no il reddito da pensione con il reddito derivante da attività lavorative.
Al riguardo, l’evoluzione della normativa italiana è stata ondivaga, perché caratterizzata da periodi di divieto, ai quali sono seguite fasi di allentamento del vincolo e, poi, di introduzione di nuovi limiti. La mutevolezza nel tempo dell’orientamento del legislatore si spiega in ragione delle diverse esigenze che man mano sono state ritenute prioritarie (quali, in particolare, quelle di natura finanziaria, di contrasto al lavoro sommerso, di promozione dell’invecchiamento attivo oppure dell’occupazione giovanile).
Attualmente, però, il principio generale è quello della piena cumulabilità tra i redditi da lavoro (sia autonomo che dipendente) e la pensione di vecchiaia, di vecchiaia supplementare48, di anzianità e anticipata (art. 19 d.l. 25 giugno 2008 n. 112).
Resta, comunque, fermo che, per richiedere la liquidazione della pensione, il lavoratore deve cessare dal rapporto di lavoro in essere, poiché la pensione può essere erogata “solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato”49.
Al principio della piena cumulabilità fra redditi di pensione e di lavoro, sono previste alcune eccezioni50. In particolare, il divieto di cumulo resta fermo nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni ove il nuovo servizio costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione51.
Anche per i lavoratori “precoci”, poi, è previsto il divieto di cumulo della pensione anticipata con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per il lasso di tempo che corrisponde all’anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione anticipata ordinaria (cfr. legge 11 dicembre 2016, n. 232 e D.P.C.M. 87/2017). Una volta raggiunta l’anzianità contributiva richiesta, trova applicazione la norma generale dell’articolo 19 d.l. 112/2008.
Analogo divieto, infine, è previsto per i titolari della “pensione quota 100”, tranne che per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di euro 5.000,00 annui (comma 3 dell’art. 14 d.l. n. 4/2019).. Il divieto vale per tutto il periodo che intercorre tra la decorrenza del trattamento (il momento di percezione) fino alla maturazione dell’età utile per la pensione di vecchiaia ordinaria.
1. E’ noto che, a causa dei trend demografici ed economici in atto, le Istituzioni europee hanno sollecitato gli Stati membri ad adoperarsi per accrescere la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, ritardandone l’uscita e contrastando il cd. “early retirement”, in modo da garantire la sostenibilità nel lungo periodo dei sistemi di welfare nazionali e, in primis della spesa pensionistica. Al riguardo, si ricordano in particolare i target quantitativi di occupazione fissati con la strategia di Lisbona del 2000, che richiedeva il raggiungimento entro il 2010 di un tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa fra i 55 e i 64 anni pari al 50%. Più di recente la Strategia Europa 2020 ha fissato per il termine temporale esplicitato nel suo titolo il complessivo obiettivo del 75% di soggetti occupati nella fascia d’età 20-64 anni.
2. Per effetto di fattori convergenti anche se di diversa natura, tra i quali spicca il tasso di natalità estremamente basso ed un servizio sanitario pubblico garantito a tutte le persone (anche se, negli ultimi anni, messo a dura prova dal taglio delle “risorse” necessarie).
3. Cfr. ISTAT, Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia, Roma, 2020.
4. Al contrario, a tutela dei minori, ed in adempimento di una precisa prescrizione costituzionale (art. 37 comma 2 Cost.), la legge fissa l’età minima di ammissione al lavoro (art. 3 comma 1 legge n. 977 del 1967).
5. Come chiarito da Cass. 2 marzo 2005, n. 4355: “i precetti dettati dall’art. 97 Cost. non sarebbero compatibili con un sistema che consentisse alle amministrazioni pubbliche di protrarre sine die il servizio di taluni dipendenti, secondo una libera scelta, sottratta in pratica al sindacato del giudice”. Precetti che, al contrario, non abbracciano il lavoro privato, per il quale opera il principio di tipicità e tassatività delle cause di estinzione del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo, Cass. 9 giugno 2020, n. 11008), tra le quali, come accennato, non è contemplata l’ipotesi del raggiungimento di un determinato limite di età.
6. Salve eccezioni connesse alla peculiarità della funzione esercitata, come ad esempio per i magistrati, per gli avvocati ed i procuratori dello Stato, per i professori ordinari universitari.
7. E comunque non oltre il 70° anno di età. Così Corte cost. 18 giugno 1991, n. 282. Nello stesso senso, con riferimento al personale delle unità sanitarie locali ed all’art. 53 comma 1 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, si veda, anche, Corte cost. 9 marzo 1992, n. 90.
8. Art. 38 comma 2 Cost.: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
9. Dapprima, nel 2004, era stata introdotta l’ulteriore possibilità (poi eliminata nel 2006) del trattenimento in servizio fino a 70 anni di età, subordinatamente all’accoglimento della domanda del dipendente interessato, che il datore di lavoro pubblico era tenuto a valutare “in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell’efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale” (art. 1-quater del d.lgs. 28 maggio 2004, n. 136). Poi, nel 2008, nel riportare a 67 anni di età il limite del trattenimento in servizio, fu stabilito che “è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” (art. 72, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
10. Cfr. Cons. Stato 2 maggio 2012, n. 2518: “l’art. 72, comma 7 cit. ha profondamente innovato le previsioni di cui al D.L.gs. 30 settembre 1992, n. 503, art. 16, non riconoscendo più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente per un biennio, ed ha attribuito all’amministrazione un potere discrezionale di concedere la proroga da esercitarsi attribuendo preminente valore alle proprie esigenze organizzative e funzionali ed in secondo luogo all’esperienza professionale acquisita dal dipendente in coerenza con l’esigenza dell’efficiente andamento dei servizi”. Si veda, anche Tar Lazio 2 novembre 2010, n. 33089, secondo cui “la modifica della disciplina dell’art. 16 del d.lgs. n° 503 del 30.12.1992 nel senso di rendere un diritto soggettivo del dipendente pubblico al prolungamento biennale del servizio una scelta discrezionale dell’Amministrazione non può ritenersi né illogica né irragionevole, né risultano sacrificati affidamenti qualificati”.
11. A seguito di ciò, anche il Consiglio di Stato, mutando il suo precedente orientamento, ha ritenuto che il trattenimento in servizio dovesse essere sorretto da adeguate giustificazioni, mentre qualora la P.A. avesse ritenuto di non dover concedere la permanenza in servizio sarebbe ricorsa “la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato” (Cons. Stato 24 gennaio 2011, n. 479).
12. Cfr. art. 1 comma 1 d.l. n. 90/2014. Così come è stato soppresso anche l’istituto dell’esonero dal servizio (previsto dall’art. 72 commi da 1 a 6 legge n. 133/2008) che riconosceva al personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni.
13. Art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008. Tale disposizione, dalla quale sono espressamente escluse le categorie dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa, aveva originariamente natura temporanea, ma è stata poi portata a regime in contemporanea con l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio (art. 1 comma 5 d.l. n. 90/2014).
14. Cfr. Cass. 13 giugno 2018, n. 15526.
15. Art. 16, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e art. 1 comma 5 d.l. n. 90 del 2014.
16. Cfr., al riguardo, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le sentenze C-144/04 “Mangold”, C-555/07 “Kucukdeveci”, e sentenza C- 447/09 “Prigge”.
17. Trib. Milano 19 gennaio 2010; Trib. Milano 9 dicembre 2010; Trib. Sant’Angelo dei Lombardi 24 agosto 2010; Tar Toscana 30 maggio 2012, n. 1061; Tar Lazio 8 febbraio 2011, n. 1213.
18. Cfr. le sentenze 16 ottobre 2007, C-411/05 “Palacios de La Villa”; 12 ottobre 2010, C-45/09 “Rosenbladt”; 18 novembre 2010, C-250/09 e 268/09 “Georgiev”; 21 luglio 2011, C-159/0 e 160/10 “Fuchs e Köhler”.
19. Così come disciplinate dagli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
20. Cfr. art. 33 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001.
21. Il libero recesso, che costituisce quindi un’eccezione alla regola generale, resta configurabile solo in alcune ipotesi quali il rapporto di lavoro con i dirigenti, il lavoro sportivo e quello domestico, nonché durante il periodo di prova.
22. Così Corte cost. 14 luglio 1971, n. 174. Nello stesso senso, Corte cost. 7 luglio 1986, n. 176, secondo cui “devesi ritenere che non possono essere negate, per il solo fatto dell’età, quelle garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì indici del valore spettante al lavoro nella moderna società”.
23. Cfr. ancora Corte cost. n. 174/1971, laddove osserva che: “in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l’assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale”. Analoga protezione non è riconosciuta all’interesse relativo all’incremento della prestazione pensionistica (cfr. Corte cost. 6 marzo 2013, n. 33, secondo cui “il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l’incremento del trattamento di quiescenza”).
24. Ciò, peraltro, a condizione che essi non “abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell’INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall’assicurazione generale obbligatoria”.
25. Cfr. Cass. 10 gennaio 2019, n. 435, secondo la quale “la salvezza dell’ipotesi dell’esercizio dell’opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia”.
26. Così, Cass. 28 agosto 2003, n 12655.
27. In tal senso, cfr. Cass. 28 aprile 2004, n. 81619.
28. Cfr. Trib. La Spezia 25 marzo 2013; Trib. Roma 14 ottobre 2014; Corte d’Appello Milano 15 aprile 2015.
29. Trib. Genova 11 novembre 2013.
30. Si veda il già ricordato art. 11, comma 1, della legge n. 604 del 1966, il quale stabilendo che le disposizioni della legge medesima non si applicavano ai lavoratori in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, determinava una disparità tra gli uomini e le donne, dal momento che queste ultime conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia prima degli uomini (e precisamente, all’epoca, al compimento del 55° anno di età, mentre per gli uomini il limite di età era fissato al 60° anno). Una parziale differenza di trattamento era prevista anche dall’art. 4 della legge n. 903 del 1977, il quale attribuiva alla donna lavoratrice, in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia, la possibilità di continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l’uomo, ma a tal fine veniva richiesta (solo per la lavoratrice) una comunicazione al datore di lavoro, da inviarsi almeno 3 mesi prima della data di perfezionamento del diritto. Si veda, infine, anche l’art. 30 del d.lgs. n. 198 del 2006.
31. Cfr. Corte cost. 1 luglio 1969, n. 123.
32. Cfr. le sentenze 11 giugno 1986, n. 137, 27 aprile 1988, n. 498 e 19 ottobre 2009, n. 275.
33. Così Corte cost. n. 256 del 2002.
34. Cfr., ancora, Corte cost. n. 256 del 2002.
35. Art. 1 d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.
36. Come ha chiarito la Corte costituzionale, la ratio della pensione di anzianità è quella di premiare i lavoratori che hanno contribuito al benessere della collettività con il proprio lavoro, partecipando assiduamente alle attività produttive per un lungo periodo di anni (cfr. Corte cost. 2 maggio 1991, n. 194). È però indubbio che questa particolare forma di tutela, che non trova un fondamento costituzionale diretto ed esplicito (l’art. 38 Cost., come detto, non considera l’anzianità di servizio tra gli eventi protetti), essendo erogata per un periodo solitamente più lungo degli altri trattamenti pensionistici, finisce per incidere sulla sostenibilità finanziaria dell’intero sistema previdenziale.
37. Particolarmente evidente è l’influenza delle sollecitazioni europee nella legge n. 214 del 2011, ove si esplicita che “Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo”.
38. Per quanto riguarda il requisito della contribuzione è previsto, di regola, un minimo di 20 anni di anzianità contributiva. È necessario, tuttavia, che l’ammontare dei contributi versati determini l’erogazione di un importo pensionistico che sia superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, istituito dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, annualmente rivalutato (cd. importo soglia). Nel caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contribuzione, o i contributi versati non siano sufficienti a determinare l’erogazione di un importo pensionistico superiore al limite ora ricordato, il diritto a pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge l’età di 70 anni (dal 1 gennaio 2019, 71 anni per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita), sempreché siano stati maturati almeno 5 anni di contribuzione effettiva, esclusi quindi i contributi figurativi (art. 24, comma 7, legge n. 214 del 2011). Nell’ipotesi in cui il lavoratore non raggiunga il requisito contributivo minimo per aver diritto a pensione, egli “perde” la contribuzione versata, e potrà eventualmente fruire dell’assegno sociale previsto a favore di tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni (66 anni, dal 1 gennaio 2018) e che si trovino in disagiate condizioni economiche (cfr. art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995; art. 20, comma 10, legge n. 133 del 2008; art. 24, comma 8, legge n. 214 del 2011).
39. Art. 2 comma 5 d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
40. Cfr. Cass. 4 settembre 2015, n. 17589.
41. Cfr. art. 24 comma 14 d.l. n. 201 del 2011. Esemplificativamente: per i lavoratori collocati in mobilità (ex artt. 4 e 24 legge n. 223/1991) o in mobilità lunga (ex art. 7 stessa legge) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; per i lavoratori destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà di settore (art. 2 comma 28 legge n. 662/1996); per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti ai sensi degli artt. 410-412 ter Cod. Proc. Civ. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 siano risultati in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42 comma 5 d.lgs. n. 151/2001).
42. A tali requisiti contributivi non si applica, fino al 31 dicembre 2026, l’adeguamento automatico alla speranza di vita. Dal 1 gennaio 2019, però, il trattamento pensionistico decorre, e quindi il diritto si consegue, trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti (cfr. art. 15, legge n. 26 del 2019).
Per coloro che accedono al pensionamento anticipato prima del compimento di 62 anni di età erano state previste delle penalizzazioni economiche sull’ammontare della pensione (art. 24, comma 10, legge n. 214 del 2011). Tali penalizzazioni sono state eliminate a decorrere dal 1 gennaio 2018 (cfr. art. 1, comma 194, legge n. 232 del 2016). Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 (ai quali si applica integralmente il sistema di calcolo contributivo), la pensione anticipata si può conseguire anche quando si raggiungono 20 anni di anzianità contributiva effettiva, con almeno 63 anni di età (attualmente 64 anni per effetto dell’adeguamento automatico all’incremento della speranza di vita, e dunque, oggi, con 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia), e purché l’importo della pensione sia superiore a 2,8 volte l’assegno sociale (cd. importo soglia), annualmente rivalutato (art. 24, commi 11-13, legge n. 214 del 2011).
43. Tra l’altro, anche la “vecchia” pensione di anzianità introdotta negli anni sessanta del secolo scorso (cfr. n. 209), a seguito di diversi interventi di riforma, era stata già progressivamente trasformata fino a divenire una sorta di pensione di vecchiaia anticipata. Ciò perché, ai fini del conseguimento del diritto, era stata attribuita rilevanza anche all’età anagrafica del lavoratore, oltreché all’anzianità contributiva (cfr. art. 1, commi da 25 a 28, legge n. 335 del 1995; art. 1, comma 6, legge n. 243 del 2004; art. 1, commi 1 e 2, legge n. 247 del 2007).
44. Tale istituto, previsto originariamente dall’art. 1 comma 9 legge 23 agosto 2004, n. 243 per il periodo 2008-2015, permetteva alle lavoratrici di continuare a maturare il diritto alla pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un’età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 anni se lavoratrici autonome, qualora avessero scelto di accedere alla liquidazione della pensione in base al criterio contributivo. Oggi, consente l’accesso alla pensione alle lavoratrici di età non inferiore a 58 anni (o 59, se lavoratrici autonome) con anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che soddisfano i requisiti entro il 31 dicembre 2019 (art. 16 d. l. n. 26/2019 e art. 1, comma 476 legge n. 160/2019).
45. Cfr. d.lgs. n. 67 del 2011; art. 1, commi 206 e 207, legge n. 232 del 2016; art. 1, comma 147 ss., legge n. 205 del 2017.
46. Cfr. art. 1, commi 199-205, legge n. 232 del 2016 e art. 17, legge n. 26 del 2019.
47. Cfr. art. 1, commi 179-186, legge n. 232 del 2016, art. 18, legge n. 26 del 2019 e art. 1, comma 473, legge n. 160 del 2019.
48. La pensione supplementare spetta ai lavoratori già titolari di una pensione quando i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per raggiungere il diritto ad un’altra autonoma prestazione pensionistica. In particolare, l’assicurato iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) che non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma, ha diritto a richiedere una pensione supplementare se risulta titolare di un’altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo. Essa spetta al compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia, qualunque sia il numero dei contributi accreditati presso l’AGO.
49. Cfr. Cass. 27 maggio 2019, n. 14417, secondo cui “deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro”.
50. Specifiche eccezioni sono, ad esempio, previste, per quanto riguarda i titolari di assegno di invalidità, di pensione di invalidità e di pensioni privilegiate ordinarie, che sono assimilabili ai trattamenti d’invalidità in ragione del comune presupposto della menomazione dell’integrità fisica del lavoratore.
51. Art. 19, comma 3, d.l. 25 giugno 2008 n. 112.